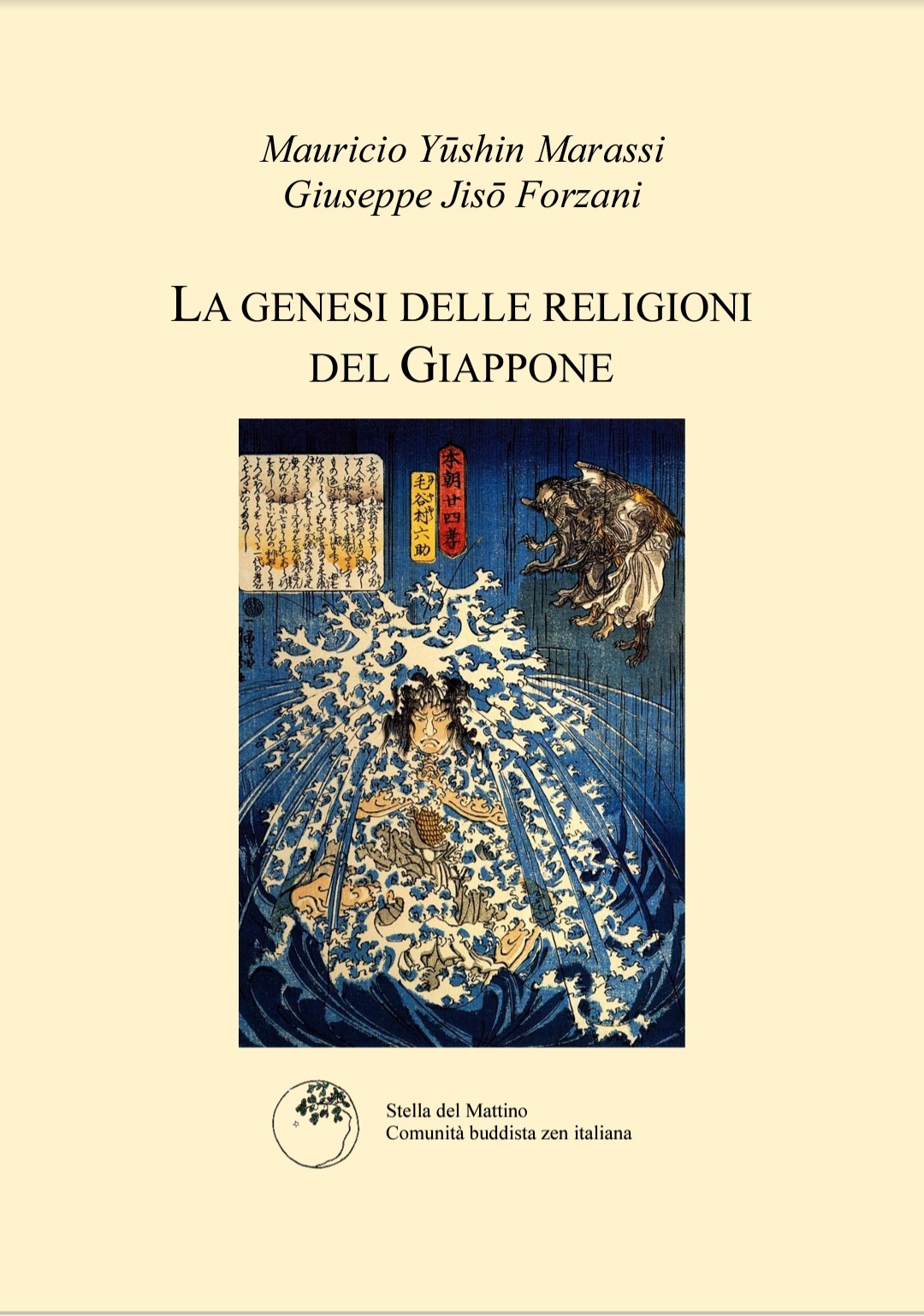* E se un dio non ci venisse a salvare?
Questo scritto di Luigi Alfieri [1] è la prefazione del libro “E se un dio non ci venisse a salvare?” di M.Y.Marassi. Lo proponiamo a distanza di tempo dall’uscita dal libro come un’introduzione e un invito alla lettura.
Il mio incontro con Mauricio Yūshin Marassi, e per suo tramite con Jisō Giuseppe Forzani, è stato, come in fondo ogni incontro, in gran parte casuale. Però, come credo accada sempre negli incontri fortunati, il caso è stato molto aiutato da una sorta di reciproca necessità. In qualche modo, ci stavamo già cercando, eravamo su strade che certo avrebbero potuto benissimo non incrociarsi, ma tendevano comunque verso incroci di questo genere.
Elemento catalizzatore dell’incontro è stato Valeriano Massimi, che qui tengo molto a ringraziare.
Valeriano ha alle spalle seri studi filosofici. Ma è di suo qualcosa di abbastanza diverso: un poeta, un mistico, un esploratore di mondi interiori (bisogna essere molto superficiali per pensare che di mondi interiori ciascuno ne abbia uno soltanto). Ed una piccola parte delle sue ricerche e delle sue scoperte ha coinvolto anche me: prima come professore, poi come amico. Perché anche io, da parte mia, qualcosa stavo cercando.
Da professore quale sono, le mie ricerche non hanno molto di mistico o di poetico. Sono ricerche intellettuali, tentativi non tanto di trovare risposte, quanto di formulare in maniera abbastanza precisa talune domande. Da antropologo culturale dilettante, e filosofo (termine che prego di assumere una volta per tutte nel senso di studioso di filosofia) di professione.
Le domande che da filosofo mi pongo, vertono da vari anni su un problema piuttosto complesso: come fanno ad esistere le identità collettive? Come si generano, come si trasformano, come s’incontrano (e purtroppo spessissimo si scontrano), che rapporto hanno con quella dimensione ancora più complessa e sfuggente che è l’identità individuale (o personale, ma non è la stessa cosa), e come questo rapporto può variare e trasformarsi? Va da sé che in problemi del genere un filosofo rischia assai facilmente di prendere per realtà universali le sue esperienze, le sue fantasie o, nel migliore dei casi, le caratteristiche della sua cultura e del suo tempo. Il rischio diventa, almeno in teoria, più controllabile se il filosofo ha l’occasione, come a me è capitato, di acquisire una certa familiarità con scienze come la sociologia e soprattutto l’antropologia culturale. Non perché di queste scienze o delle scienze in genere ci si possa fidare ciecamente, ma perché si ha la possibilità di usare come strumento d’indagine qualcos’altro oltre a se stessi, i propri maestri e i propri autori. Le scienze, meno individualistiche o personalistiche della filosofia, sono forme di pensiero condiviso, espressione, appunto, di un’identità collettiva: presentano una maggior omogeneità con l’oggetto in esame, ed evitano, sperabilmente, certe distorsioni (senza con questo dare la “verità”; ma c’è bisogno di dirlo?).
Occupandomi da filosofo della politica d’identità collettive, ed avendo imparato qualcosa, se non altro perché la insegno da tempo, d’antropologia culturale, ho avuto modo di rendermi conto meglio di quanto altrimenti avrei potuto che nessun’identità è più forte, assorbente, duratura, ma nello stesso tempo più duttile, più capace d’incontri e di trasformazioni, per quanto non sempre pacifici i primi e non sempre consapevoli le seconde, dell’identità religiosa. Famiglie, stirpi, clan, nazioni ecc. sono identità esclusive: chi è diverso sta fuori, possibilmente lontano, o comunque in una dimensione accuratamente confinata dove non dà fastidio. Ma le identità religiose, quando non sono mere appendici rituali di quelle precedentemente elencate, non ammettono un fuori. Sono di tutti (i puri, i credenti), per tutti (coloro che aprendosi ad accoglierle entrano in un cammino di salvezza), sono totalità di senso che si propongono come soluzione per la totalità degli uomini (ciò vale, s’intende, anche per le religioni politiche, troppo spesso confuse nel vago concetto di “ideologia”, ma questo qui non interessa).
È particolarmente interessante ed importante, dal mio punto di vista, cosa succede quando due o più identità collettive s’incontrano. Quelle esclusive non hanno difficoltà di principio a convivere, purché riescano a stabilire (spesso sanguinosamente) dei precisi confini o una precisa gerarchia. Quando ci riescono, non hanno bisogno di mutare. Quelle universalistiche, inclusive, come le identità religiose, hanno un problema in più. Proprio perché ognuna è totale, nessuna può, in linea di principio, accettare la convivenza con altre, se non negandone la verità. Può tollerarle provvisoriamente come errori in buona fede, come approssimazioni, come versioni peggiorative di se stessa, ma non può ammetterle sul suo stesso piano. O, se lo fa, non può non ridefinire se stessa, ridimensionarsi, trasformarsi. Nessun conflitto, e di questi tempi lo sappiamo bene, può essere più distruttivo di un conflitto tra opposte totalità di senso; ma nessun incontro come quello tra due opposte totalità di senso offre più vaste possibilità di mutamento, fino a cambiare l’idea stessa d’umanità.
Se ci si occupa di questo, l’occasione d’incontrare dei monaci zen italiani appare subito preziosa e non si può lasciarla sfuggire. Come fa un europeo, un occidentale, ad entrare così in profondità in una dimensione tanto remota? Come la vive? Cosa cambia in lui? Cosa il fatto stesso d’incontrarlo può cambiare in noi? La questione è tanto più interessante perché, nel caso di Marassi come in quello di Forzani, siamo lontanissimi da certe mascherature un po’ carnevalesche in cui si rischia d’imbattersi quando si frequentano gli occidentali in qualsiasi modo convertiti all’Oriente. Se un monaco zen italiano fosse uno che vorrebbe essere giapponese o che gioca a fare il giapponese, la cosa sarebbe solo patetica (in qualche caso lo è), ed anche poco interessante, perché a questo punto è molto meglio avere a che fare con giapponesi veri. No, Marassi e Forzani non giocano a fare i giapponesi, ed anche esteriormente non hanno nulla a che fare con quello che ci si aspetterebbe dallo stereotipo del “monaco zen”. Sono due signori seri e tranquilli, molto “normali”. Conoscono il giapponese e gli ideogrammi cinesi, studiano e traducono testi giapponesi e cinesi, hanno vissuto a lungo in Giappone, ogni tanto ci tornano, e vivono quotidianamente le pratiche religiose della scuola Sōtō Zen. Ma sono e restano dei nostri e non dei loro: occidentali, europei, italiani (un po’ più complicato il caso di Marassi, che è italo-argentino). Ed anche come monaci sono assai poco ascetici e ieratici: sono pure sposati e con figli, ulteriore duro colpo allo stereotipo del “monaco zen”.
Ma la cosa davvero interessante, nella faccenda, è proprio questa dimensione di “normalità”. Se avessimo a che fare con persone che vestono abiti esotici, fanno la faccia strana, recitano litanie incomprensibili in lingue remote, e così via, avremmo soltanto la rappresentazione fittizia di un’ovvietà: ci siamo noi, ci sono loro, noi e loro siamo diversi, c’è un confine. Qualcuno di noi, magari, riesce ad andare dall’altra parte, porta indietro qualcosa con cui camuffarsi, e nel fatto stesso di recitare in questo modo il proprio oltrepassamento del confine conferma che un confine c’è, preciso e rassicurante. In fondo, non è successo niente, niente è cambiato. Se invece qualcuno va e torna senza camuffarsi, conservando i suoi abiti, la sua faccia, la sua lingua, le sue abitudini, ma con qualcosa di nuovo, di diverso che lavora dentro di lui al punto di diventare la sua vita, innescando un processo senza fine che nell’etichetta “monaco zen” trova soltanto una semplificazione, grossolana per quanto necessaria, allora è successo qualcosa, qualcosa è cambiato. E la possibilità stessa che un simile cambiamento si dia trascende di molto il mero dato biografico occasionale, il fatto che alcuni signori sono andati in Giappone e sono diventati monaci zen, ma acquista una rilevanza più vasta: l’identità collettiva euro-occidentale (quindi cristiana, necessariamente) e l’identità collettiva sino-giapponese nella particolare forma del buddismo zen possono incontrarsi, possono mescolarsi, e far nascere cose nuove.
Vorrei sottolineare con forza che per quanto mi riguarda il cuore della faccenda non è il buddismo in quanto tale. Non sono buddista, né mi sento sull’orlo della conversione, e non sono neppure uno studioso o un conoscitore del buddismo, sul quale possiedo soltanto le nozioni usuali per una persona colta (dato il mestiere che faccio, è mio dovere professionale definirmi tale, sperando di esserlo davvero). Per me non sarebbe stato molto diverso se invece che monaci zen italiani avessi incontrato imam italiani (e ce ne sono), o qualcos’altro ancora di questo genere. Quello che mi interessa, e ritengo sia interessante oggettivamente, al di là dei gusti personali, e non come curiosità stravagante, ma come anticipazione rivelatrice del nostro probabile ed auspicabile futuro (se un futuro ci sarà), è proprio il nascere di questi ibridi, di questi “mostri” culturali, di queste doppie appartenenze, di queste identità plurali. L’uomo del futuro sarà qualcosa di questo genere (o non sarà).
Per questo con Marassi e con Forzani, con Yūshin e Jisō dovrei forse dire, perché anche la pluralità dei nomi è un segno importante, organizzo da vari anni delle attività culturali: conferenze, seminari, ultimamente un corso integrativo di Antropologia, da cui proprio questo libro trae origine. Lezioni sul buddismo tenute da buddisti che però sono e restano italiani, non si atteggiano a giapponesi di complemento e conservano ben salde tutte le proprie radici culturali originarie, anzitutto le radici cristiane. E l’obiettivo di queste lezioni non è di fare proseliti (se ce ne saranno, sono affari loro), e neanche di diffondere nozioni più precise sul buddismo (sebbene questo non nuoccia), ma proprio di sottoporre agli studenti un’esperienza di vita seriamente e radicalmente vissuta. Si può essere così, si può essere persino così: italo-argentino-giapponesi, cristiano-buddisti, monaci-laici, missionari zen in Occidente, cioè superatori di confini, negatori di confini di professione. In un momento in cui (di nuovo, dopo che tanti di noi si erano illusi che fosse ormai garantito un futuro cosmopolita, semplicemente e universalmente umano) assistiamo (o direttamente partecipiamo) ad una forsennata e invereconda corsa alla moltiplicazione dei confini e delle bandiere, fino al regionalismo, municipalismo, etnicismo più fantasiosi, anzi fino ad aperte, ufficiali, pubbliche, compiaciute dichiarazioni di razzismo da parte di forze di governo, aprire orizzonti diversi mi sembra un dovere scientifico e didattico ineludibile.
Queste non sono (o a me non interessa che siano) lezioni sul buddismo. Sono lezioni sulla trasgressione: ovviamente nel senso etimologico di oltrepassamento, di superamento, di passaggio, appunto, di confini. Ma è giusto riconoscere subito che non è né indifferente né casuale che si parli di buddismo, che siano dei buddisti a parlare: perché sotto questo profilo il buddismo non è una religione come le altre. È l’unica tra le grandi religioni universali che include esplicitamente, consapevolmente, come proprio tratto essenziale, nella propria totalità di senso anche la propria carenza di senso, anche il proprio scacco, sino all’autonegazione. Nelle altre religioni lo fanno, spessissimo, i mistici (tanto cristiani quanto mussulmani quanto ebrei, ecc.), ed anzi questa è probabilmente una delle caratteristiche salienti di ogni mistica. Nel buddismo (eccezion fatta per pochi fanatici, e magari anche per taluni imbecilli che credono che per trovare la verità basti un biglietto d’aereo per destinazioni orientali) ciò è invece essenziale per vivere autenticamente l’esperienza religiosa. Per questo la storia del buddismo è una storia di migrazioni culturali, e forse nessuna religione è più nomade, meno legata a un suolo, a una lingua, a un popolo. Una religione che nasce in India e dall’India scompare, per diventare birmana, siamese, tibetana, cinese, giapponese…, sempre diversa e sempre uguale, intatta nel suo continuo mutare pelle. Ora, da non molti anni, il buddismo, i diversi buddismi sviluppatisi separatamente gli uni dagli altri, arrivano in occidente, s’incontrano tra loro e reciprocamente si scoprono, e diventano Occidente. È questo il punto essenziale della questione, di cui tanto Marassi quanto Forzani hanno ed esprimono una precisa, limpida consapevolezza. Il buddismo non è una religione “orientale”. Non deve parlare per forza il sanscrito o il giapponese. Non ha nulla di pittorescamente esotico che le sia essenziale. Non deve per forza indossare tonache gialle o arancioni (né deve indossare tonache, in generale). Non ha verità dottrinali irrinunciabili, e non è neppure legata indissolubilmente alla persona del suo fondatore storico. Può prescindere (quasi) da tutto, può accogliere (quasi) tutto. Ha una sottile, raffinata, virtuosistica capacità di affermarsi nella propria negazione. Si è sempre trasformato, ed ora si sta trasformando di nuovo, sotto i nostri occhi. Sta diventando nostro: non importa se è un fenomeno minoritario, e, pur in crescita continua, minoritario probabilmente resterà. Nel trasformarsi, sta trasformando anche noi. In futuro, i più tra noi continueranno a dirsi cristiani, o a dirsi atei, ma saranno diventati, in entrambi i casi, un po’ buddisti. Un po’ altri. Un po’ diversi. Un po’ più aperti. Un po’ meno irrigiditi nel culto di vitelli d’oro di qualunque risma.
Questo libro, le lezioni da cui nasce, il progetto culturale in cui è inserito, i rapporti umani che in tutto questo sono anche casualmente coinvolti, mi pare trovino il loro senso principale nell’essere un tentativo d’incontro, di fusione (di con-fusione, sarei tentato di dire) di appartenenze e di linguaggi, un salutare esercizio di distacco ironico dalle identità troppo fisse, troppo ovvie, troppo obbligate. Avere il coraggio di diventare altro, attraversando la necessaria dimensione del non essere nulla, non è solo l’ineffabile esperienza dei mistici di tutte le religioni (e in qualche modo la base minima per potersi dire buddisti). È anche sempre, in qualche modo, l’esperienza che ogni uomo libero vive della propria libertà. Può essere scomodo, ma non è per niente sgradevole; ed è bene dirlo, specialmente agli studenti.
In questo spirito, raccomando il libro al lettore.

[1] Ordinario di Filosofia politica, docente di Antropologia culturale e Antropologia delle religioni, Presidente del Corso di laurea specialistica in Antropologia ed Epistemologia delle religioni, facoltà di Sociologia, Università “Carlo Bo” di Urbino.
Se volete, lasciate un commento.
You must be logged in to post a comment.