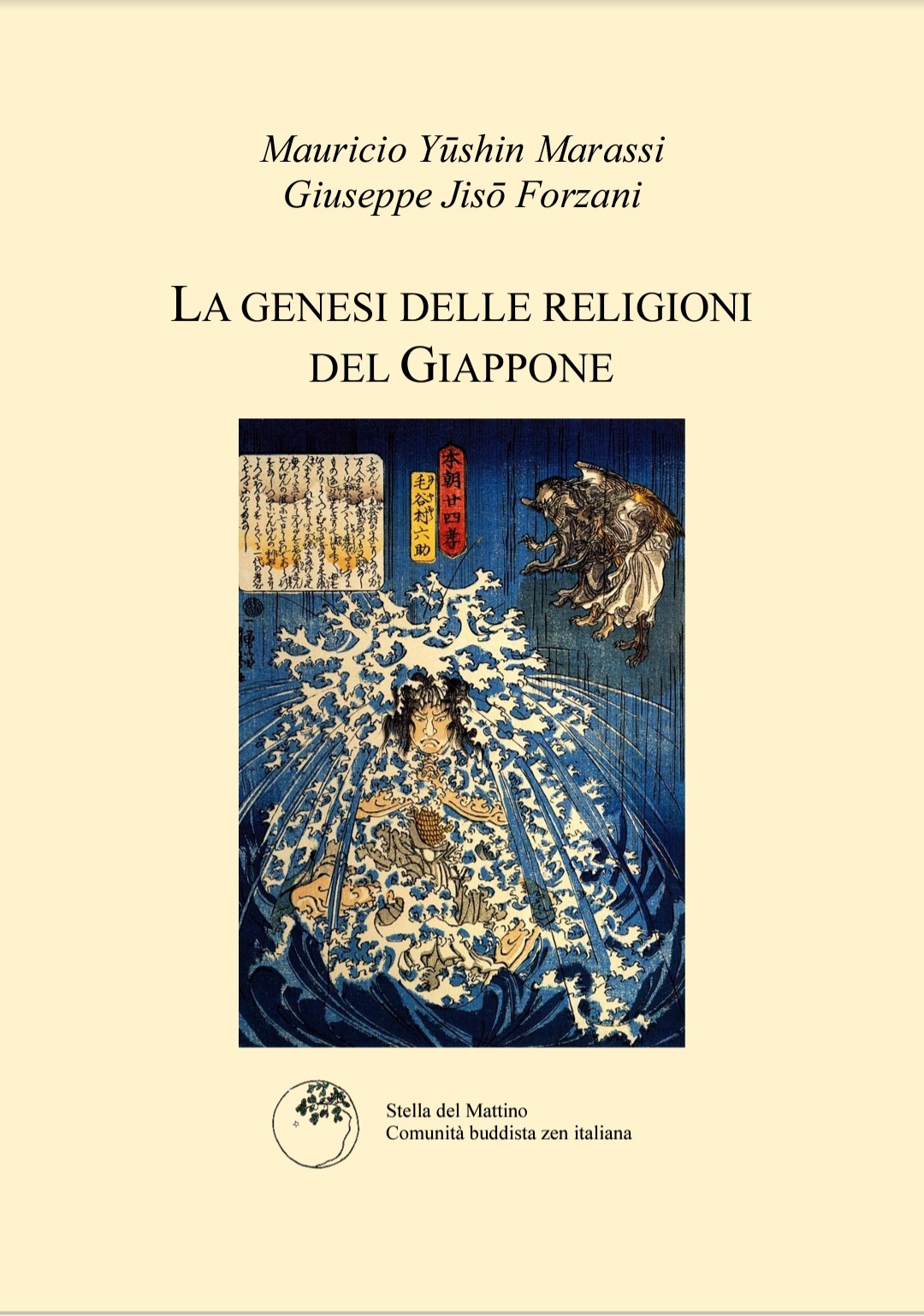Il paradiso dei senza legge
Fu nel giugno del 1973, mentre mi trovavo nel nord dell’India, la prima volta in cui qualcuno mi parlò dello Zen, dal suo “interno”. Un giovane australiano che da alcuni anni praticava il Rinzai Zen mi assicurò che era la soluzione ad ogni mio problema. Mi disse, o così volli capire, che nello Zen vi è una pratica che libera lo spirito e che assieme agli insegnamenti che vi stanno attorno trasforma l’uomo permettendogli di svilupparsi pienamente, privo dai condizionamenti della famiglia e della cultura, senza alcun obbligo ed alcuna legge da seguire.
Dopo il “grande disastro” del Sessantotto ero partito alla volta dell’India sperando di trovarvi Vera Conoscenza, accompagnato da un poco di scetticismo ma anche confusamente persuaso che quel partire permettesse di lasciare a casa il me stesso di ogni giorno, con tutti i rovelli, le incertezze, le meschinità, per scoprirne un altro libero e sereno, tra profumi di incenso e note di sitar, da riportare a casa al posto di “me”. Una dolce illusione che il viaggiare di quei tempi assecondava: non vi erano guerre lungo tutta la lunga strada per l’Oriente e quei luoghi ancora scarsamente svelati dai media serbavano intatto il senso -forse un poco infantile, salgariano- dell’ignoto, così la lentezza del viaggio via terra favoriva la sensazione di penetrare sempre più a fondo in un altrove magico e reale dove tutto era possibile. Ogni giorno era motivo di meraviglia e l’incanto riempiva cuore e mente scacciando in qualche angolo ogni ricordo di me, ed assieme ai ricordi ogni malinconia. Purtroppo non colsi il senso profondo, il piccolo seme di libertà di questa esperienza dell’illusorietà di ciò che pensavo essere la (mia) vita e mi limitai a farmi riempire di “novità”: come vino nuovo in un vecchio tino.
Così come ogni cosa, anche quel viaggio terminò ma, diversamente da altre volte, il ritorno alla mia vita precedente non dissolse subito il sogno di raggiunta libertà; nutrita dagli incontri col mistero dell’India la nuova fantasia che già chiamavo Zen mantenne lo spirito come su una nuvola, mentre sotto di me scorreva la realtà “normale”. Che a mano a mano si avvicinava per risucchiarmi nelle angustie del quotidiano.
[…]
Libertà dolorosa
Vi è un tipo di dolore, sconosciuto a chi non ha provato a morire in vita, che si genera nel processo: è come se la vita delle abitudini, del fabbricare una identità immaginata ed in essa abitare avesse volontà di sopravvivenza, non volesse lasciarsi scompaginare e disintegrare nelle lunghe ore di zazen quando non vi è altro da fare che sopportare il dolore alle gambe e lasciar scorrere via tutti i pensieri. I giorni in un eremo -questo era Antaiji- si susseguono pieni di attività e difficoltà da affrontare in un continuum temporale scandito solo dagli orari interni ma, nel frattempo, l’immaginazione mantiene viva per anni l’idea che fuori, dove lo abbiamo lasciato, ci sia il mondo dove eravamo qualcuno, seppure un qualcuno dappoco, avevamo famiglia, amici, risate, tristezze. Quella vita, ogni vita, non vuol morire e scalcia dentro di noi per essere salvata, vissuta.
Poi, col trascorrere del tempo, il ritmo vitale inizialmente quasi proibitivo diventa il passo normale e, a poco a poco, il mondo scompare lontano, il qui ed ora di una vita apparentemente banale riempie e svuota senza interruzioni. L’eccezionalità della vita monastica non è negli orari impossibili, nella fatica immane dei giorni dei lunghi ritiri: più che giorni una fila ininterrotta di zazen dal cuore della notte fino a sera. Non sta neppure nel vivere su un monte isolato, sepolti da due tre metri di neve, è una eccezionalità invisibile, giù nelle profondità che sostengono un trascorrere altrimenti indesiderabile. Come è indesiderabile la marginalità di una vicenda dove non vi è carriera né mete da raggiungere, dove la fatica si applica allo stare semplicemente lì, sconosciuti e soli, mentre si è coscienti che nulla ci trattiene: ogni istante è quello nel quale si potrebbe andar via.
[…]
Ma poi c’è il resto del tempo, durante il quale siamo uomini, donne normali, dove (quasi) ogni istante richiede una scelta che, di fatto, favorisce questo o tralascia quello. È giusto accettare quel lavoro? È bene frequentare/non frequentare quella persona? Posso dire questo? Posso negare quello? I miei figli, come devono essere educati, su quali principi, in base a quali valori? È giusto votare quel partito? O non votare? Faccio bene a donare a chi mi chiede o salvo il salvabile per la mia famiglia? Sino a che punto salvo sino a che punto dono? Ha senso parlare di amore? Ha senso, è bene, è male amare i miei “cari”? Come gli “altri”? Di meno?
E poi i progetti di vita: posso mirare ad aumentare il mio benessere, quello di chi dipende dai miei atti? Non è forse che, ciò di cui mi approprio -per me, per i “miei”- è di fatto tolto, negato a tutti gli altri? Posso fumare sapendo che nuoce alla mia ed alla altrui salute? E bere una bottiglia di vino con gli amici? Fare sesso con una persona, adulta, consenziente, senza legami? Comprare un’auto nuova mentre la vecchia cammina ancora, avere più indumenti dello stretto necessario? Privare della mia presenza chi ne ha bisogno per dedicare il tempo allo zazen oppure rinunciare allo zazen per trascorrere il tempo con mio figlio? Negarsi ad ogni invito costringendo mia moglie al vuoto di relazioni famigliari oppure accettare e trascorrere le ore nel nulla delle chiacchiere?
E poi la forma della vita: chi sono, un monaco zen o una persona qualunque la cui vita non ha nessuna forma particolare? Vesto la veste qualche volta? Mai? Sempre? Solo dentro di me? Per i miei studenti devo essere professore, per chi domanda lo zazen un riferimento affidabile, per i miei lettori scrittore, marito per mia moglie e padre per mia figlia, quale di questi ruoli è quello vero? Tutti? Nessuno? Sono un uomo e basta, un uomo senza qualità? Sono qualcuno in particolare?
In realtà, come è normale che sia, non so chi sono, “che cosa” sono, se “tutto questo” sia un sogno e se davvero appartengo a una certa forma. Zhuangzi sognò di essere una farfalla che svolazzava felice, ignara di essere Zhuangzi. Poi si svegliò e non sapeva se era Zhuangzi che aveva sognato una farfalla o una farfalla che stava sognando di essere Zhuangzi.
Se volete, lasciate un commento.
You must be logged in to post a comment.