In merito all’articolo “Alla scoperta della via maestra”, a firma Carlo Di Folca, apparso sul numero 21 di Dharma dedicato al libro La via maestra, edito da Marietti nel 2005
* L’autore risponde
Su di un “punto” non mi trovo d’accordo con quanto sostenuto da Di Folca, che ringrazio per l’attenzione e l’affetto che ha voluto dedicare al mio lavoro. La critica all’affermazione per cui è “autonomia l’obiettivo” che compare a p. 95 del libretto citato e che costituirebbe “musica alle orecchie dell’orgoglioso”, a mio parere non tiene conto né del contesto né del senso profondo. Il contesto è mostrare l’assurdità di una relazione pretesa liberante ma che, invece, crea dipendenza, per cui “autonomia” è correlativo a “dipendenza”. Il senso profondo è che “autonomia” corrisponde a “prendere rifugio in sé stessi” di cui altrove nel testo (p.130).
Quel rifugio/direzione, che non è meta statica, è il massimo di autonomia, dopo essermi spogliato anche di orgoglio, umiltà ecc. Il disguido si completa nelle parole successive, quando il recensore distingue verticalmente (e non dialetticamente) tra “pratica” e “risultato”: tra i più classici “nondue” di ogni tradizione buddista.
Riguardo al resto, anche se si poteva essere un poco più ariosi, meno accanitamente avvinti ad un solo tema, mi trovo sostanzialmente d’accordo con Di Folca, e in particolare sull’assunto che: «Bisogna maneggiare l’orgoglio con molta cura, con grande delicatezza, perché ogni veemenza farà inevitabilmente assurgere il denunciante a nuovo modello». Sono così d’accordo che mi sono stupito del suo affermare «l’universalità dell’orgoglio», o che esso sia, addirittura, «l’essenza del problema fondamentale dell’uomo». L’esaltazione di Lucifero –certo per combatterlo ma così resuscitandolo in colui che lo combatte- è il cavallo di battaglia di tanti agitati predicatori cattolicii; nel libro, che ho inteso inserire in atmosfera buddista, ho trascurato di rendere completo omaggio a tanto idolo; e anche in questo concordo con Di Folca, anche se, forse, per motivi opposti.
Non l’ho nominato, nonostante Lucifero -letteralmente: il “portatore di luce”- mi sia alquanto simpatico. Chissà, un giorno qualcuno dedicherà un poco di tempo al Lucifero buddista, che usa sé stesso come lampada che illumina il cammino, paga in prima persona per i propri errori, offre aiuto a chi vuole seguire la stessa strada, e per il resto non rompe le sc… a nessuno. Un grande.
Infine, per nobilitare un poco il discorso, una reminiscenza dotta: il limite del mostrare (anche nel dire) è splendidamente dipinto nel Sutra del Diamante, dove si riconosce la possibilità che possa esistere un segno “buono”, positivo: quello della non esibizione dei “segni”. Ma, quanto al resto, “parlare è profanare” e saggiamente Qualcuno non ha detto “neppure una parola”; quando ci azzarderemo su quel terreno, speriamo che ci sarà sempre chi, compassionevole, ce lo ricorderà.
Mauricio Y. Marassi
«Il peccato di orgoglio, il pensiero colpevole concepito per un istante: non serviam: non servirò. Quell’istante fu la sua rovina. Egli offese la maestà di Dio con il pensiero colpevole di un istante e Dio lo cacciò per sempre dal cielo, nell’inferno!», cfr. James Joyce, Ritratto dell’artista da giovane, Newton, Roma 1995, 112.
No Responses to “L’autore risponde”
Se volete, lasciate un commento.
You must be logged in to post a comment.

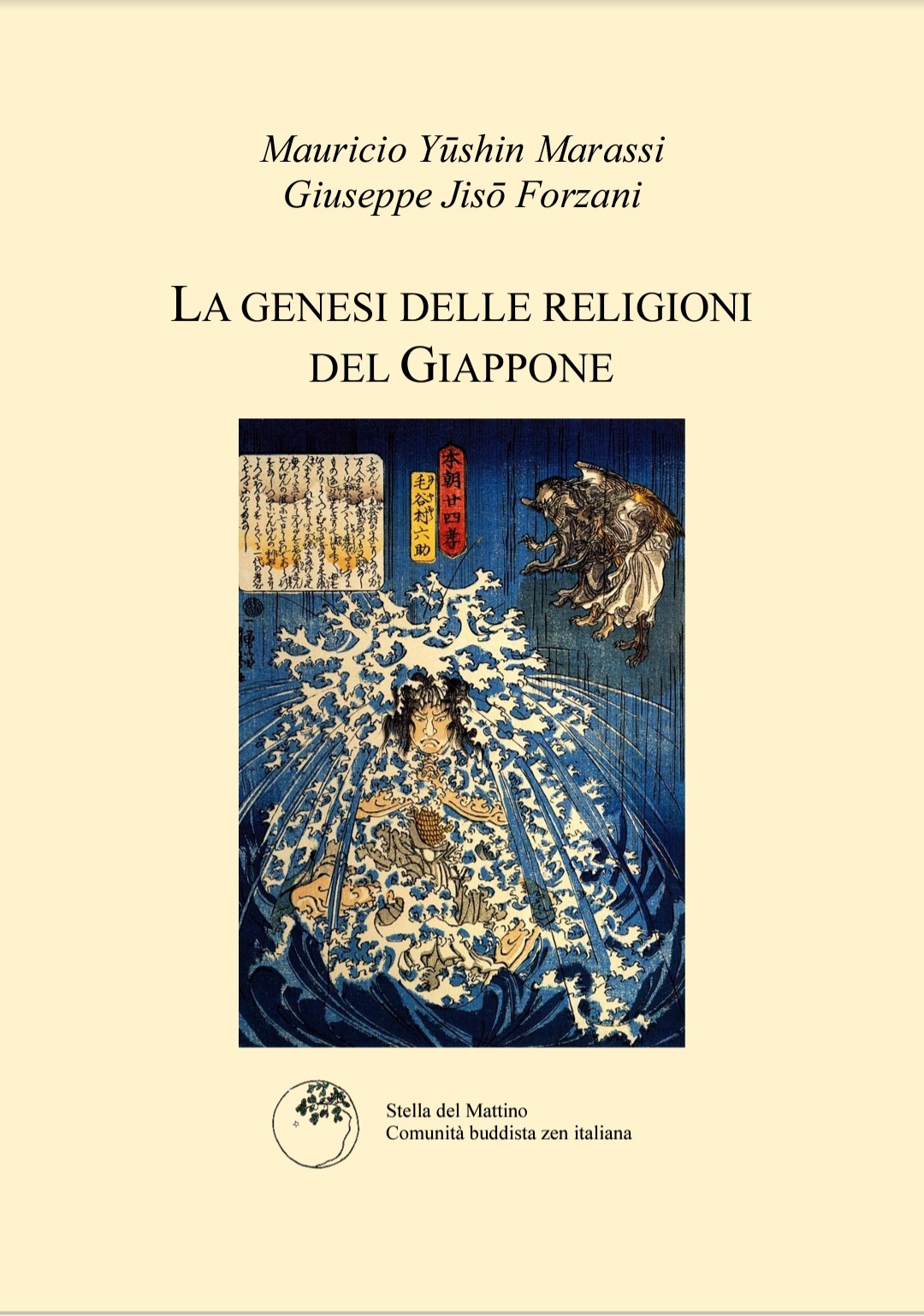






Marzo 20th, 2006 at 11:29 am
Riflessioni sulla risposta di Mauricio Y. Marassi al mio articolo Alla scoperta della via maestra.
Credo che la risposta di Mauricio Y. Marassi alla mia recensione de La via maestra contenga alcuni spunti rilevanti e meritevoli di una analisi più approfondita. L’accolgo, dunque, come un’occasione per chiarire meglio il tipo di riflessione che da tempo sto conducendo sul buddhismo e che hanno fatto da sfondo alle considerazioni da me proposte nella citata recensione.
Su di un punto, tuttavia, mi sembra opportuno replicare esplicitamente: trovo perlomeno contraddittorio attribuirmi l’attitudine di combattere “Lucifero”, così resuscitandolo, proprio mentre viene condivisa la mia affermazione che “bisogna maneggiare l’orgoglio con molta cura, con grande delicatezza”. Mi sembra piuttosto evidente che quella cura e quella delicatezza traducono proprio l’atteggiamento di non contrapposizione caldeggiato dallo stesso Marassi, e non vedo proprio come esso possa essere trasformato in bellicoso per il semplice fatto che considero l’orgoglio universale e “l’essenza del problema fondamentale dell’uomo”. Che l’uomo navighi in acque perigliose in ragione di un suo “problema” esistenziale fondamentale è addirittura il predicato delle prime due Nobili Verità del buddhismo, e da ciò non consegue alcuna automatica definizione dei contenuti e della modalità della cura. Per quello che mi riguarda, anni di pratica nella vipassana mi hanno insegnato che l’unico modo per accostarsi a ciò che viene avvertito come un problema esistenziale è esserne consapevoli, accoglierlo in modo equanime e lasciare che sia, così com’è, osservando ciò che accade nel nostro corpo-mente e, nel caso, rendendo oggetto di consapevolezza anche l’attitudine della mente a volersene sbarazzare. La mia concezione dell’orgoglio è perfettamente coerente con questo atteggiamento fondamentale.
Il fatto è che io, a differenza di Marassi, non trovo affatto “alquanto simpatico” Lucifero, e la ragione potrà apparire paradossale solo se non si è compreso il senso della mia argomentazione: perché non credo per nulla alla sua esistenza – e, a fortiori, al suo “illuminare il cammino”. Al di là dell’ironia che pervade le considerazioni di Marassi sul “portatore di luce”, io ritengo che sia questo il punto in cui si rivela la sostanziale diversità fra le nostre due impostazioni, e che a mio parere non è affatto irrilevante, perché concerne la diagnosi della causa di dukkha, ossia, nientedimeno, che la seconda Nobile Verità..
Non c’è dubbio che la mia convinzione che sia l’orgoglio, e non l’ignoranza o il desiderio, alla radice di dukkha è debitrice del cristianesimo, ma in un senso affatto diverso da quello che conduce i “tanti agitati predicatori cattolici” di cui parla Marassi a redarguire un’umanità in preda al peccato. Per me – ma chiunque avesse l’interesse e la pazienza necessaria potrà constatare che la mia interpretazione corrisponde esattamente sia al testo biblico, sia a quanto affermato da molti Padri della Chiesa – l’orgoglio, che non ha nulla a che vedere con la presunzione, di cui è invece la perfetta antitesi, si sostanzia nel rifiuto della propria vulnerabilità, impermanenza e dipendenza, che spinge all’emulazione di un modello di perfezione, ritenuto incarnare le qualità ambite dell’autonomia, dell’autosufficienza e del potere. Già da questa breve descrizione appare evidente la compatibilità dell’orgoglio, inteso in questo modo, con l’affermazione buddhista che a generare tutta la sofferenza dell’uomo è la brama di possedere un io autonomo ed autosufficiente.
In questo senso, Lucifero – o, più correttamente, Satan (letteralmente “l’accusatore”, per cui ad “accusare”, a combattere Satana si diventa come lui), ossia ciò che diventa l’angelo più luminoso dopo una caduta determinata proprio dall’orgoglio: “Tu dicevi in cuor tuo: Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio…, sarò simile all’Altissimo” (Is. 14:12-14) – è il simbolo di questa attitudine tipicamente umana, perché descrive il processo per cui, l’ambizione a divenire “come Dio” (Gen. 3:5), porta di fatto alla negazione del proprio semplice esistere, così come si è e, in nome dell’acquisizione di un’autonomia assoluta e divina, proprio perché nega l’essere in nome di un fantasticato dover essere, in realtà porta alla “caduta”, trascina verso il basso, fino all’autodistruzione.
So bene che il termine di “autonomia” è sempre “correlativo a ‘dipendenza’”, ma proprio questo è il problema di ogni orgoglioso: sa di essere dipendente dal maestro-modello e vuole diventare come quello s’immagina che sia, autonomo ed autosufficiente. Il paradosso dell’orgoglio è che si coltiva una dipendenza col fine ultimo di divenire infine totalmente in-dipendenti. Naturalmente l’orgoglioso si vergogna della sua attuale dipendenza per cui, in genere, o la dissimula accuratamente, pretendendo di essere già autonomo nel proprio giudicare e scegliere, oppure denuncia solo modelli nobili e approvati culturalmente (come un “maestro” zen). E’ anche vero che tutto ciò è paradossale, perché mostra “l’assurdità di una relazione pretesa liberante ma che, invece, crea dipendenza”, ma questa assurdità è proprio il gioco dell’orgoglio, la satanica e sottile omeopatia del voler sacralizzare se stessi coltivando una dipendenza che liberi da ogni dipendenza. In questo senso più profondo, dunque, l’autonomia non è il contrario della dipendenza, perché il binomio autonomia-dipendenza è tutto interno alla logica dell’orgoglio, ne rappresenta la più autentica sostanza. In questo contesto, chiunque si faccia paladino dell’autonomia e possegga una certa autorevolezza, diviene automaticamente un candidato a rivestire il ruolo di modello agli occhi dell’orgoglioso, perché quell’autonomia è, ripeto, proprio ciò che, emulandolo, il discepolo ambisce ad acquisire.
E a nulla giova ricordare che l’autonomia “corrisponde a ‘prendere rifugio in se stessi’”, perché quel “prendere rifugio” non avviene nel vuoto esistenziale, non determina automaticamente la liberazione dalla vocazione a sbarazzarsi della propria vulnerabilità in nome di un modello di perfezione. Al contrario, finché l’orgoglio non viene dissepolto e reso consapevole, è la pratica che viene messa al servizio delle sue mire, e l’insegnante-maestro diviene il nuovo modello di perfezione, più o meno occultato dalla parola d’ordine – rassicurante per l’orgoglio – di “prendere rifugio in se stessi”. Va rilevato, infatti, che la dinamica maestro-discepolo, così acutamente svelata e descritta da Marassi nel suo libro, non è una caratteristica tipica dello zen occidentale ma, per limitarmi a un esempio di cui ho esperienza diretta, si ritrova anche nella vipassana, in forma più sottile ma anche più invasiva e difficile da riconoscere, perché s’instaura proprio laddove vi è la minore enfasi possibile sulla figura dell’insegnante, definito quale semplice “amico spirituale” (kalyanamitta). E proprio la tradizione Theravada, col suo mettere al centro la pratica meditativa, il “prendere rifugio in se stessi”, rappresenta una riprova estremamente pregnante della pervasività dell’orgoglio. Il quale, giova precisarlo, non è un’attitudine della mente rozza e mondana, ma propriamente religiosa, è l’essenza del religioso tradizionale (mi si consenta, in questa sede, questa semplificazione), perché si sostanzia nello sforzo di trasformare se stessi applicando diligentemente i dettami – etici, rituali, sacramentali o meditativi – propri di una qualche via religiosa. Va da sé che quei dettami sono sempre veicolati da una persona in carne ed ossa, comunque lo si chiami: maestro, insegnante, amico, guida spirituale.
L’orgoglio, dunque, è un’attitudine esistenziale e non morale e, in via di principio, addirittura incompatibile col “peccato” (l’errore), perché si nutre proprio dello sforzo di emendarsi da ogni imperfezione o traccia di vulnerabilità e, dunque, anche dalla vulnerabilità all’errore. Il “peccatore” e l’orgoglioso sono due tipi radicalmente diversi: il primo sa di non rispettare le regole della propria religione e non si erige a giudice di nessuno, mentre è l’orgoglioso che è predisposto a divenire un “agitato predicatore”, perché ha un senso abnorme e paradossale dell’errore (o del peccato), trasfigurato in ambiguo segnale lungo la via: da un lato è ciò che testimonia della distanza dall’ideale perseguito; dall’altro è ciò su cui occorre lavorare, che bisogna “combattere”, in sé e negli altri, al fine di addivenire alla perfezione. Al contrario, la consapevolezza dell’orgoglio, essendo inscindibile dall’accettazione della vulnerabilità, genera uno sguardo compassionevole sulla propria e altrui fallibilità, vede nell’errore o nel peccato niente di più che l’inevitabile conseguenza di essere creature limitate, né onnipotenti né onniscienti, insicure ed esposte alla prevaricazione in difesa del proprio piccolo, fragile, impermanente e tuttavia prezioso io. Proprio quello sguardo di cui sono incapaci i “tanti agitati predicatori cattolici”, che solitamente censurano moralisticamente le umane debolezze in nome di principi assoluti di cui, naturalmente, si ritengono i più autentici interpreti, e per i quali sovente chiamano a raccolta battaglioni armati fino ai denti.
Ma anche costoro vanno compatiti e non giudicati, e tanto meno si può ironizzare sul loro comportamento, perché rivelano, con la loro intransigenza, la lacerazione interiore che li devasta e che consegue dal continuo giudizio di conformità fra ciò che sono e ciò che vorrebbero, o pretendono, essere. Nell’ergersi a modelli, mostrano di aver lungamente logorato ed isterilito se stessi nella diuturna opera di emulazione del loro ideale, e di pretendere che tutti combattano la medesima battaglia contro la loro stessa umanità.
In questo quadro, l’unico modo per aiutare l’orgoglioso è mostrargli (o meglio, suggerire una via che gli consenta di vedere in se stesso all’opera) questo gioco perverso e assurdo, che produce solo la proroga e l’intensificarsi di una dipendenza auto-distruttiva e generatrice di sofferenza. Consapevolezza che apre non all’autonomia, ma alla serena accettazione dell’universale ed irrimediabile interdipendenza, nel bene come nel male, nella bontà e nell’errore, nell’orgoglio come nell’umiltà. Tutta la storia umana può essere letta con la chiave della lotta contro la nostra vulnerabilità. I sogni di immortalità, di potere, di fama, di successo, di ricchezza, di bellezza imperitura e così via altro non sono che traduzione della fuga dalla condizione fragile e insicura che irrimediabilmente ci appartiene, talmente imprevedibile che “perfino” da un pervicace orgoglioso ci si può aspettare un po’ di luce. Ma non in quanto tale, piuttosto perché, nel suo rivelare, pagandone lo scotto sulla sua pelle, la sfrenata ambizione alla sacralizzazione, può apprendere e diffondere un po’ di compassione e di saggezza.
Ha ragione Marassi, nel ricordare il Sutra del Diamante, ad affermare che il segno “buono” è “quello della non esibizione dei non segni”. Ma, “quanto al resto”, il parlare che è profanare riguarda solo la pretesa di comprendere e di enunciare la verità, di afferrare la vita – ambizione che, non casualmente, caratterizza sempre coloro i quali finiscono per divenire dei modelli. Ma c’è un parlare che non profana, ed è quello che ci aiuta a comprendere il nostro errare, ciò che turba ed agita il nostro cuore-mente (citta), e che può sostenere con una conoscenza più adeguata delle proprie difficoltà l’investigazione pratica, consapevole e accogliente di sé (come ben mostra la sequenza circolare e sinergica dei fattori dell’Ottuplice sentiero, dove la retta visione “precede” i fattori più propriamente pratici, per esserne, poi, a sua volta nutrita e trasformata). Invece, il ritenere che, in nome dei “nondue” buddhisti, questo “prendere rifugio in se stessi” che costituisce il nucleo della pratica sia, sempre e comunque, inscindibile dal “risultato”, per cui non se ne possa parlare cercando di comprendere i termini ed il contesto esistenziale in cui inevitabilmente la pratica viene accolta, non nobilita il discorso in dialettico ma, se si vuol essere realmente conseguenti, consegna solo al silenzio assoluto.
Carlo Di Folca
Marzo 20th, 2006 at 8:30 pm
De hoc satis?
Larga la foglia …
mym