La comunicazione mediale nel buddismo:
Le immagini della realtà e la realtà delle immagini.
Un chilo è pesante o è leggero?
Se qualcuno vuole capire, afferrare che cosa pensano “i buddisti” di una certa cosa (per esempio della storia, del cinema, del ruolo della donna…), o come si comportano rispetto ad una data situazione complessa (l’amore, il sesso, la politica), oppure quale sia il loro approccio cognitivo nei confronti della fede, della religiosità, della filosofia o della psicologia… O che tipo di rapporto abbiano con le altre religioni o che cosa pensino del cristianesimo, occorre contestualizzare.
In pratica bisogna decidere “chi” dovrebbe rispondere e quando: cioè se ci rivolgiamo a un buddista indiano del quarto secolo avanti cristo. A un buddista giapponese dei nostri giorni. A un birmano di mille anni fa. A me, ovvero a un buddista di cultura cattolica, italiana, del XXI secolo. Con ogni probabilità ognuno risponderebbe, in modo estremamente diverso a ciascuna di quelle domande e laddove le risposte combaciassero ben difficilmente si potrebbe farne risalire il motivo alla comune appartenenza religiosa.
Il motivo è molto chiaro: i buddisti non sono una categoria antropologica speciale. Non si può parlare di loro in blocco.
Anche se l’indicazione di base è chiara, e con le parole del Dhammapada la possiamo esprimere con: “Si deve essere rapidi nel bene, dal male si deve ritrarre la mente! Infatti, se un uomo compie il bene in ritardo, la sua mente si diletta nel male”[1] tuttavia, sin dall’antichità, secondo il buddismo bene e male non hanno una collocazione dogmatica. Vi sono momenti mondani che è bene vivere e in altre circostanze -temporali, culturali…- i medesimi comportamenti sono sconsigliati.
A volte mi si chiede se “nel buddismo” vi sia il problema del maschilismo: il buddismo si è diffuso particolarmente nei Paesi dell’Estremo Oriente che da molto tempo hanno una cultura che secondo il punto di vista corrente potremmo dire maschilista. Ora che si sta diffondendo in Occidente penso si possa dire che la media dei buddisti occidentali è meno maschilista della media dei loro colleghi cristiani. Questo perché il buddismo ha preso piede soprattutto nelle aree culturali progressiste della società occidentale.
Così mentre lo guardiamo, ecco che il buddismo scompare, ci appare ri-velato dalla cultura nel quale vive, mai con una fisionomia a sé stante. Sembrerebbe essere un recipiente vuoto.
In un senso è certamente vero che sia un recipiente vuoto, ma se fosse letteralmente così il buddismo sarebbe una tecnica dialettica, una forma di criticismo a 360 gradi oscillante tra lo scetticismo ed il nichilismo.
Il punto focale da cui tutto si origina va identificato nel momento in cui Sakyamuni, diviene il Buddha, il “Risvegliato” oppure “Colui-che-ha-compreso” secondo un’altra scelta traduttiva della parola buddha. Chiariamo che non è un risveglio “da” con il conseguente uscire da tutti i sogni per entrare in una sorta di realtà vera priva di sogni e illusioni, diversa da quella che ciascuno di noi vive. E neppure buddha è “colui che ha compreso qualche cosa”, il contenuto di un pensiero di tipo concettuale o discorsivo o una concatenazione logica: questo sarebbe facilmente enunciabile e definibile proprio perché nel momento in cui “qualcosa” è concepita come pensiero lo è già in una forma riproducibile alla portata di altre menti.
Il primo fatto che occorre notare è che prima, dopo e soprattutto “in quel momento” il Buddha era seduto. Non passeggiava assorto per il bosco, non era concentrato nella lettura di un testo sapienziale.
Quello star seduto è il punto culminante della tradizione precedente, proprio dove questa passa il testimone al futuro: il risveglio avviene all’interno della forma base dello Yoga/Dhyana che poi sarà Chan/Zen/Zazen… ovvero la forma della meditazione seduta.
E questo star seduti non è al modo delle tradizioni che lo avevano prodotto, ossia una tecnica per realizzare qualche cosa: la conoscenza, la libertà dal dolore, la purificazione… ma è già la forma del risveglio.
Sul finire della notte, all’impallidire della Stella del Mattino si compie l’identificazione tra 1) colui che siede, 2) lo star seduti e 3) il risveglio.
Abbiamo accennato alla forma del risveglio, vediamo ora qualche cosa riguardo al “contenuto” intendendo con ciò non tanto il gusto ovvero ciò che non si può trasmettere, dell’esperienza vissuta dal Buddha: quello è scomparso con lui e si rinnova ogni qualvolta qualcuno entra nella via. Ci riferiamo alla sua rappresentazione simbolica, ovvero una narrazione in termini trasmettibili agli altri uomini.
Ricorrendo alla tradizione, su questo punto univoca sia nelle sue articolazioni nazionali che nello sviluppo temporale, a livello di contenuti l’apporto originale del Buddha alla religiosità universale consiste nella completa penetrazione di pratityasamutpada, la visuale del vuoto e dell’impermanenza che da quel vuoto deriva, che è di fatto l’elaborazione dinamica (nel tempo) e articolata (nello spazio) di “anatman”, ovvero la negazione dell’assunto base della religione vedico-bramanica, negazione dell’esistenza di un fondamento, un sé individuale, eterno, immutabile, dotato di vita propria.
In termini simbolici, da pratityasamutpada si origina quella che generalmente viene considerata la cultura buddista: il Cammino di Mezzo, le Quattro Nobili Verità, l’Ottuplice sentiero.
Da essa nascono tutti i sutta del Canone Pali, e poi via via la Madhyamaka o Madhyamika di Nagarjuna, la scuola Yogacara, il tantrismo vajrayana, le scuole cinesi Chan e Tiantai, lo Zen giapponese, vietnamita e coreano.
In tutta la storia del Buddismo solo un altro elemento si aggiunge -meglio: si esplicita- accanto a pratityasamutpada: è l’atteggiamento benevolente, amorevole e sereno, senza scopo né interesse, verso ogni creatura mahakaruna (ahimsa, maitri, mudita) [2].
Così, parafrasando Aryadeva, discepolo di Nagarjuna, l’intero buddismo esprimibile si può riassumere in due elementi: esperienza-consapevolezza del vuoto-impermanenza e amore fraterno.
Assieme al “sedersi nella quiete”[3] del Buddha, questa piccola dotazione è sufficiente a realizzare tutti gli obiettivi gnostici e pragmatici che si propone il buddismo ovvero, nelle parole del Discorso della messa in moto della ruota del dhamma di fornire: «Una via chiara, luminosa ed intelligibile, una via sapiente che conduce alla pace, alla conoscenza, all’illuminazione, al nirvana»[4].
Ma quella stessa piccola attrezzatura si rivela insufficiente a soddisfare l’esigenza di fare, capire, credere, congetturare, venerare che accompagna l’animo umano volto alla conversione.
In tutta la storia del buddismo vi è stata solamente la scuola indiana Yogacara/Vijñanavada[5] nata nel quarto secolo, a farsi carico di parte dell’esigenza di soddisfare l’intelletto dell’uomo di religione. Prima, dopo, altrove rispetto agli espedienti parametafisici proposti da questa scuola, queste funzioni sono state e sono assolte dalle culture religiose ospitanti.
Così ogni buddismo, a seconda della famiglia culturale nel quale viene allevato, sviluppa forme di culto, riti di passaggio, divinità da venerare rappresentazioni di forze spirituali da invocare o fuggire, persino rappresentazioni cifrate della realtà sottile, personale e cosmica.
Tuttavia, come è evidente nelle marcate differenze nel tempo e nelle diverse aree culturali, ogni apparato ed ogni suo componente non è che un aggregato provvisorio, senza alcuna forza vincolante che lo determini come il buddismo: è solo un buddismo e come tale ha una nascita, un periodo di fulgore, l’invecchiamento e la fine.
Mentre la fenice è già rinata altrove, in modo affatto inaspettato.
Anatman/pratityasamutpada, vacuità e impermanenza dicono di un fondo senza fondo così radicale che nessun fenomeno vi può sfuggire, neppure la storia: non sarà mai possibile determinare se il bruco è solo bruco e la farfalla è solo farfalla, ossia con una storia solo individuale o se è il bruco che diventa farfalla; cioè se esiste una storia complessiva. In senso essenziale non c’è né bruco né farfalla e perciò nulla che si possa trasformare, nulla che possa avere una storia autonoma.
Ovvero: proprio perché il bruco non ha un’esistenza in senso ontologico proprio per questo può trasformarsi in farfalla. Così è per la ghianda e la quercia, il bambino e l’adulto.
Torte e ricette. Non confondere la ricetta con la torta
Kukai, il monaco giapponese che nel nono secolo trasmise il buddismo tantrico/vajrayana dalla Cina in Giappone, afferma: «Gli insegnamenti del buddhismo segreto[6] sono tanto profondi da sfidare qualsiasi espressione scritta; soltanto la pittura può rivelarli[7]». Quello che Kukai intendeva dire è che l’estremo limite della comprensione tramite le facoltà umane non si raggiunge attraverso l’uso del pensiero razionale ma è prerogativa di un altro tipo di percezione. Quel tipo di facoltà che esercitiamo quando ascoltiamo musica oppure osserviamo un quadro, una scultura.
L’esigenza di interporre una mediazione nel processo di apprendimento tra parte insegnante e parte discente è ben presente in ogni scuola buddista sin dall’antichità. Tuttavia la situazione complessiva della trasmissione da persona a persona nell’insegnamento buddista è molto diversa da ciò che comunemente si intende con trasmissione del sapere. Per esempio, se noi prendiamo in considerazione una scuola di qualsiasi tipo, il passaggio del sapere da una generazione all’altra avviene attraverso parole che si fanno carico di concetti analogici e numerici, nonché della loro combinazione; penso alla letteratura ed alla matematica per esempio. Si tratta per lo più di questioni che il pensiero umano è solitamente in grado di maneggiare e proporre, come pure di comprendere e poi riprodurre.
Con le opportune istruzioni vengo messo in grado di tradurre il greco antico, distinguere la prosa di Virginia Woolf da quella di Jane Austen oppure apprezzare ed applicare le regole della geometria euclidea. Si può sostenere che tutto ciò di cui si tratta nelle materie insegnate nelle scuole di ogni livello è già sotto forma simbolica prodotta dal pensiero e perciò da questo comprensibile e riproducibile.
Perciò nel caso della trasmissione che avviene in una comune scuola, la possibilità di rappresentare i vari piani di realtà tramite simboli, immagini o parole che riproducono pensieri, permette ad una enorme quantità di sapere di essere trasmessa da una generazione all’altra in forma pensabile; è un pregio, una qualità positiva; infatti viene detta patrimonio intellettuale, culturale ecc.
Invece per ciò che concerne la trasmissione essenziale del buddismo questo tipo di patrimonio può costituire un vero e proprio ostacolo, un’occlusione che impedisce il fatto stesso che si vuole realizzare: il passaggio da una generazione all’altra dell’identità buddista.
La fiaba della verità
Apparentemente il buddismo è la religione che più si presta ad essere rappresentata, dipinta, illustrata. La sua plasticità è tale da essere un vero e proprio invito affinché un artista si misuri con essa. Per esempio nel capitolo VII del Saddharmapundarikasutra, o Sutra del Loto compare una parabola che, come tutte le allegorie di questo sutra pare un vero e proprio abbozzo scenografico: una guida conduce un folto gruppo di persone all’Isola dei Gioielli e sul loro cammino incontrano una grande ed intricata foresta: «Il folto gruppo di persone […] dice: “Maestro, guida, condottiero, noi siamo stanchi, impauriti, ansiosi ed esausti. Torniamo indietro, quest’impervia foresta è troppo lunga”. Ma la guida, abile nei mezzi […] pensa tra sé: “È un peccato che questi infelici non raggiungano la grande Isola dei Gioielli”. Per compassione verso di loro utilizza allora l’abilità nei mezzi salvifici. Nel cuore della foresta […] fa apparire una magica città […] Quei tali, pervasi da meraviglia, sorpresa, stupore, dicono: “Siamo fuori da quella impervia foresta; qui abbiamo ottenuto il nirvana e vi rimarremo”. […] In seguito sapendoli riposati, la guida fa sparire la magica città e dice loro: “Venite signori, la grande Isola dei Gioielli è vicina. Io ho fatto apparire questa città per darvi un poco di riposo»[8].
Fuor di metafora qui si dice che ogni discorso, ogni ragionamento che abbia per oggetto il buddismo è una piccola grande magia, destinata ad essere svelata, superata al passo successivo: l’Isola dei Gioielli è il passo successivo che quando sarà nel presente sarà la “magica città” che nel fare un altro passo scomparirà divenendo passato. Proprio questo, che è l’atto di considerare reale e, insieme, fondamentalmente illusorio il mondo nel quale siamo immersi è il fare dei buddisti: affinché sia reale non ne costruiamo fantasie.
Lasciando scorrere senza aggrapparci ci armonizziamo alla sua impermanenza, illusorietà.
Raffigurare vuoto
Nel buddismo l’esigenza di mantenere un medium tra l’oggetto del discorso e l’ascoltatore non è realizzata solo tramite la letteratura, si riproduce anche nelle altre arti. L’arte figurativa buddista si è evoluta, a partire dal V secolo avanti Cristo, seguendo diverse fasi che partono dai monumenti funerari e passano poi attraverso la rappresentazione della Comunità Universale che ascolta l’insegnamento del Buddha.
Inizialmente però questi non è raffigurato, in sua vece viene lasciato un posto vuoto al centro, attorniato da semidei, re, santi discepoli, animali e spiriti. In questo caso il simbolo è il vuoto rappresentato come tale: simbolo inafferrabile per un messaggio che è “non afferrare”[9].
In altri casi, al posto centrale invece di un vuoto vi è un segno che rimanda alla vicenda della biografia iconografica del Buddha: l’albero di ficus religiosa seduto sotto il quale si dice che Sakyamuni sia giunto al risveglio; oppure la ruota del dharma, il cui avvio è l’inizio della trasmissione agli uomini della nostra era dell’insegnamento universale…
Nel Gandhara, l’influenza ellenica successiva alla conquista di Alessandro e dei regni indo greci succedutisi dal IV secolo a.C. al I secolo d.C., portò alle prime raffigurazioni umane del Buddha: un indiano nella postura, negli abiti e nell’acconciatura ma con le fattezze del dio Apollo.
Però, a partire dal II secolo a.C. si era compiuto il processo di spersonalizzazione della figura fisica del Buddha: quelle statue -più tardi i dipinti che raffiguravano per lo più una persona seduta a gambe incrociate- non erano ritratti del signor Sakyamuni, ma erano un tentativo di rappresentare la realtà della via di salvezza con fattezze umane.
Anche in quel tipo di arte quindi, ciò che è raffigurato non è il vero soggetto, che resta sì evocato ma va percepito senza immaginarlo, senza costruirne un’immagine privata. Che sarebbe un idolo.
L’arte di non raffigurare
L’esigenza di non dare forma col nostro pensiero immaginativo al “vero soggetto” la ritroviamo anche quando prendiamo in considerazione il significato di “fede”.
Nel buddismo aver fede significa non dare alcuna forma costruita da noi all’oggetto della nostra fede. Altrimenti il nostro credere sarebbe diretto ad un idolo da noi stessi fabbricato. La vera fede nel buddismo è vuota, priva di immaginazioni. Però crediamo ugualmente.
Ecco, nel meccanismo attivato dal linguaggio intenzionale si sviluppa un processo analogo: il simbolo (sia esso il vuoto, una forma, una metafora) ci avverte che si sta parlando d’altro; a quel punto, come nel credere senza oggetto, lasciamo che lo spirito si espanda libero e privo di contenuto, privo di oggetto. Oppure: senza assumere alcuna forma.
Comprendiamo meglio l’importanza decisiva di questa operazione, all’apparenza inutile e oziosa, se consideriamo che l’insegnamento buddista è volto ad innescare un processo, un movimento spirituale, non ad impossessarci di un’immagine o di un qualche tipo di conoscenza.
Quando il buddismo entrò in Cina, a partire dal I secolo della nostra era, trovò ad accoglierlo una cultura religiosa e filosofica estremamente sviluppata, profonda, ampia e orgogliosa.
Anche in quell’antica cultura si parlava di “vuoto”. Il senso però era sottilmente e profondamente differente dall’omologo termine buddista. Nel daoismo di Zhuangzi e Laozi e poi in quello dello Studio del mistero, il vuoto è il non ancora manifesto, l’apice di potenzialità “prima” che il fenomeno venga in essere. Ossia per gli antichi cinesi il vuoto era il massimo del pieno.
Fu la forza dell’insegnamento base del Buddha sull’impermanenza -rivisitato secondo Nagarjuna che pone (o ri-pone) il vuoto al centro della scena- ciò che permise al buddismo di smarcarsi dal daoismo, evitando di esserne fagocitato. Nagarjuna, il monaco indiano del secondo secolo riconosciuto come sommo da tutte le scuole buddiste, insegnò il vuoto inteso come qualità della manifestazione, la qualità fondamentale di ogni esistenza fenomenica, non come condizione previa alla manifestazione del fenomeno.
Quando i monaci buddisti cinesi nell’ottavo secolo vollero rappresentare quello che in mancanza di un termine migliore potremmo chiamare il “vuoto sotteso all’impermanenza del reale” naturalmente si mossero all’interno del canone estetico cinese, usando le forme e le atmosfere che già caratterizzavano le rappresentazioni degli eremiti del Dao. Ma vi aggiunsero, se così si può dire, l’espressione del vuoto e della volatilità di ogni esistenza. Questo diviene vero soggetto di quei dipinti a china, nei quali brandelli di panorama, un ciuffo d’erba, un sasso, un fiore fungono da contrappeso per evidenziare ancor di più la quantità di vuoto che copre quasi per intero la tela, e contemporaneamente sono irridenti testimoni del mistero di un intero cosmo che vive, nasce muore e cambia continuamente in ogni sua più piccola molecola senza alcun fondamento che lo sostenga: spazio nello spazio, nel tempo senza tempo. Il sasso, il ciuffo d’erba, l’uccello in volo sono allusioni ad una qualità del fenomeno, incongruente eppur vitale.
Nel tredicesimo secolo quell’arte fu introdotta in Giappone dove trovò una sensibilità ed un terreno adatti per essere apprezzata ed elaborata per quasi tre secoli. Tuttavia, col passare del tempo, quel sasso, la rana sul punto di saltare, il drago che occhieggia dal fondo di un anfratto cessarono di essere i “marcatori” di qualche cosa d’altro, divennero il vero soggetto: nacque il manierismo. Quasi altrettanto bello, ma muto, in qualche modo privo di vita profonda.
Seguire le indicazioni
Perciò ogni forma di rappresentazione mediale originatasi nel buddismo necessita da parte dei suoi autori (e possibilmente anche da parte degli interpreti) di una lunga pratica e studio e sequela per poter essere realmente espressione di un’esperienza originale: sebbene le parole scritte o parlate dei buddisti non siano altro che “un dito che indica la luna”, qualora il dito indichi una direzione errata esso non può neppure svolgere la sua funzione mediale. L’indicazione è data anche dalla qualità del dito.
Poi deve poter dire alludendo, senza che ciò che è rappresentato sia mai afferrabile in quanto “contenuto” perché l’opera è esplicitamente un velo, una metafora. Contemporaneamente deve poggiare sulla consapevolezza che non vi è alcun messaggio, comunicazione, soggetto autenticamente buddista: chi pensa di sapere che cos’è il buddismo è il meno adatto per comunicarlo.
Essendo il buddismo il fatto religioso –o più semplicemente “quello che i buddisti fanno”- raccontarlo correttamente significa negare al racconto stesso -ma anche all’immaginazione che nasce dal racconto- la possibilità di sostituirsi al “vero soggetto”. Quello che dico non è il buddismo, è il racconto mio personale del buddismo…
Finalmente al cinema
Per questo nel rappresentare il buddismo, particolarmente per mezzo del cinema, è molto difficile mantenersi lontani dal manierismo, in ogni sua forma. Dico “particolarmente per mezzo del cinema” perché, assieme alla televisione, il cinema è una forma di comunicazione che, nell’immersione/identificazione che induce, fa apparire le cose narrate, ovvero la finzione, come se fossero ciò da cui la narrazione è nata. In questo caso l’opera di mistificazione è potentissima: basta mettere assieme una piccola statua del buddha con accanto un fiore scarlatto, un indiano immobile e smagrito, coperto da una veste ocra in una capanna nella foresta, seduto a gambe incrociate ed ecco che il buddismo è ascesi solitaria. Oppure: sarebbe magnificamente scenografica la rappresentazione del Buddha sul Picco dell’Avvoltoio, a lungo immobile in silenzio davanti ad una grande folla in attesa, poi con un gesto della mano accenna verso un fiore di campo davanti a lui e Mahakasyapa con un leggerissimo sorriso mostra di aver capito… ed ecco che il buddismo è la trasmissione di una sapienza misteriosa ed ineffabile. Oppure: si rappresenta un monastero cinese con monaci atletici avvolti in ampie vesti gialle che compiono salti mirabolanti ed ecco che il buddismo “è” le arti marziali. Oppure: in una casa, circondata da un piccolo giardino muscoso, una donna dai tratti orientali è devotamente assorta, prega inginocchiata davanti ad un immagine di Kannon-Avalokitesvara, così simile ad una statuetta di Maria da essere difficilmente distinguibile: ecco che il buddismo è devozione all’immagine della compassione. Identico discorso possiamo fare sulla storia di un bambino tibetano riconosciuto adatto, qualificato per essere istruito come lama o riguardo alla rappresentazione del rigore della vita monastica in una comunità birmana che vive del cibo raccolto nella questua, consumando un solo pasto al giorno.
Il buddismo vive in molte forme e ciascuna può dire di essere il buddismo ma non lo può rappresentare in toto. Se tentiamo di raffigurarlo in uno di quei modi il nostro messaggio diviene uno stereotipo: dipingeremo una rana avendo come soggetto una stupida rana, non il mistero della vita.
Negli Udana, antichissime narrazioni del Canone Pali, vi è la storia raccontata dal Buddha[10] su coloro che, non vedenti dalla nascita, per la prima volta si avvicinano ad un elefante ed a seconda della parte dell’animale che toccano descrivono l’elefante come una colonna, uno scacciamosche, una liana. Siccome è inevitabile trovarsi sempre in questo caso, ovvero rappresentare una piccola parte del grande articolato buddista, è indispensabile la volontà di palesare la marginalità del proprio discorso, affinché non venga visto, creduto come rappresentativo del tutto.
Il dolore
Tutti questi distinguo, queste avvertenze e cautele danno conto del perché nella società moderna siano relativamente scarse le opere narrative o filmografiche nate dal buddismo. Non penso ai film commerciali in stile hollywoodiano, nati e proposti senza alcuna pretesa religiosa.
Mi riferisco a opere di narrativa, poesie, film, teatri che tentino fondatamente di far parlare il buddismo. Opere agiografico/edificanti a parte, penso si possa dire la stessa cosa del cristianesimo: per esempio le lettere di Paolo a volte hanno anche una struttura narrativa, ma sono molto difficili da “riprodurre” in un racconto, in un film o in un teatro. Infatti, per quello che mi consta, in duemila anni nessuno ci ha ancora provato.
Un film che volesse essere autenticante cristiano o che volesse dire il cristianesimo a chi non lo conosce incontrerebbe quasi le stesse difficoltà di un suo confratello buddista: dico “quasi” perché il buddismo non è una religione del Libro, non ha una trama pronta e da tutti accettata.
Per terminare
Fondamentalmente “il Buddha non ha detto neppure una parola”, questo significa che nulla di ciò che ha detto può essere inteso in modo dogmatico, come fosse una legge da non trasgredire. Il punto di partenza della sua predicazione[11] che nasce, lo ripetiamo, dal risveglio descritto come pratityasamutpada è la constatazione che la nascita è dolore, la malattia è dolore, la vecchiaia è dolore, la morte è dolore, il non raggiungere ciò che vorremmo è dolore, l’essere costretti a convivere con ciò che non amiamo è dolore.
La sua testimonianza fu:che esiste una causa del dolore, che il dolore può essere vinto, che esiste una via che conduce alla fine del dolore. Che questa via è la via mediana, così detta perché non si aggrappa a nessuna teoria, a nessuna affermazione a nessuna negazione. Che nella vita di ogni giorno la via mediana si manifesta con naturalezza, inconsapevolmente come retta visione, retta intenzione, retta parola, retta azione, retti mezzi di sostentamento, retto sforzo, retta attenzione, retta concentrazione.
Dedicò 45 anni della sua vita alla testimonianza nei fatti, giorno per giorno, della realtà della “via che conduce alla fine del dolore”. In questo tempo lunghissimo ebbe modo di condividere la vita e la via con due, tre generazioni di discepoli, suoi compagni di cammino. A chi gli chiedeva consiglio su come questa via vada percorsa rispondeva secondo circostanza. Ogni sua risposta era diretta ad una certa persona in quel momento in quella situazione: se noi prendessimo le sue risposte come indicazioni generali, avulse dalla vita del momento che le aveva generate compieremmo un tradimento.
Allo stesso modo sarebbe un inganno rappresentare “il buddismo” attraverso una o più delle sue manifestazioni nel tempo e nelle culture: ognuna è la risposta che quegli uomini in quel luogo, in quel tempo hanno dato, danno con la loro vita all’invito a percorrere la via che conduce alla fine del dolore.
mym
[2] Cfr. M.Y.M. Il Buddismo mahayana attraverso i luoghi i tempi e le culture, 99. (D’ora in poi : Vol. I)
[3]Dhyana (s.) “assorbimento nel silenzio e nella pace” che in p. è jhana, in cinese fu traslitterato chanding e channa poi chan, in giapponese zenna e zen, in coreano son. Samatha “quieto dimorare” (da sama “calma, quiete” e tha “dimorare, riposare, fermarsi”), samadhi “completezza profonda” (da sam “con, assieme, unione” e adhi “unire, mettere assieme”.
[4] Cfr. M.Y.M. Vol. I, 95 ss.
[6] “Buddismo segreto” è una traduzione di mikkyo, uno dei termini giapponesi con cui si designa il buddismo esoterico, di scuola tantrica o vajrayana.
[7] Cfr. P. Cornu, Dizionario del Buddhismo, Bruno Mondadori, Milano 2003, 579.
[8] Cfr. Luciana Meazza, a c. di, Sutra del Loto, BUR, Milano 2001, 193 s.
[9] Nekkhamma in pali, naiskramya in sanscrito.
[11] Cfr.Dhammacakkapavattanasutta, o Discorso della messa in movimento della ruota del dhamma, e Saccavibhangasutta, o Discorso della esposizione dettagliata delle verità.
One Response to “Introduzione”
Se volete, lasciate un commento.
You must be logged in to post a comment.

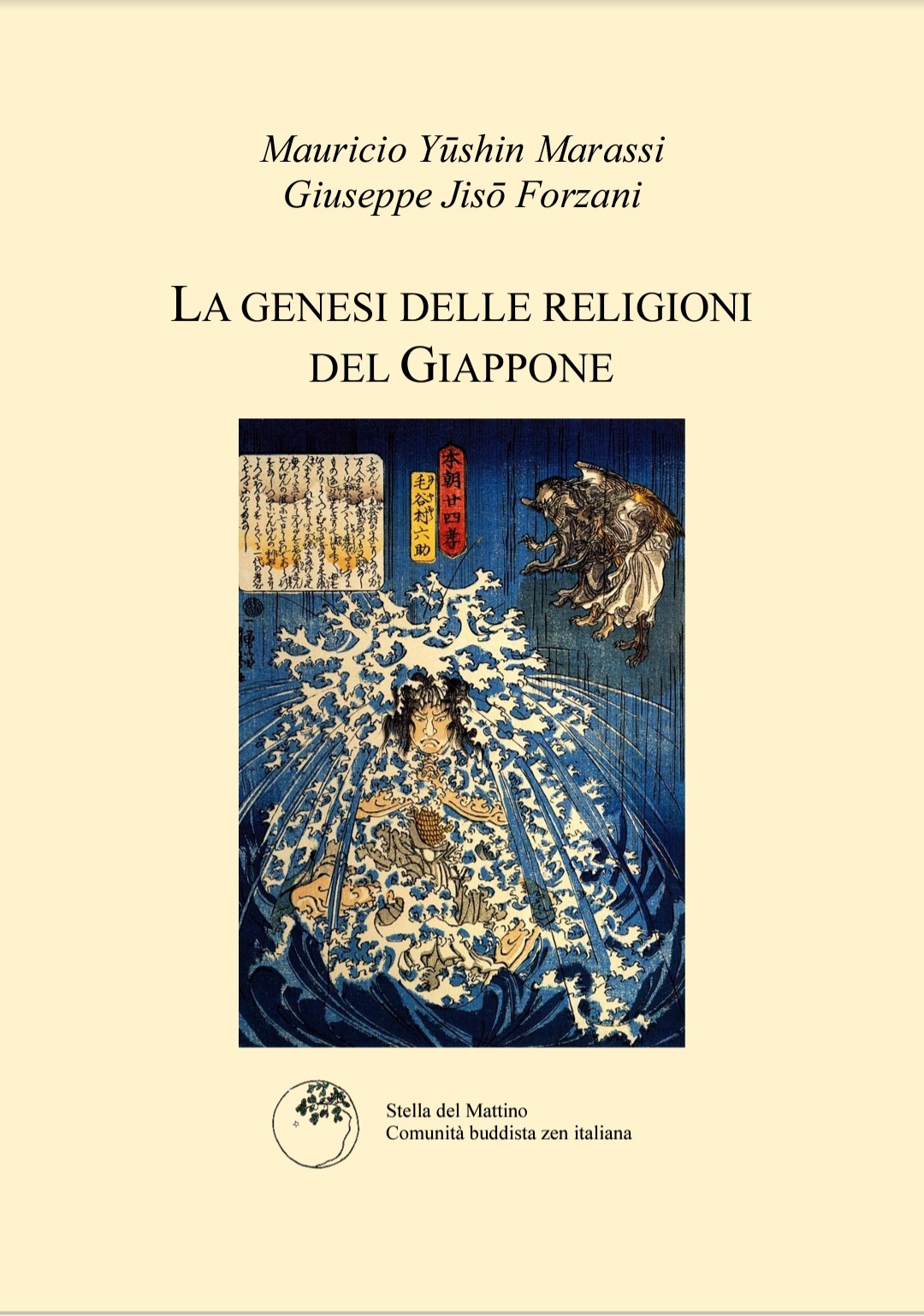






Dicembre 7th, 2008 at 4:27 pm
Penso che per un buddista del XXI sec. il cinema abbia una sorta di incompiutezza ontologica. Rappresenta il massimo della definizione consegnato a un’infinita indefinita meccanica. Ogni film non finisce mai, ma ricomincia in continuazione: è un eterno ritorno. Come se l’immagine si sostituisse al testo.