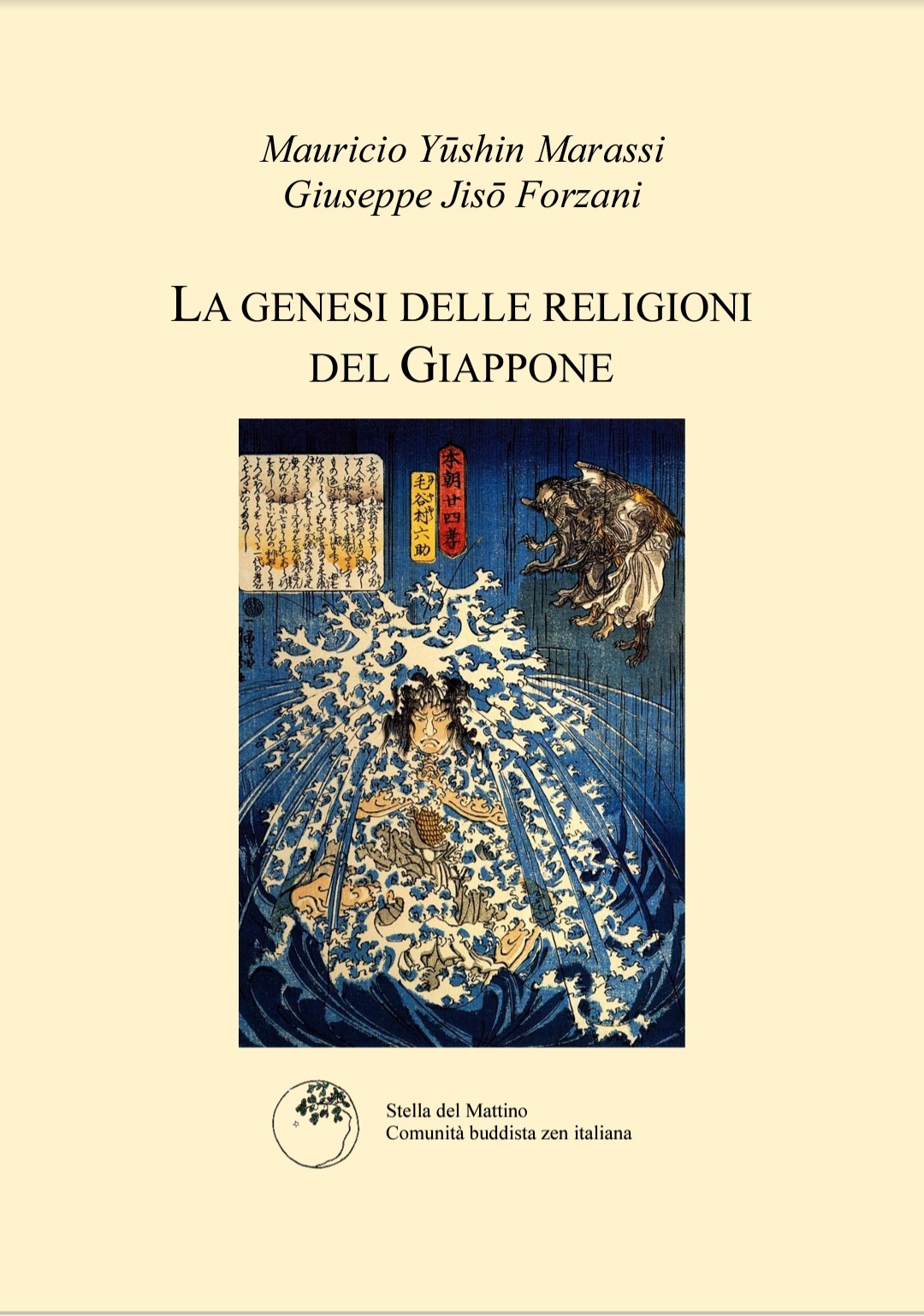III. Curare la radice
Per curare un male radicale, come è la crisi dell’uomo contemporaneo, è necessaria la cura della radice. La radice è la parte profonda dell’albero, della sua manifestazione evidente. Oggi in molti rivendicano le radici cristiane della cultura e della civiltà europea. Nel Vangelo, Gesù afferma che l’albero si riconosce dai frutti. Se i frutti dell’albero Europa, che oggi tutti mangiamo nel mondo, sono malati o avvelenati, sarà forse il caso di guardare con maggior attenzione questa radice originaria.
Se sul piano storico la malattia della cultura europea inizia a manifestarsi nell’epoca (intorno al XII secolo) in cui l’esperienza mistica viene mortificata e spesso perseguitata dalla Chiesa, il germe di quella malattia va cercato nella radice stessa. Ed è proprio la metafora dell’albero a darci indizi rivelatori. Nei Vangeli si trova ripetuto in varie occasioni e con differenti esempi che l’albero buono è quello che produce molti frutti. E’ vero che spesso troviamo nelle parole di Gesù affermazioni che invitano a non cercare guadagno, a non darsi affanno per produrre e per accumulare. Ma molto più forti risuonano gli ammonimenti a far fruttare, che si tratti di talenti o di vigna, e a tagliare, estirpare, bruciare tutto ciò che non porta frutto, fino alla maledizione e all’essiccamento dell’albero di fico che non produce fichi in inverno, fuori stagione! Chi porta frutto avrà in premio il regno dei cieli, chi non porta frutto è destinato al fuoco eterno. La cultura europea è rimasta talmente influenzata da questa atmosfera produttiva, da strutturarsi su una didattica etica che ha fatto del progresso, dell’accrescimento, della quantità i valori trainanti della propria storia recente.
Dall’inizio dell’età moderna, la spinta che sosteneva la visione escatologica della cristianità si è applicata sempre di più alla realizzazione dei valori supremi (giustizia, eguaglianza, libertà) nella storia e nel mondo, spostando l’attenzione e l’impegno dall’interiorità all’esteriorità dell’uomo. La mentalità contemporanea ha del tutto scordato quello che era un cardine della visione mistica e spirituale, religiosa e filosofica: di nuovo con la parole di sant’Agostino, mistico, filosofo, teologo: “Non uscire fuori di te, ritorna in te stesso: nell’interiorità dell’uomo abita la verità, e se troverai la tua natura mutabile, trascendi anche te stesso” (De vera religione XXXIX). Il progressivo spostamento del baricentro dell’uomo fuori di sé, culmina nell’epoca moderna nella ricerca del valore e del senso della propria vita quasi esclusivamente nella relazione che l’uomo ha con ciò che lo circonda.
In questa situazione il buddhismo può essere un fattore determinante di autentica conversione.
La conversione nel buddhismo non è conversione al buddhismo, nel senso di aderire a una dottrina che si chiama buddhismo. La conversione è ciò che Dōgen nel Fukanzazengi indica con la seguenti parole: 須らく回光返照の退歩を學すべし – subekaraku ekō henshō no taiho wo gakusubeshi – è essenziale imparare a fare un passo indietro, volgendo la luce a rischiarare dentro di sé. Il buddhismo può svolgere il compito di indicare all’uomo contemporaneo, occidentale e orientale, quale è la sola cosa che conta perché, secondo le parole del Vangelo: “Là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore” (Mt. 6,19-21). Proprio questo sembra essere il problema dell’uomo contemporaneo: non sapere più dove è il suo tesoro, e mettere dunque il cuore là “dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano”. Il buddhismo può insegnare all’uomo occidentale, orientato fuori di sé in una prospettiva di progresso che non conduce da nessuna parte, a fermarsi, a tornare in sé, a illuminare se stesso per cercare, in sé e a partire da sé, il proprio tesoro.
IV. In che modo?
Il buddhismo ha un grande vantaggio rispetto alla problematica di cui stiamo parlando: non ha mai elaborato un’idea di Dio, non ha mai “pensato Dio”. Quello che i cristiani chiamano Dio è per il buddhismo impensabile. Il buddhismo non ha bisogno di liberare l’uomo da Dio, come invocavano i mistici cristiani, perché non ha mai dato sostanza e sostegno all’idea di Dio. Libero da Dio l’uomo è anche libero da quel se stesso fatto a immagine e somiglianza di Dio.
Poiché nel buddhismo non c’è un oggetto di fede né di pensiero da chiamare “Dio” né di conseguenza un nome per quell’oggetto, sovrapponendo approssimativamente i linguaggi possiamo dire che quello che i cristiani chiamano Dio nel buddhismo è perfettamente vuoto, né esistente né non esistente, e non può in nessun caso fornire il pretesto per elaborare un’idea di Dio, né un’idea di io che gli sta di fronte. Se vogliamo continuare ad usare la parola “Dio”, per restare nella terminologia occidentale, possiamo dire che nel buddhismo Dio e lo spirito dell’uomo sono già non-due, perché è nello sperimentare quel limpido vuoto che l’uomo incontra se stesso. Incontra il proprio spirito vuoto di Dio e di sé.
A differenza delle religioni e delle filosofie occidentali, il buddhismo non ha paura del vuoto. Il pensiero occidentale non si è mai seriamente confrontato con il vuoto, perché, in un modo o nell’altro, ha sempre concepito il vuoto come nulla. Il pensiero occidentale ha ontologizzato persino il vuoto, lo ha rappresentato come nulla e se ne è ritratto comprensibilmente inorridito.
Per il buddhismo, invece, il vuoto non è né un ente né un sostantivo ma un attributo, l’attributo fondamentale di ogni cosa. E’ la caratteristica che rende possibile che ogni cosa sia ciò che è, un miracoloso vuoto apparire. Buddhismo è dimorare nella natura vuota della realtà, dove tignola e ruggine non consumano, dove non c’è nulla da rubare, da perdere, da guadagnare.
Il buddhismo non è una spiegazione della realtà, una cosmologia o una filosofia ermeneutica. Non è un’utopia né una dottrina sociale su cui cercare di modellare la realtà. Non è una dottrina né un’ortodossia. Non è una terapia per curare il malessere psicologico individuale. Il buddhismo è la via che indica come mettere in pratica l’esperienza indifferenziata dell’uomo e di …, del relativo e dell’assoluto, del condizionato e dell’incondizionato, del finito e dell’infinito. Una esperienza di unità profonda che può essere vissuta solo nella fede, nell’abbandono e nella rinuncia a mettere il sigillo del pensiero umano come determinazione finale della realtà.
Mentre nell’esperienza cristiana la fede è per lo più un moto dello spirito, uno slancio del cuore oltre se stesso, un’apertura incondizionata a Dio, nel buddhismo la fede è esperienza vissuta con corpo e spirito, un atto di pura e serena fiducia, senza la costruzione -che è sempre principio di appropriazione- di un oggetto. Questa esperienza si sintetizza nel sedersi in silenzio, quell’atto di corpo, mente e spirito che chiamiamo zazen. Zazen è l’atto di fede, la fede in atto perché è il modo concreto, la posizione del corpo e spirito dell’uomo che mette in pratica, nel semplice star seduto, questa relazione non duale. Se usiamo la terminologia cristiana, possiamo dire che in zazen Dio e uomo sono non due, perché in zazen si è liberi sia da Dio che da io. Oppure, nelle parole di Dōgen
自己の身心および他己の身心をして脱落せしむるなりjiko no shinjin oyobi tako no shinjin wo shite datsuraku seshimuru nari – abbandonare corpo e spirito di se stessi e corpo e spirito dell’altro. Dove la relazione non è sostenuta dall’idea né di io né di tu, la relazione è identità e nulla è di ostacolo alla libertà.
Questo -almeno in un ambito di persone che praticano zazen da molto tempo- non è difficile, quantomeno a capirsi. Ben più difficile è invece la realizzazione e la trasmissione della qualità che trasforma lo zazen in atto religioso in una vita religiosa, lo tiene al riparo dal diventare -come già avvenuto in passato- una via di potenza, di acquisizione di potere e perciò, in definitiva, una forma di vita che si sostiene sulla morte. Quella qualità che fa sì che si possa essere grandi solo rimanendo piccoli, maestri solo se si vive da discepoli, senza velleità né di accumulare né di apparire né di contare.
Per poter avere un ruolo vitale all’interno del processo storico in atto, ben oltre quel livello di ritualità da parata in cui si viene invitati o si partecipa, “per far sì che ci siano anche i buddhisti” al tavolo più o meno rotondo del banchetto “interreligioso”, magari per aver diritto a una fetta di torta, sarà necessaria, prima di tutto, una profonda riforma al nostro interno, un abbandono progressivo della deriva formalistica, gerarchica, chiesastica che ci assorbe tante energie, per rivitalizzare la spiritualità della semplicità e della gratuità, la coltivazione del cuore innocente invece che il consolidamento della volontà di potenza. Senza la capacità di convertire prima di tutto il nostro cuore non avrà alcun senso la nostra presunta capacità di praticare lo zazen, per cui anch’esso finirà per diventare -come molti segni stanno a indicare e dimostrare- un’altra delle prede che il mondo dell’accumulazione e del “mio” saranno ben lieti di incassare, per farne poi un loro raffinato strumento.
La tradizione non è forza d’inerzia, ripetizione meccanica di modi di fare, la trasmissione non è appropriazione di modelli ed esibizione personale di certificati e conseguimenti, la cura della generazione presente e a venire non è consolidamento di posizioni raggiunte e protezione del proprio gregge. La riforma continua che fa girare la ruota del dharma è tornare a quel vuoto vitale ogni volta che essa rischia di impantanarsi nel calcolo dei profitti.
V. Conclusione
Ma, si dirà, di fronte a una crisi epocale e globale, che mette in discussione il futuro dell’umanità, quello che il buddhismo ha da proporre è tutto qui? In un mondo perennemente in guerra con se stesso, invece di proporre una soluzione alternativa, un progetto di un mondo diverso, il buddhismo dice semplicemente di fermarsi, di rientrare in se stessi, di illuminare la propria vita con la pratica dello zazen e di testimoniare nel proprio ambiente e nel proprio ambito la qualità spirituale ed esistenziale dell’innocenza?
Proprio così. Il buddhismo può fare per il mondo né più né meno di quello che può fare per me, per ciascuno di noi: e io posso fare per gli altri, per il mondo né più né meno di quello che posso fare per me stesso. “Ama il prossimo tuo come te stesso”.
Tornare indietro non si può. Così come un vecchio non può ritornare giovane e un morto non può tornare vivo, né un singolo individuo né il mondo possono tornare sui propri passi. Non si può ritornare a prima che si innescasse quel processo storico che ci ha portato qui dove ci troviamo e rifare il percorso in modo diverso, per evitare gli errori commessi. Tornare indietro non si può, ma tornare a zero sì. Tornare al punto zero e di lì ripartire ogni volta: questo è la conversione di ciascuno che può convertire il mondo intero. Il buddhismo, in Occidente come in Oriente, può svolgere questa funzione, perché non è la ricetta di un mondo migliore, una dottrina che applicata trasformi questo mondo in un mondo diverso: buddhismo è non farsi illusioni a proposito delle illusioni e dello svegliarsi dalle illusioni. È l’adesione ideale e operativa al sentiero di mezzo che non investe né nel conseguimento del successo che placa per un istante la voragine dei desideri né nella rinuncia auto punitiva e disperata nell’attesa della morte. Questi due estremi si manifestano nella storia in forme sempre differenti. Oggi un estremo sembra essere rappresentato dal mito della crescita e del progresso, individuale e collettivo; l’altro dall’annullamento di sé e dalla negazione di questo mondo attraverso le mille modalità dell’ottundimento, siano esse il fanatismo ideologico e religioso o la droga o il lavoro. Il continuo ritorno alla via di mezzo che il buddhismo indica è un’opera infinita, perché in palio c’è la vita eterna e dunque non è confinata in un tempo.
In un mondo che esalta il godimento dell’ora e del qui nell’appagamento di ogni desiderio, lo stile di vita dei buddhisti nel mondo è la sola riprova valida della loro fedeltà alla via che testimoniano. Il buddhismo, in Occidente come in Oriente, può fornire tutti gli strumenti che la tradizione ha elaborato per questa opera infinita di ri-orientamento, ma deve evitare l’errore che la civilizzazione occidentale ha commesso, di trasformare il mezzo nel fine. Il cristianesimo occidentale ha gradualmente trasformato le chiese, che inizialmente erano le comunità delle persone che si sostenevano a vicenda nel percorrere la via indicata da Gesù, nella Chiesa, un’istituzione che si vuole depositaria del pensiero e della volontà di Dio, e che è pertanto fine a se stessa, la meta. Il buddhismo, nel momento in cui prende anche in Europa e in America forme istituzionali, deve fare estrema attenzione a evitare questo tipo di errore.
Lo scopo del buddhismo è il risveglio che apre alla liberazione da ogni male, alla pace, non è la costruzione di una o più istituzioni religiose numerose, potenti, efficienti. Un’istituzione buddhista, sia essa un piccolo centro, un monastero o una struttura centrale non tradisce la propria vocazione solo se è al servizio della fede e della pratica dei singoli sulla via del risveglio. Non è preposta a certificare l’autenticità e la bontà del cammino di nessuno, non è preposta ad attribuire cariche, titoli, diplomi, né a fornire un’identità di riserva, un ruolo o uno status, una nuova maschera, insomma, dalle fattezze “buddhiste”.
Il risveglio dalle illusioni che chiamiamo esperienza di Buddha, è vedere, con i propri occhi, che ogni forma è illusione e illusione suprema è pensare che ci sia “qualche cosa” che illusione non è.
dipendente e condizionato da altro, è,
non dipendente e condizionato da altro,
il nirvāṇa. Tale l’insegnamento.
(Nāgārjuna, Mādhyamakakārikā, Le stanze del cammino di mezzo, 25, 9)
Se volete, lasciate un commento.
You must be logged in to post a comment.