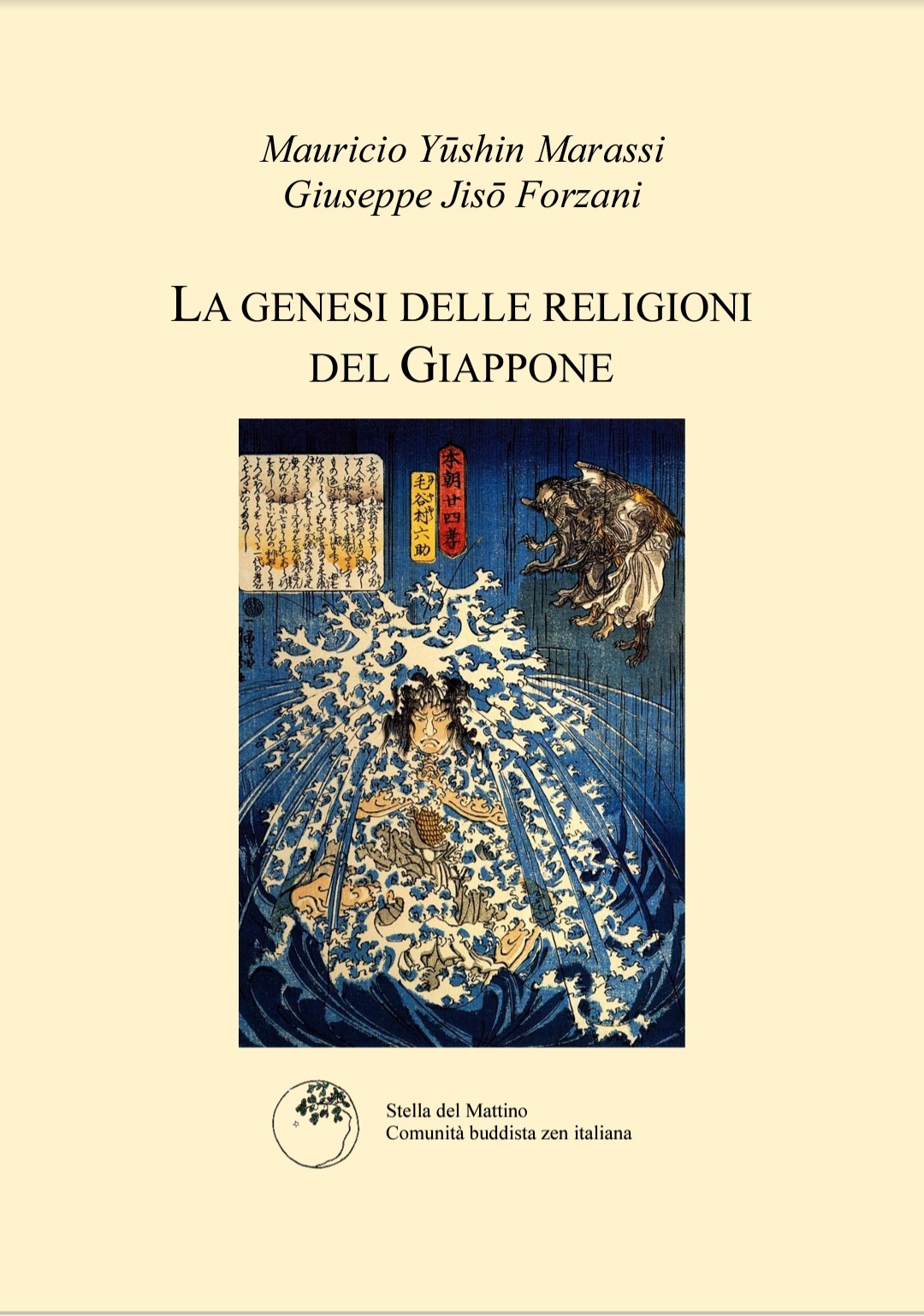L’occasione di scrivere queste righe mi è data dall’aver visto una trasmissione televisiva in cui l’attrice, presentatrice Catherine Spaak, garbata e graziosa, intervistava, nell’ordine: una monaca Zen (così è stata presentata), Platinette (un signore/signora sovrappeso “en travesti”) ed Eva Grimaldi (un’avvenente attrice di film “spinti”, come si diceva una volta). La monaca zen, sollecitata dall’ottima padrona di casa, ha tratteggiato con nitidezza e sobrietà la propria avventura umana, dicendo cose molto intelligenti, moderne e per nulla scontate sulla sua vita. Allo spettatore, la sua vista era impreziosita da due grandi occhi luminosi, da una gestualità morbidissima e dai colori vivaci del maglioncino e dei pantaloni, (evidenzio questi particolari non per frivolezza ma per sottolineare la positività di tutto l’insieme). L’orakusu era indossato con tale disinvoltura e naturalezza che solo dopo alcuni minuti l’ho notato. Tuttavia, chi abbia visto quella trasmissione rimarrà con due immagini mentali che, per come sono state create, si legheranno forse per sempre al suo inconscio: l’esistenza alle spalle di quella signora (e, per estensione, di ogni monaco zen) di un personaggio “altro” o “fuori del gioco” definito maestro, o Maestro (e quindi, automaticamente, l’esistenza di un corso, un procedimento, che ci fa maestri). Inoltre s’intravedeva la possibile commistione tra lo Zen e la pranoterapia. La signora, infatti, è anche pranoterapeuta, ma a differenza di altre sue attività che (come la danza classica) ha precisato essere esterne, estranee al mondo dello Zen, nel caso della pranoterapia questo non è stato precisato così che rimane nello spettatore la convinzione che “in qualche modo” essa sia connessa allo Zen. Non fosse altro perché il suo iniziatore alla pranoterapia fu, disse, la stessa persona che, indirettamente, la portò ad avvicinarsi al buddismo Zen.
A mio vedere, il dar per scontato l’esistenza di una figura chiamata “Maestro” (con annessa la conseguente possibilità di far carriera diventandolo) e l’accostamento, almeno verbale, tra la pranoterapia e lo Zen, sono due parti di un medesimo discorso. La prima parte si lega ad un processo storico all’interno del quale gli occidentali (prima gli americani e poi gli europei) hanno dato vita (anche con interessate complicità giapponesi) ad una attività, quasi un mestiere, che è una vera e propria degenerazione: il Maestro Zen. E’ un nome/figura che nella tradizione viene negato sin dall’inizio: nel Butsu Yui Kyō Gyō, componimento considerato contenere le ultime raccomandazioni di Shakyamuni morente, una larga parte è riservata a spazzare via ogni velleità di costruire maestri o di atteggiarsi tali. In questo sutra si afferma con chiarezza che il vero maestro, la lampada che illumina il cammino e la realtà tutta, è la scintilla di vita pura che sgorga continuamente in noi e che ascoltata ci guida. La trasmissione può avvenire solo tra pari (cfr. Shōbōgenzō Bendōwa), così come è possibile indicare la giusta direzione solo a chi si trova già sul sentiero. Chiamiamo forse “Maestro” chi ci guida in un’escursione in montagna? Lo rispettiamo, gli siamo grati, forse ci ha salvato più volte la vita, ma non eleviamo ogni sua attività a puro insegnamento che salva, anche fuori dei sentieri dei monti. Il maestro di sci o il maestro di musica, non sono “Il Maestro”.
Non voglio dire che non esista, nelle scuole Zen, la relazione maestro/discepolo, ma è una relazione personale, senza forma e, perciò, indescrivibile. Ogni volta che gli diamo forma fissa, sia con l’idealizzazione sia con titoli o certificazioni ufficiali, uccidiamo e imbalsamiamo la sostanza della relazione. Usando la terminologia e le immagini proposte da Dogen nel capitolo dello Shōbōgenzō chiamato “Muchū Setsumu” (“Spiegando un sogno dentro un sogno”), si può dire che maestro è il fratello maggiore che ci ospita, ci accoglie nel suo sogno. Per un poco: poi ciascuno vive solo il suo sogno, dentro al sogno.
In tutta la tradizione cinese e giapponese, sino ai nostri giorni, non c’è né il ruolo né il termine che corrisponda a ciò che si (fra)intende con la parola occidentale “Maestro”. Vi sono appellativi onorifici, quali zenji e rōshi, ma questi non corrispondono ad un ruolo o ad un livello di realizzazione dell’insegnamento. Qualsiasi vecchio monaco può essere definito tale per rispetto o perché, in quel periodo, è abate di uno dei due monasteri più importanti. Ma anche in questo caso non è in alcun modo un’investitura sacra, un riconoscimento della buddità o dell’illuminazione di qualcuno. Anche il termine “kyōshi”, sebbene significhi comunemente “insegnante, professore”, nella realtà dello Zen Sōtō, in Giappone, è tutt’altro dalla patente da Maestro (che non esiste), come è a volte inteso in occidente. Consiste in un certificato, rilasciato dall’amministrazione del clero (Sōtōshū Shūmuchō) ed abilita a condurre un tempio o qualsiasi attività ufficiale (in Giappone o altrove) utilizzando il nome della Scuola Sōtō Zen. Non ha nulla a che vedere con la presunta realizzazione di un alto livello dell’insegnamento. Devono avere il “kyōshi” (assieme ad un complicato intrigo di altri certificati) tutti i preti del Soto Zen, altrimenti, non potendo gestire un tempio, non potrebbero, per esempio, neppure officiare funerali. Che, in Giappone, sono la principale fonte di sostentamento del clero.
E’ vero che in Giappone ogni ruolo, civile o religioso, appartenendo ad una società a forte contenuto tradizionale (ancora fondata sul presupposto che il suddito che ubbidisce all’imperatore/dio compie così il volere divino, ossia è esso stesso la longa manus del dio imperiale nella realtà spicciola) ha una valenza anche sacrale. Quindi il religioso preposto alla conduzione del tempio, per quanto poco versato nelle “cose” dello Zen è, per il suo stesso ruolo, in una posizione a contenuto sacrale. Tuttavia è così anche per il capotreno o per il capoufficio, come pure ha una forte autocoscienza/autostima (e per molti versi questo si traduce in carisma e in sacralità di ruolo) l’anziana signora che pulisce il pavimento della stazione o il poliziotto che regola il traffico. C’è chi sta sopra e chi sta sotto ma ognuno è re nel proprio regno.
Forse proprio per questo, in America, nei primi decenni del secolo scorso, quando cominciarono ad arrivare i primi monaci/preti buddisti e (anche grazie ai libri di D.T. Suzuki) si guardò a loro non tanto come officianti di riti per i Giapponesi defunti in terra straniera (quali in parte erano), ma come portatori di insegnamento sapienziale altissimo (come avrebbero dovuto essere), avvenne che la prosopopea (di alcuni) ed i titoli di cui quasi tutti si fregiavano (che in patria erano semplicemente appellativi rispettosi) furono tradotti col nome ed il ruolo sacrale di “Zen Master”. Caricando questo ruolo/espressione di tutti i significati più elevati. Sino alla cosiddetta “Presentazione Idealistica” di Richard Baker (cito, tradotto, da “Means of Authorization” di Stuart Lachs, reperibile su darkzen):
“Richard Baker, nell’introduzione al più venduto libro sullo Zen in lingua inglese, Zen Mind, Beginner’s Mind (Mente Zen, mente di principiante) descrive il termine “rōshi” nel seguente modo:
« Un roshi è una persona che ha realizzato quella perfetta libertà che costituisce la potenzialità di tutti gli esseri umani. Egli vive libero nella pienezza di tutto il suo essere. Il flusso della sua coscienza non è fatto di strutture fisse e ripetitive come la nostra coscienza egocentrica, ma sorge anzi spontaneo e naturale dalle effettive circostanze del presente. Tutto ciò comporta una vita dalle caratteristiche straordinarie – capacità di rimanere sempre a galla con le proprie risorse, vigore, spontaneità, semplicità, umiltà, serenità, allegria, incredibile perspicacia e incommensurabile compassione. Il suo intero essere attesta che cosa significhi vivere nel presente. Anche senza che si dica o si faccia nulla, l’impatto puro e semplice dell’incontro con una personalità così evoluta può essere sufficiente perché cambi l’intero sistema di vita di una persona […]». [Cfr. anche S.Suzuki, Mente zen, Ubaldini, Roma 1976, pag. 15].Bisogna tener presente che quanto sopra fu scritto come introduzione alle parole ed agli insegnamenti dell’insegnante del signor Baker, ossia Suzuki rōshi. Quindi questa introduzione intendeva descrivere una persona reale, e, per estensione, come è chiaramente affermato all’inizio della citazione, tutti coloro che si fregiano del titolo di “rōshi”. Non è il riferimento idealizzato ad un essere celeste oppure a qualche figura religiosa di una lontana mitologia”.
Penso sia facilmente comprensibile che presentare (siamo nel 1970, agli albori del buddismo Zen in America…) un titolo/persona/ruolo/funzione con quegli attributi può portare solo a due tipi di conseguenze, ambedue catastrofiche: che nessun essere umano venga ritenuto degno, idoneo, di rivestire quel ruolo (non si troverà nessuno così apparentemente santo da soddisfare sempre tutte le condizioni: il nostro idealismo troverebbe sempre qualche cosa per cui “il tale” non è all’altezza) oppure che, quando qualcuno (come Suzuki Shunryu in America o Deshimaru Taisen in Europa) è accettato in quel ruolo da uno o più seguaci/discepoli, altri se ne aggiungano acriticamente divinizzando il poveraccio di turno. Quando lo scorso anno (ossia 30 anni dopo le parole di Baker!) andai a San Francisco, alcuni confratelli che conoscevano la propensione iconoclasta o poco rispettosa delle forme e dei riti da parte di noi Italiani, mi raccomandarono di far bene attenzione a come parlavamo, con i fratelli Americani, di Suzuki Roshi “perché, dissero, qui in America è considerato alla stregua di un dio”. Ora Suzuki Shunryu, per quello che mi consta, era un brav’uomo e non approfittò di quella pericolosa situazione in cui tutto gli era permesso perché, per definizione, ogni suo atto, anche il più assurdo, essendo lui “roshi”, era di fatto un profondo insegnamento dharmico. Ma, alla sua morte, quando la palla passò ad altri (a cominciare proprio da Baker) immediatamente cominciarono gli abusi e continuano tuttora. Il perché, a mio parere, è abbastanza semplice.
In molti monasteri giapponesi (non in tutti), ma per esempio (certamente sino ad alcuni anni or sono) ad Eiheiji, i novizi venivano trattati a pugni e schiaffi quotidianamente alla minima manchevolezza, anche per uno sguardo sbagliato. Chi, in America prima ed in Europa poi, si è assunto il ruolo/compito dello Zen Master, ha trovato buon gioco a spadroneggiare sui corpi sulle menti e sugli averi dei propri seguaci/discepoli sia per la posizione da semidio in cui era posto sia per aver tradotto il comportamento visto in Giappone in termini di dispotismo all’occidentale. Dimenticando però due cose fondamentali:
1) Ad Eiheiji si usa (o si usava) la violenza NON perché è un monastero Zen ma perché la violenza è ammessa nel sistema educativo giapponese quasi in ogni ambito. Un esempio: a metà degli anni ottanta un preside di una scuola superiore giapponese, per punizione rinchiuse tre ragazzi della prima classe (15 anni) in un container, al sole, senz’acqua, per non ricordo quanti giorni. I ragazzi morirono. Però, il fatto più raccapricciante, per me, fu che i genitori (invece di aiutarli, chiamare la polizia, l’esercito, i pompieri) sostarono, sino alla morte dei loro figli, all’esterno del container, incoraggiandoli a resistere, ad accettare sino in fondo la loro punizione. Ecco quindi che se, per un assurdo che non auspico, anche in America, in occidente, quei sistemi fossero normali, accettati ed utilizzati come metodi educativi validi, molti dei casi classificati come abusi nei confronti dei discepoli da parte degli Zen Master non sarebbero neppure notati, perché usuale dialettica tra educatore e discente. Fortunatamente sta avvenendo il contrario: sono invece proprio i monasteri Zen, in Giappone, a mettere in discussione quei metodi al loro interno e nella società.
2) In occidente il termine Maestro, con i toni con cui è stato sin qui usato nello Zen, è stato attribuito, in ambito religioso, solo, o quasi solo a Gesù Cristo (o suoi epigoni). Attribuirlo di punto in bianco ad un pover’uomo che ha ricevuto, pronunciato i voti buddisti è crocifiggerlo alla sua carne.
In Italia, da un poco di tempo, sta succedendo qualche cosa di analogamente preoccupante. Non so perché, non so su suggerimento di chi, però è certo che a tutti i monaci buddisti, specialmente in ambienti vicini all’UBI (Unione Buddista Italiana), si attribuisce l’appellativo di “venerabile”. A mio modesto avviso, almeno per ciò che riguarda l’ambito dello Zen, è una degenerazione identica a quella dello “Zen Master”, un imitare un appellativo onorifico che in oriente hanno tutti, ciascuno nel suo ruolo, non solo i monaci. E’ porre in alto, per statuto, ciò che sta bene dove si trova, specialmente quando non si fa grande. Non solo. Negli ultimi tempi circola, riferito anche ai monaci dello Zen, un termine ancora più comico, se non fosse tragico: Maestro di Dharma. E pare che si voglia fare un elenco di persone che, per regola, possano fregiarsi di questo titolo. Un suicidio del buddismo Zen, in salsa italoamericana.
Prima di buttarsi a capofitto su questa strada, bisognerebbe tener conto che gli Americani, dopo essersi scottati severamente le dita, stanno facendo precipitosamente marcia indietro. Ci sono centinaia di pagine circostanziate in merito, in tutte le lingue. E non si tratta più, o solo, di lamenti più o meno interessati provenienti da insoddisfatti sulla strada che conduce a diventare maestro Zen: vi sono anche serissimi studi a livello universitario (cfr. l’accurata “History of the Soto Zen School” del prof. Griffith Foulk del Sara Lawrence College, ed anche “The Soto Zen School in modern Japan” del prof. Nara Yasutani, già preside dell’Università Buddista Komazawa di Tokyo e l’attento lavoro “Soto Zen in America” del prof. Jhon R. MacRae, della Indiana University).
Chiedo, per favore, a chi si occupa di queste cose: prima di fare un passo e sancire etichette, marchi difficilmente cancellabili, guardate alle esperienze di chi ci ha preceduto.
L’altro aspetto che ho citato all’inizio di queste righe, è quello della commistione dello Zen con le discipline più disparate, dalla macrobiotica alla pranoterapia, dai massaggi agli oroscopi cinesi, dall’agopuntura alla musica. Non intendo dire che queste cose siano estranee allo Zen. Intendo dire che stanno allo Zen come qualsiasi altra attività umana: allevare i bambini, fare l’impiegato alle poste, il bagnino o il parrucchiere. Non ha alcun senso parlare di “massaggi Zen”, “pranoterapia Zen”, “cibi o alimentazione Zen”, “musica Zen” ecc. Non esistono né mai sono esistiti.
Penso sia sotto gli occhi di tutti l’uso che i media, l’industria e la cultura stanno facendo dello Zen e del buddismo in generale, o meglio: della moda del buddismo e dello Zen. Ci sono decine di prodotti, per lo più di bellezza, che si chiamano “Zen”, varie pubblicità televisive per reclamizzare questo o quel prodotto usano immagini di monaci buddisti, creando o confermando accostamenti di significati estranei tra loro. La parola “Zen” è entrata nel linguaggio comune, in Francia ed America, come sinonimo di “cool”.
Di fronte a questa banalizzazione, distorsione, chi pone la propria vita nell’ambito buddista deve sentire una forte responsabilità a far sì che le proprie parole e azioni siano il più chiare possibili, mantenendo, difendendo se non i nomi (penso sia oramai tardi) almeno gli ambiti ed i significati. Per questo chiedo, a chi si presenta in qualche modo come “esponente” dello Zen, la serietà di chiarire gli ambiti in cui si svolge la propria vita per non ingenerare confusione. Vi possono essere monaci Zen che vivono facendo le cose più disparate, ma qualsiasi esse siano hanno a che fare con lo Zen non in quanto tali ma perché sono la vita di una persona la cui vita è lo Zen. Ossia se io, monaco Zen, sono anche educatore, terapeuta in una comunità per tossicodipendenti, l’essere tale, di per sé, non fa di questo un mestiere/attività connessa allo Zen. Lo è perché è parte della mia vita. Se pratico la pranoterapia, soprattutto perché questa è un’attività un poco misteriosa e sconosciuta ai più, devo essere ben attento a distinguere questa attività dal mio essere monaco Zen, per evitare sovrapposizioni o commistioni.
In ogni caso è bene sapere che, proprio per questi motivi, diciamo di contaminazione almeno nelle forme, la tradizione sconsiglia i fedeli di praticare attività legate agli aspetti più sottili dell’esistenza.
Anche se un consiglio è solo un consiglio, è bene vedere a fondo quale ne è l’origine e quali i pericoli (per sé e per gli altri) di fronte ai quali quel consiglio mette in guardia.
Mauricio Yūshin Marassi
Se volete, lasciate un commento.
You must be logged in to post a comment.