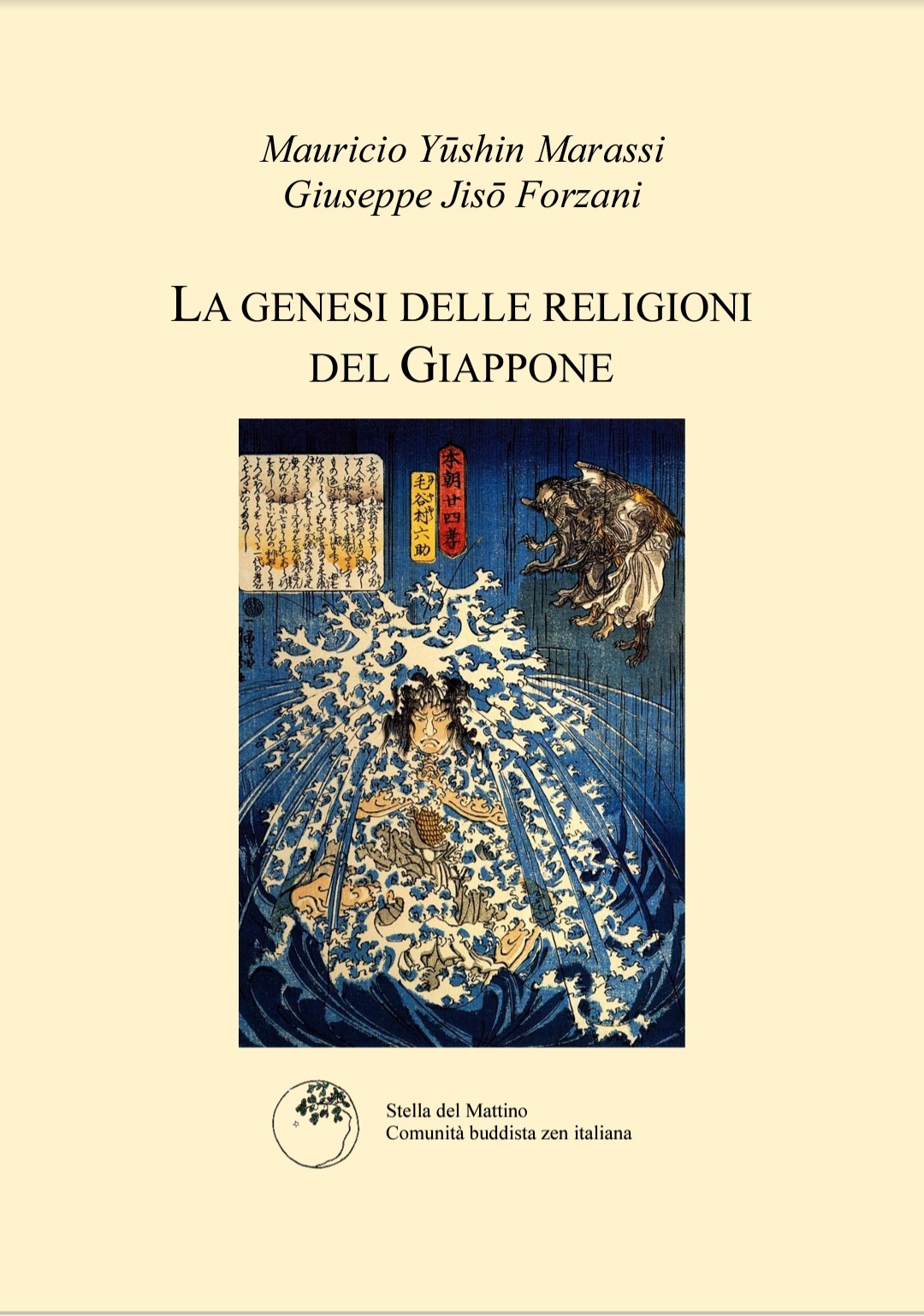Detto in altri termini, io mi occupo di buddismo perché il buddismo si occupa di me. Si occupa di me perché è la via che descrive (nel senso di tracciare e di esplicitare) il rapporto fra la totalità indiscriminata della vita che informa ogni vita e l’individualità discriminante di ogni vita che manifesta la vita. E’ l’indicazione a vivere ogni momento come forma della totalità e la totalità come espressa nel singolo momento: non c’è attimo che non sia espressione totale, non c’è totalità se non nella manifestazione di ogni attimo. La forma è vuoto, il vuoto è forma… Samsara è nirvana, nirvana è samsara…O, per stare alla metafora linguistica evocata dal titolo di questi incontri, l’alfabeto è il risveglio, il risveglio è l’alfabeto. L’alfabeto permette a una lingua (alfabetica) di dire tutto il dicibile in quella lingua, se tolgo anche una sola lettera quella lingua non sussiste più; ma una lingua non è solo la somma delle parole che la formano, così come una parola non è la semplice somma delle sue lettere. L’alfabeto senza significato è un’accozzaglia di suoni, il significato senza alfabeto è inespresso e perduto.
Allora, il buddismo si occupa di me perché io sono la materia del buddismo e nello stesso tempo il buddismo è per me materia (di applicazione, di indagine, di studio, di fede…): giochiamo ancora una volta col duplice senso della parola “materia” nella lingua italiana. Non è un esercizio di stile, un gioco di parole fine a se stesso, ma un’occasione, che a volte la parola ha il potere di esprimere, per sintetizzare il carattere formalmente ambiguo e sostanzialmente coerente della realtà: coerenza contraddittoria dell’esistenza.
Io sono l’oggetto di cui il buddismo si occupa e un soggetto che si occupa di buddismo. Ecco dunque il senso di considerare l’identità, nell’ambito di queste lezioni. Il cuore del buddismo è il rapporto fra la vita e la mia esistenza e il cuore di quel rapporto sono io: che cos’è questo io che sono?
Scrive Dogen, nel 1233: “Imparare [studiare, conoscere] la via di Buddha è imparare (conoscere, studiare) sé stessi (jiko)”. Che cos’è questo io, questo sé, questo jiko da imparare? Il buddismo non è forse la religione del non io, del non sé, anatta, anatman, muga… Perché allora si deve imparare qualcosa che non è? Ma poi, cosa vuol dire non io? Chi è che dice “non io”? Come posso “io” dire che io non sono? Io sono l’io che non sono?
Innegabilmente io sono. Comunque io chiami o non chiami il mio esserci, io comunque sono. E sono sempre: quando veglio e quando dormo, quando mi penso e quando mi ignoro, quando agisco e quando subisco, quando godo e quando soffro… non c’è discontinuità nel mio esserci. Altrettanto, non posso cogliermi nella globalità del mio esserci, solo nella particolarità contingente: la coscienza di sé è il principio della divisione e del passaggio dall’identità all’identificazione. Io identifico me stesso nelle particolarità del mio esserci: e così facendo mi trovo e mi perdo. Mi trovo perché mi riconosco identificandomi, mi perdo perché riconoscendomi scordo l’identità fondamentale. “Imparare se stesso, prosegue Dogen, è dimenticare se stesso”. La coscienza di sé è come uno specchio: mi riconosco in un’immagine di me che parla sì del mio esserci, ma riflette e dice solo un volto fuggente. Mi posso identificare in quell’immagine di me e in essa riconoscermi solo perché contestualmente scordo tutte le altre: guardando quell’immagine di me posso dire “io sono quello” solo perché le altre sono momentaneamente svanite. Il non essere ciò che non sono è costitutivo dell’essere ciò che sono. Nella lezione buddista troviamo sia l’indicazione a tenere costantemente pulito lo specchio, a pulirlo dalle immagini riflesse che mutano incessantemente e non sono mai il volto definitivo, a pulirlo dall’immagine precedente in modo che si possa rivelare la successiva, sia l’affermazione che non c’è nessuno specchio da pulire, perché la coscienza proietta comunque immagini relative e non c’è altro volto di me che non sia quelle immagini: invano cercherò lo specchio totale perché mi ha già trovato: è la mia vita stessa.
Anatta, muga, parla di un’identità incondizionata: l’io che non è, in quanto non è un ente, non si esaurisce in nessuna delle sue infinite identificazioni: il volto originario che non è né la somma né la sottrazione dei volti. Facciamo attenzione a non dare a quest’espressione un valore ontologico, a non fare del non io un super io o il vero io. Non io è l’indicazione a non far collimare idealmente identità e identificazione: a non fare di un’identificazione specifica la propria identità tout-court, a non cercare di identificarsi in una identità ideale. Un esempio, appropriato al contesto: se affermo “io sono un monaco buddista”, proposizione contemporaneamente totalizzante e rarefatta, sto descrivendo un’identificazione di me, un’identità costruita e in costruzione (identi-ficare, l’identità facentesi) che coesiste, coopera, confligge, con altre identificazioni di me (sono un maschio, sono di una certa età, sono italiano, sono marito, sono padre, ecc. ecc.). Essere monaco buddista non è tutto di me anche se dentro c’è tutto me stesso. Non io non vuol dire che io non sono i mille volti delle mie identificazioni, più o meno fittizie: vuol dire che nessuna di esse esaurisce la profondità, l’attualità e le possibilità del “io sono”.
Qui si situa l’importanza fondamentale del dialogo: il dialogo primario, quello da cui discendono tutti gli altri dialoghi, è quello fra le diverse identificazioni di me stesso fra loro e con l’idea di un’identità incondizionata (non io) che le anima. Il dialogo delle parti fra di loro e con la totalità che compongono e che le forma. Dialogo, non rapporto dialettico: non c’è un io dialogante con un tu che produce un noi, ma una “parola” (per mantenere il simbolo “logos”, ma preferirei “vita”) che attraversa e anima io, tu noi, ogni cosa. Non c’è io primario che genera o crea io derivati: il volto è ognuno dei volti. “Dimenticare se stesso è riconoscersi nelle diecimila forme, nei diecimila volti” per appoggiarci ancora a Dogen. Qui inizia e prende forma ciò che nel buddismo occidentale viene chiamato, con molta approssimazione, “pratica”: termine riduttivo e agglutinante, che dovrebbe tradurre svariate parole (pratipatti, adhyācāra, prayoga, yogācāra…) che la raffinatezza espressiva indiana ci ha tramandato e che indicano, con ricchezza di sfumature, l’applicazione e l’ottenimento, il dar inizio e il realizzare, l’impegno e la comprensione, il passo e la meta. Ciò che con una frase un po’ ad effetto potremmo chiamare “la pratica del risveglio che risveglia la pratica” in ogni circostanza della vita, e che si concretizza come cura verso il mio mondo, responsabilità verso la mia vita e il suo percorso, conversione incessante dall’egocentrismo alla dislocazione continua del centro.
Dogen conclude così questo famoso brano: “Riconoscersi nelle diecimila cose è considerare il proprio corpo e spirito (ego) e l’altro corpo e spirito (alter) abbandonando entrambi. Questo è il segno del risveglio senza il marchio del risveglio, l’assenza di traccia che fa proseguire senza fine il risveglio” (da Shobogenzo Genjokoan). Ciò che chiamo tu, non è che un alter ego: un tu che dice io in maniera diversa da me. Non ci sono due volti uguali, e a ben vedere neppure somiglianti: ma tutti dicono io. Se mi riconosco nei diecimila volti del mio volto, riconosco io anche nei diecimila volti di tu. La differenza è immutata, abissale, ma cade ogni distinguo ontologico fra io e tu. Il conflitto non ha base d’appoggio, superiorità e inferiorità sono sbuffi di vento. Una sola rinuncia è obbligata: quella a rimirare il mio io illuminato, a specchiarmi nella mia faccia bella. Lo specchio dell’ipocrisia religiosa è in mille pezzi, ogni frammento brilla di luce propria. Narciso non si innamora più solo del volto suo bello: amerà finalmente tutti i volti che brillano sul pelo dell’acqua.
Giuseppe Jisō Forzani
Se volete, lasciate un commento.
You must be logged in to post a comment.