Sab, 1 Gen 2011
Buon anno a tutti.
Più delle altre volte transitare per il primo gennaio mi ha fatto sentire intenso l’esser vivo. Il sentimento associato a questa consapevolezza non è stato di gratitudine, come a volte si dice dovrebbe essere, ma di … scuse. La pulsione a scusarmi d’esser vivo.
Dopo questo simpatico siparietto personale che va ad incrementare il già corposo capitolo Checceneimportannoi, iniziamo da dove ci eravamo lasciati. Se seguo il buddismo, gli insegnamenti del buddha per dirigere la mia vita, dovrei farlo anche (soprattutto?) in senso etico. In termini pratici concreti, che cosa significa? Dovrei seguire i 5, gli 8 o i 10 precetti? Conosco i precetti? Posso prescindere dai precetti? Se sì, perché? Se no, perché?
L’argomento, mi pare, riguarda i buddisti e tutti, non lascia fuori nessuno, anche chi non ha alcun legame con la religione: chiunque compie scelte probonus.
Un’occasione per proseguire la riflessione ce la offre un articolo comparso il 23 dicembre sulla prima pagina di La Repubblica col titolo Società plurale e morale comune che trovate qui in fondo. Era firmato “Angelo Scola, Patriarca di Venezia”. Ora, ho molto rispetto per i patriarchi in generale ma in questo caso penso valga la pena cercare il pelo nell’uovo, anche perché -a me pare- uovo pelosissimo è. Tralasciando i vagheggiamenti del Patriarca su un tempo in cui pare fosse possibile una “morale comune” o in cui fosse possibile parlare di una “percezione morale” (moral insight) per sua natura universale e propria di ogni uomo in quanto uomo, mi sembra degna di un buon cercatore di verità la frase: Importanti correnti del pensiero morale concordano nell’affermare che per cogliere l’autentica natura della morale si debba partire dalla esperienza elementare del bene che ogni uomo vive. Notiamo che se per sondare l’autentica natura della morale partiamo dall’esperienza dell’uomo, il bene in sé (e perciò il male in sé) cui dice di richiamarsi il Patriarca, subisce ontologicamente un duro colpo. Ma, soprattutto, da qui in poi cominciano i problemi…
Dice infatti il Patriarca: Se si guarda alla genesi di questa esperienza morale, ci si rende conto che essa si radica in un desiderio di compimento di sé¸ che prende forma dalla promessa suscitata dalle inclinazioni e dagli affetti originari. A partire dalle relazioni primarie di riconoscimento reciproco con la mamma e il papà, il bambino, mediante la parola, acquista coscienza pratica di se stesso e diventa capace di apertura e comunione con gli altri. Assegnare come unica motivazione della genesi dell’esperienza del bene in ogni uomo la spiegazione psicanalitica del riconoscimento reciproco con i genitori tramite la parola sulla base degli affetti originari è limitante, culturalmente scorretto, religiosamente impoverente ecc. ecc. Un sordomuto orfano dalla nascita (facciamo subito un caso limite così risparmiamo tempo) sarebbe privato di ogni possibilità di sperimentare il bene, secondo gli angusti limiti posti dal Patriarca. Il salto successivo -un salto mortale carpiato- porta dal bambino in dialogo affettivo con mamma e papà alla parabola evangelica di Gesù ed il giovane ricco, ascoltiamo ancora il Patriarca: … e comunione con gli altri. A questo proposito il dialogo tra Gesù e il giovane ricco raccontato dal Vangelo è particolarmente significativo anche a una pura lettura razionale perché vi possiamo trovare conferma della triplice scansione dell’esperienza morale elementare: desiderio-riconoscimento-comunione. Il giovane ricco si avvicina a Gesù e chiede: «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?». Accogliendo la domanda, Gesù gli risponde: «Dà ai poveri». Lo invita cioè a riscoprire la decisività del nesso tra il bene e la relazione. Il desiderio di compimento che anima il giovane ricco si realizza, dunque, in questo riconoscimento che apre a una vita comune, condivisa: è questa la forma originaria dell’esperienza del bene e la verità antropologica della moralità. Se i comandamenti sono la via al bene, il principio della moralità è il bene stesso. Ed è nella relazione che questo si rivela primariamente. Del bene si deve fare esperienza perché il desiderio di bene trovi la via della piena attuazione. Qui troviamo le maggiori criticità: secondo il Patriarca, Gesù, dicendo al giovane ricco di donare tutto ai poveri lo invita a riscoprire la decisività del nesso tra il bene e la relazione. In pratica il dono dell’affetto ricevuto dai genitori nel quale si è scoperto esistente nella raggiunta comunità tramite la parola viene riprodotto nell’atto di donare ai poveri, quindi: conferma della triplice scansione dell’esperienza morale elementare: desiderio-riconoscimento-comunione. Infatti: Il desiderio di compimento che anima il giovane ricco si realizza, dunque, in questo riconoscimento che apre a una vita comune, condivisa. Il ghiaccio si fa sempre più sottile: il “giovane ricco” cercava la vita eterna, il massimo del massimo, non pannicelli caldi quali vita comune, condivisa. Nel Vangelo, in realtà, Gesù prova prima a dissuaderlo: «… fai il bravo, segui i comandamenti, dai…» ma il giovanotto insiste. Allora Gesù gli dice vendi, regala e seguimi, non gli dice di spupazzarsi i bambini un po’ mocciosi dei poveri beneficiati, gli dice di spogliarsi del suo sia in quanto cose (dona!) sia in quanto vita (seguimi!). In quel caso, con tutto il rispetto, Gesù ai poveri (qui totalmente astratti) o meglio: alla relazione con loro, non ci pensava proprio, pensava al giovane ricco. Altrimenti quando il giovanotto invece di donare tutto si allontana avrebbe dovuto tentare di trattenerlo, di mercanteggiare: «Magari tutto no, ma almeno vendi la casa al mare, che la usi poco…». Invece (be’, è figlio di Dio, non sarò io a doverlo ricordare…) sapeva già come sarebbe andata a finire: il giovanotto voleva diventare (come) Dio; per poter agguantare il premio avrebbe dovuto superare prove disumane: spogliarsi completamente dell’umano. Sport per minoranze, tant’è che conclude con occhio clinico il Nazareno: «…è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli”. A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: “Chi si potrà dunque salvare?”. E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: “Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile”». Si sa: solo (uno come) Dio può compiere atti veramente disumani.
E i poveri? Con buonapace del Patriarca Scola, quelli, poveracci, benché compatiti ecc. ecc. come sempre son lontani dalla torta, altrimenti non sarebbero più “i poveri”… Ed è giusto così: se “il bene” è nella relazione, nella fattispecie nel donare ai poveri, in assenza di poveri (o di ricchezze da donar loro) il bene scomparirebbe, non sarebbe più “il bene”.
Morale della storia: anche in una religione in cui, tutto sommato, l’etica dovrebbe essere problema semplice (i 10 comandamenti sono stati redatti direttamente da Dio; durante qualunque predica il sacerdote con competenza assicura che Dio vuole questo o quello da noi…; è data per certa l’esistenza del bene e del male in sé) si brancola in modo ancor più incerto che altrove, e per di più occorre anche rispondere contemporaneamente al dogma del bene/male in sé, alla razionalità, all’esperienza comune, alle smanie dei patriarchi…
23 Commenti a “Mt 19; 16-26”
Se volete, lasciate un commento.
Devi essere autenticato per inviare un commento.


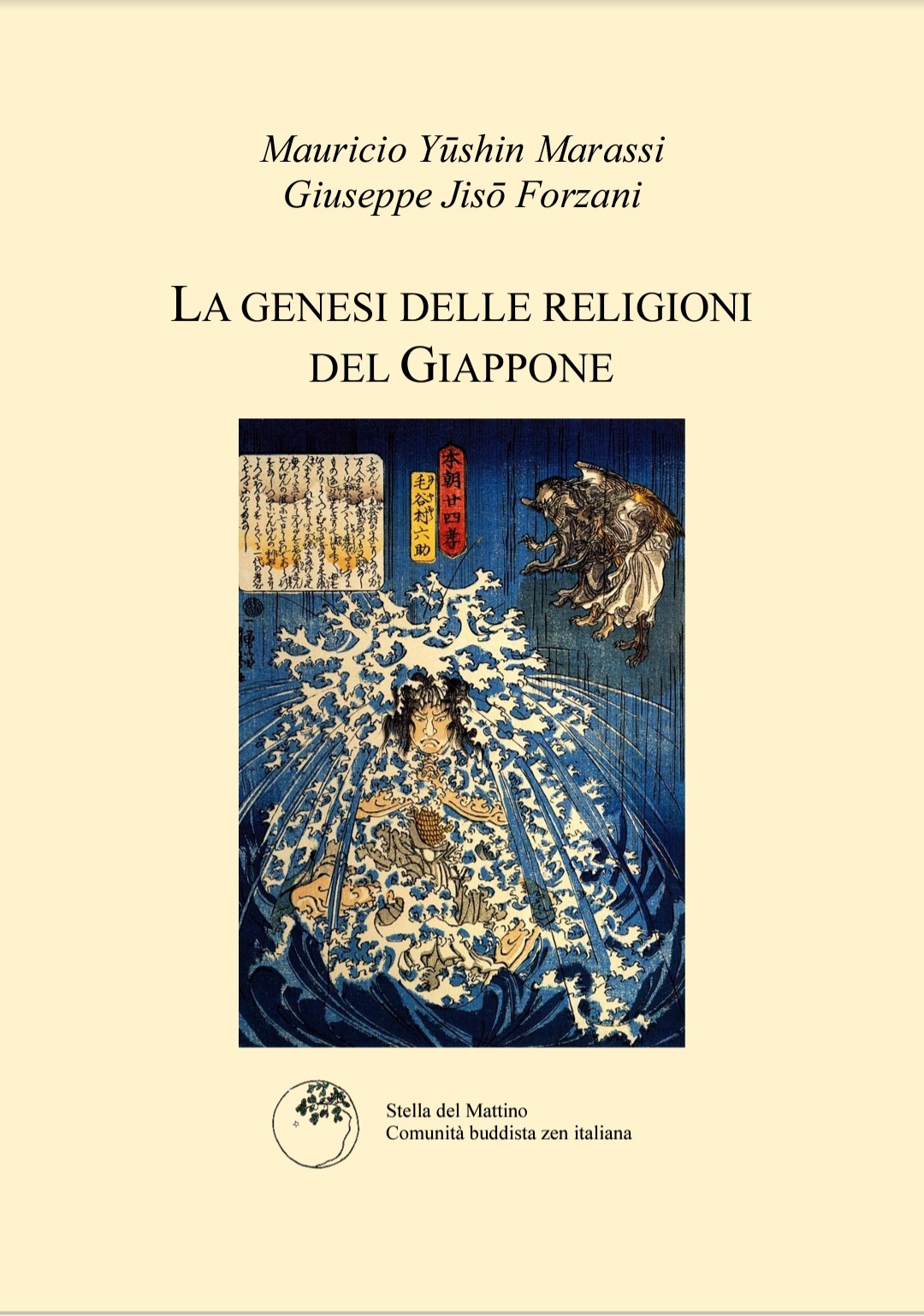






1 Gennaio 2011 alle 11:03 pm
Ho apprezzato i tuoi rilievi e vorrei aggiungere qualcosa.
Intanto su Scola va detto che è molto vicino a una organizzazione paramassonica come Comunione e Liberazione (di cui ci si può chiarire il portato nell’ottimo saggio di Ferruccio Pinotti “La lobby di Dio” chiarelettere editrice, 2010). Questo perchè costoro, Scola incluso, sono l’apoteosi del relativismo che indicano come limite per accedere al divino in visione cristiana.
Come si evince dall’articolo del cardinale (anche citando Papi e studiosi), esordisce con una forte critica al relativismo per concludere con altrettanto relativismo.
In sostanza, la Chiesa, condanna a parole il relativismo per prodursi nel relativismo più bestiale.
Il tipo di “relazione” che spingono personaggi come Scola, Tettamanzi, Bertone, e compagnia, sarebbe disintegrata da un reverendo saggio e onesto come padre Ernesto Balducci per esempio.
Il loro dramma è che non sono autentici rispetto a ciò che dicono di professare, sono l’apoteosi del relativismo che additano. Somigliano sempre di più alla massoneria…Giano bifronte…l’ossimoro come dialettica…stanno integrando Lucifero direbbe Jung.
2 Gennaio 2011 alle 11:06 am
Ciao Nello, son contento tu abbia evidenziato il trucco del relativismo negato con una mano (quello degli altri) per far spazio al “nostro” quello vero, quellobbono. Mi chiedo spesso che cos’hanno nella testa, nel cuore queste persone. Pensavo si trattasse di supponenza (variante antipatica dell’ignoranza), speriamo non sia peggio. Per Balducci… ci sentiamo più avanti.
2 Gennaio 2011 alle 11:15 am
Ho letto a suo tempo l’articolo del Patriarca e l’ho riletto ora: tanto la prima quanto la seconda lettura mi hanno lasciato interdetto, non tanto per l’ansia “mondana” del Patriarca di cercare un’impostazione del problema del bene e del male condivisibile anche da chi non si riconosce nella visone cristiana del mondo e della salvezza (egli è pur sempre un pastore di anime e un pescatore di uomini, e in quanto tale usa esche per prendere i pesci e va in cerca delle pecorelle smarrite) quanto per l’ignoranza “religiosa” con cui tratta la parola evangelica. E dico ignoranza nel senso di non tener conto del significato primario della parabola che lui stesso ha scelto. E’ veramente impressionante rilevare come un Patriarca cattolico si serva proprio di una delle parole più radicalmente esplicite e crudamente non fraintendibili di Gesù sull’alterità dell’atto religioso salvifico rispetto a qualunque dialettica umana (impossibile presso gli uomini, possibile solo presso Dio) per architettare una morale tutta antropologica della relazione in cui il moto impossibile e necessario dell’abbandono totale (lascia tutto e seguimi) è svenduto come la “proposta” di intavolare “un’altra più impegnativa relazione”. Là dove persino i discepoli diretti di Gesù, gente che appunto aveva tutto lasciato per seguirlo, sbalordiscono, il Nostro impavido non si scompone, cancella Dio e organizza un simpatico simposio: Buoni di tutto il mondo, unitevi! Sulla pelle dei poveri che in un mondo ormai senza paradiso fanno le veci dei dannati dell’inferno: là sono, là restino ad attendere la nostra caritatevole relazione, cosicché noi si possa aver conferma della nostra intrinseca moralità. Un ricco che fattosi povero continua ad aver bisogno dei poveri per sentirsi ricco anche da povero non mi pare granché più che una presa in giro della povertà, sia umana e schiavizzante che religiosa e salvifica. Ma i contorcimenti patriarcali non mi pare ci facciano procedere granché nella nostra ricerca: che anche gli amministratori della parola di dio siano alla frutta non è certo consolante: mal comune mezzo gaudio è la più amorale delle formule.
2 Gennaio 2011 alle 11:22 am
Anche jf paventa un’impressionante ignoranza (la santa ignoranza? :P) del Patriarca. Nella “morale” che vi ho propinato in fondo al mio lungo interloquire oltre al -nel senso di: “al di là del”- mal comune mezzo gaudio, intendevo dire: la ricerca dell’etica è strada impervia anche in quel dei cristiani, dove -si sa- il Buono, il Bene è chiaro: è ciò che si trova in accordo con la volontà di Dio, e viceversa. Pur in presenza di schiere di fini conoscitori del pensiero del Capo la saponetta continua a sguisciare di qua e di là
2 Gennaio 2011 alle 6:43 pm
Penso che
1)Vi è una percezione morale universale? forse “non tutti i cigni sono bianchi”, ma molti studiosi, anche laici, concordano su questa tendenza-possibilità fondamentale dell’umano.
2) Perchè contrapporre il bene “in sè” al bene in relazione? Nagarjuna direbbe che il bene si realizza nei beneficiati, e poi molti cristiani, teologi e non, hanno fatto del bene come relazione il fondamento della testimonianza cristiana.
3)Il linguaggio è certamente ciò che caratterizza l’uomo rispetto agli altri viventi, esso è uno spazio di possibilità ulteriore che l’uomo apprende da altri uomini: i geni non danno luogo ad una trasmissione cieca, ma sono una condizione di possibilità che interagisce con la dimensione culturale(spazio da cui si può realizzare il bene);
il linguaggio inoltre è il luogo in cui prende forma la prospettiva della fede, qualunque essa sia.
Non mi entusiasmano né Scola né molti altri sepolcri imbiancati ma la carità concreta (bene in relazione), pur non essendo esclusiva di nessuno, si realizza ogni giorno grazie al contributo silenzioso di molti cristiani
2 Gennaio 2011 alle 7:27 pm
La morale ha bisogno della consapevolezza, ma non basta. E’ anche sforzo, continuo e costante, di aggiustamento. Possiamo raggiungerla di volta in volta grazie all’attenzione, alla passione e all’impegno.
Un antico maestro cinese portava un bue fra i monti. Gli chiede il doganiere al valico: «Cos’è la tua Via nel profondo?»
«Tirare il bue, quando va a destra, a sinistra e, quando va a sinistra, a destra e andare diritto».
2 Gennaio 2011 alle 7:48 pm
Ciao Dario. Spezzo volentieri una lancia a favore della carità concreta: senza mi mancherebbe una parte considerevole del percepirmi morale. Anche la morale del bue ha la mia adesione, certo (ciao Louis). A costo d’esser noioso richiamo però l’attenzione sul tempo nel quale non vi è carità da render concreta e sul fatto che, per andar diritto, occorre idea di “diritto” (ovvero: di “destra” e “sinistra”). Mi interessa molto la considerazione che, la morale, è “anche sforzo, continuo e costante, di aggiustamento”, questo implica però che stiamo sempre sbagliando, altrimenti perché l’aggiustamento?
2 Gennaio 2011 alle 8:30 pm
Se bastasse ogni volta applicare “rigidamente” principi astratti non ci sarebbe bisogno di aggiustamenti.
2 Gennaio 2011 alle 8:39 pm
È vero. Questo è il caso dei principi etici cinesi (che però non definirei astratti. Decisi dall’uomo, comunque), vi è un modello base o ordine naturale e a quello ci si adegua. Così, parlando in generale, per Confucio il comportamento personale va uniformato ai riti/etichetta-globale e la relazione interpersonale è sottoposta al modello padre-figlio che nella realtà diventa superiore-inferiore. Poi vi è il “modello (base)” secondo il daoismo che è l’assecondare, quello legista che è “seguire la norma/legge” ecc. ecc.
Tuttavia l’Occidente si è mosso su altre piste, che si aggirano attorno alle “idee universali” o alla morale intrinseca all’essere uomini. Per esempio nel donare si percepisce (sempre? Tutti?) un bene che pone il donare tra gli atti morali universali…
2 Gennaio 2011 alle 8:47 pm
Concordo con Louis8
Il senso del bene è bene in relazione e bene in sé: il primo è rapporto vivo con il qui e ora, il secondo è il senso, la direzione verso cui tende il qui e ora che tenga conto di questo senso; possiamo dire che fede e bene non sono oggetti che ingessano il reale ma aperture di senso che interrogano l’umano che li riconosce?
2 Gennaio 2011 alle 9:39 pm
Se la morale, come dice Dario, è un “tendere verso”, l’aggiustamento di cui parlavo sarebbe il timone da assestare continuamente lungo la rotta o, se preferite, la capacità di scegliere il “giusto mezzo”, adeguato alla nostra natura, quale è determinato dalla nostra ragione e dalla nostra volontà.
3 Gennaio 2011 alle 1:05 pm
Per prima cosa, buon anno a tutti.
Magari dico una cosa banale sul vivere da Buddhisti e sul bene e male. Buddha disse (o chi per lui scrisse): “questa dottrina è inaccessibile alle costruzioni concettuali”.
Poi, Doghen nel Fukanzazengi: “Hai già il fulcro della via che è il corpo umano…”.
Non basta questo a definire cosa è “bene” e “male” ?
Proteggere il proprio corpo (cibi sani, vita regolare, ecc…) e dare incessantemente e gratuitamente (non imporre) ad altri la possibilità di proteggere il proprio corpo (carità, aiuto, beneficienza, sostegno, ecc…), non è già questo il “bene” ?
Quando manca una delle due cose, “siamo nel male”, e tornare sempre a questo è bene.
Uhm…la sto facendo troppo semplice ? Oppure posso già mettermi un sandalo in testa ?
3 Gennaio 2011 alle 6:44 pm
Ciao ryokan, sandali in testa anche due se vuoi, poi vai su e giù per le scale del condominio e… 🙂
Il fatto è che se dici “inaccessibile alle costruzioni concettuali” e poi metti giù uno schema (la cura del corpo per esempio) ti pesti la coda.
Dario e Louis sono fini filosofi e hanno ragione nel loro argomentare. Pare però che parlino di che cosa sia onon sia “il bene” piuttosto che di come si decide, si sceglie nelle mille azioni della vita (che non implicano tutte relazione e che implicano relazioni da scegliere, in alternativa).
3 Gennaio 2011 alle 8:43 pm
La questione del bene mi ricorda la questione del Tempo in Agostino: tutti sanno che c’è ma nessuno riesce a definire in assoluto che cos’è.
Come “aspirante buddista” mi “accontenterei” di realizzare le “tre menti”, gli “atteggiamenti spirituali che contengono valore”(cito ‘E se un dio non ci venisse a salvare?’ cap 5). Per me questo è bene
3 Gennaio 2011 alle 9:58 pm
Be’, se ti accontenti di “serenità, pace interiore, tranquilla allegria, calore umano” allora…
😉
4 Gennaio 2011 alle 11:13 am
Dario 14: penso che l’ambiguità insita sia nel concetto di etica (e del suo equivalente semantico “morale”) sia nei vari “bene”, “senso del bene”, “bene in sé” abbia bisogno di chiarezza, a partire proprio dal popolo buddista occidentale: nato in una cultura religiosa “per benista” basata sul senso di colpa e che ora sguazza in un mare in cui si incontrano śīla (profondamente diverso da “etica”), “etica” (la parola non c’è in cinese) confuciana, daoista, legista ecc. Senza un chiarimento (solo apparentemente) linguistico parlare di etica buddista è come parlare del tempo per un Agostino buddista: (quasi) tutti pensano che ci sia, (quasi) nessuno sa dire dov’è, che cos’è ecc.
4 Gennaio 2011 alle 12:06 pm
Tra l’altro, non so se vi siete accorti che su questo sito è apparsa la pubblicità (a pagamento!) in tre “finestre”: una qui sotto, due a destra più in alto. Però prima ci siamo messi a vento: il vaticano dice che è tutto regolare… 😎
4 Gennaio 2011 alle 4:03 pm
Rigirando il pensiero sull’ argomento in questione mi sono imbattuta in questa domanda che probabilmente sarà sottesa a tutto ciò che è stato detto finora: perché un buddista sceglie di fare il bene?
E’ facile rispondere ( credo ) per chi è all’ interno delle religioni tradizionali dove il bene può essere visto come necessaria risposta alla volontà di Dio. Ma per un buddista?
4 Gennaio 2011 alle 4:03 pm
E sul come…
Ho provato ad ‘osservare’ come avvengono le mie scelte all’ interno di una normale giornata. A dir la verità non mi pongo normalmente la questione ‘sto facendo il bene o sto facendo il male’, ma semplicemente ‘cerco’ di fare ‘bene’ ciò che devo fare ( che poi ci riesca ..bè quella è un’altra questione!)
Mi sembra di poter dire che l’ unico criterio concreto che ho ravvisato ( sia nelle relazioni interpersonali che nei vari lavori ) è la necessità di essere ‘presente’ a quello che sto facendo.
E poi … c’è tutto il resto.
4 Gennaio 2011 alle 4:38 pm
Ciao Marta, bentornata. Chiedersi il perché scegliere di fare o non fare il bene è basilare, quantomeno per poter capire che cosa ciascuno di noi intenda con “bene”. Essere presente, dici, può essere fine a sé stesso o “al fine di”. Fare bene ciò che si fa (anche nel fare il male secondo me val la pena di cercar di farlo bene) è già una scelta di bene, lascia ancora aperta la domanda “perché?”.
6 Gennaio 2011 alle 8:18 pm
MYM 16-Sul bene in sè nel buddismo: non avendo competenze per un analisi filologica tento con gli strumenti che ho.
Tra nichilismo e eternalismo: già l’indicare la possibilità di liberazione dalla sofferenza è una indicazione di bene, poi l’ottuplice sentiero, le tre menti, le parole contenute nei sutra sono indicazioni “linguistiche”, segnali indicativi di una via “benefica”.
Affermare che cos’é bene, esattamente, nella realtà è complesso, la stessa azione di uccidere la possiamo considerare un male nonostante in alcuni casi sia il male minore =bene: per cui nella realtà decidiamo di volta in volta che cos’è bene.
Quindi “in astratto” -bene in sè- direi che è ciò che si contrappone al male (in relazione a persone o all’ambiente), in concreto è l’applicazione contingente dell’astratto.
Linguisticamente direi quindi che non possiamo affermare (e indicarlo) assolutamente che “c’é”, né che non c’é, né che c’é e non c’é, né che né c’é né non c’é
Ps nell’ideogramma cinese “Virtù” l’indicazione è seguire la via del”cuore”: perciò non riesco a svelare l’ambiguità 🙂
6 Gennaio 2011 alle 8:25 pm
Ciao Dario. Quello su cui sto ragionando parte dal presupposto che occorra una ridefinizione del senso di etica nel buddismo. Non per metterla giù una volta per tutte, sarebbe una fregatura antibuddista, quanto per giungere ad una impostazione condivisibile del “problema”. Che metto tra parentesi perché anche l’esistenza o meno di un problema dovrebbe far parte di questo lavoro di definizione. Intendendo con questa parola non più che un metodo.
7 Gennaio 2011 alle 11:43 am
Mi pare di poter dire che il presupposto che occorra una ridefinizione del senso di etica nel buddismo si basa a sua volta su un precedente presupposto (che il senso dell’etica nel buddismo così come è attualmente concepito sia insufficiente, inadeguato, inefficiente) il quale a sua volta si basa sul presupposto che il senso dell’etica nel buddismo sia un quid necessario (altrimenti perché occorrerebbe ridefinirlo?). La domanda potrebbe quindi essere: perché è necessario il senso dell’etica nel buddismo? Penso che la risposta debba essere, almeno inizialmente, di natura soggettiva: perché per me, che mi dico buddista, lo è. Se per me, che mi pongo la domanda, la domanda stessa fosse priva di senso, la questione non si porrebbe. Se invece la questione per me si pone, allora la domanda diventa: perché ha senso cercare il bene (prima ancora di cercare di dire che cos’è)? Risponderei: perché ho fatto e faccio esperienza del male (sia di quello che ho fatto e faccio, sia di quello che ho ricevuto e ricevo). Ed è un’esperienza “indiscutibile”, come il caldo e il freddo – prima si fa e poi se ne ragiona. E siccome il male fa male, a me a agli altri, cerco il bene. Non è forse da qui che conviene partire?
PS. Certo che fa un po’ impressione scrivere con davanti agli occhi il monito continuo che “dio mi ama”! Coloro che amo io li riprendo e li castigo, dice da qualche parte la Bibbia…