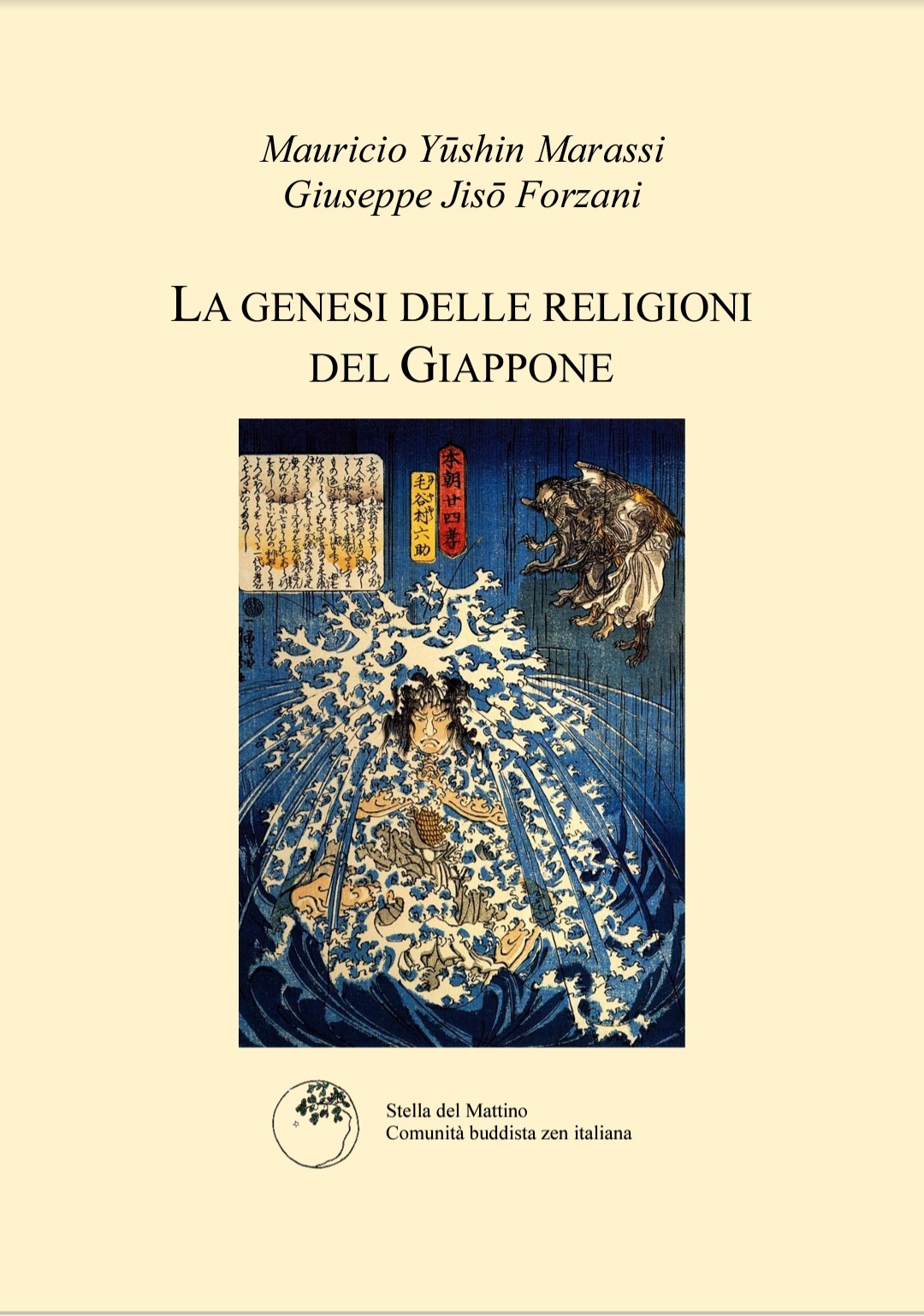Dom, 3 Set 2006
Quella che segue è la versione scritta dell’intervento di Giuseppe Jiso Forzani al convegno interculturale sul tema “La religione nell’era della tecnica” svoltosi, in occasione del Vesak[1], a Torino, venerdì 12 maggio 2006.
Nel poco tempo che ho a disposizione, sia perché siamo in ritardo con il programma sia perché devo necessariamente prendere un treno che non mi aspetta, cercherò di mettere in risalto due questioni che mi sembrano oggi particolarmente rilevanti in relazione alla realtà del buddismo in Italia. Mi scuso per l’approssimazione che la sintesi porta inevitabilmente con sé, ma credo che, dopo le esaurienti relazioni che abbiamo ascoltato finora, un intervento breve non sarà sgradito al pubblico.
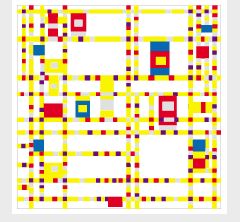
La celebrazione del Vesak in Italia è un’occasione di incontro, tanto delle diverse tradizioni buddiste presenti nel nostro Paese fra di loro, quanto con la cultura e la religiosità storicamente predominanti in Italia e costitutive della sensibilità più diffusa. Vorrei sottolineare questo aspetto, perché mi pare vada posto in risalto, più di quello relativo alla celebrazione di una festività buddista. E’ infatti opinabile che i buddisti abbiano festività da celebrare: quando ciò accade nei paesi dove il buddismo è religione popolare, succede più che altro in omaggio alla cultura e al folklore indigeni, per venire incontro a sentimenti devozionali e alla ciclicità di scansioni temporali ricorrenti: tutte cose comprensibili e legittime, ma che non hanno direttamente a che fare con il buddismo che, in omaggio all’indicazione di Śākyamuni Buddha, raccolta da tutte le tradizioni posteriori, di non considerarlo mai un oggetto di culto e di fede, non ha nessuna ricorrenza da celebrare o di cui far memoria in riferimento al “fondatore”. Inoltre, il Vesak in quanto festa ricorrente celebrativa non è universalmente riconosciuto nei paesi dove il buddismo è quantitativamente significativo: in Giappone, il paese dove il buddismo mahāyāna ha la maggiore diffusione percentuale al mondo, il Vesak è festività sconosciuta. A livello popolare ci sono celebrazioni della nascita e della morte (entrata nel nirvana) di Buddha, ma in date separate, mentre nei monasteri si ricorda il Risveglio in un’altra data ancora: la festività dei tre momenti raggruppati in un’unica data celebrativa è ignota alla tradizione buddista giapponese.
Il senso dunque dell’incontrarsi in quest’occasione non è per me quello di una comune celebrazione identitaria, quanto quello appunto dell’incontro: fra coloro che si scoprono e riconoscono buddisti, in modi spesso molto differenti fra loro, e con coloro che vedono il buddismo con interesse e curiosità, dall’esterno di un interno, come chi veda entrarsi in casa una realtà forse inattesa ma con cui non si può evitare di confrontarsi.
Ho ascoltato con estremo interesse gli interventi fin qui succedutisi e mi si è rafforzato un convincimento: che noi (buddisti, intendo) dobbiamo concentrare una buona parte dei nostri sforzi intellettuali verso la formazione di un linguaggio che sappia esprimere con sufficiente naturalezza nella nostra lingua concetti che ci sono stati finora comunicati da linguaggi molto diversi dai nostri (sanscrito, pali, cinese, coreano, tibetano, giapponese…). Ho notato una volta di più una sproporzione espressiva che va necessariamente poco a poco colmata, pena la mortificazione di ogni dialogo: è come se, di fronte all’interlocutore che parla in italiano della propria tradizione di pensiero, sia essa filosofica, scientifica o religiosa, con la profondità e la potenza espressiva che secoli di famigliarità gli consentono, noi balbettassimo ancora parole prese a prestito. Il nostro lessico risente ancora in maniera proporzionalmente eccessiva della dipendenza dalle lingue orientali: è un dato di fatto, di cui si deve prima di tutto prendere atto. Un linguaggio, per essere davvero espressivo e comunicativo, non può limitarsi a una terminologia teoricamente corretta: una lingua non è fatta solo di termini ma soprattutto di parole vive, che devono avere il loro incarnato e colorito. Non dovremmo dunque accontentarci di ripetere frasi fatte o espressioni libresche, ma, studiando e scrivendo, leggendo e parlando, concorrere alla formazione di un linguaggio ricco, di un’espressività consona alla nostra sensibilità: solo così riusciremo a dire ciò che abbiamo da dire e a far ascoltare ciò che vale la pena di essere ascoltato. Questa mi appare oggi una priorità.
Su un secondo punto vorrei portare la vostra attenzione, più direttamente collegato, questo, col tema proposto. Nel regno della tecnica, di cui abbondantemente si è parlato, c’è un aspetto cui noi buddisti dobbiamo fare particolarmente attenzione. Le pratiche religiose che le varie tradizioni buddiste orientali hanno custodito e oggi propongono in occidente, possono essere non di rado facilmente fraintese come tecniche funzionali al conseguimento di particolari risultati. L’oriente, e il buddismo in particolare, sarebbe in possesso di tecniche (di meditazione, concentrazione, introspezione psicologica…) efficaci per ottenere buoni risultati: benessere psicofisico, sollievo spirituale, aumento dell’attenzione e della presenza mentale… Credo che questo sia un elemento che contribuisce in maniera non marginale al “successo” del buddismo in occidente: il trionfo della tecnica religiosa come uno dei tasselli del dominio universale della tecnica.
Niente da obbiettare ai buoni risultati: se una cosa fa individualmente bene, senza effetti collaterali dannosi a sé e agli altri, non si vede perché non farla. Ma questo non c’entra nulla col buddismo e con la religione. Pur mantenendo le caratteristiche che sono proprie di ogni tradizione, ritengo sia della massima importanza che il buddismo non si presti a un simile fraintendimento. La religione è la rottura dello schema intenzionale “mezzo per un fine”, è apertura incondizionata senza manipolazione. Ci sia o meno un riferimento trascendente nel patrimonio genetico di una religione, ciò che distingue il fenomeno religioso da tutti gli altri è proprio e solo questo: la rinuncia a qualunque controllo sugli eventuali risultati ed effetti, la dismissione di ogni atteggiamento utilitaristico.
C’è un’immagine che in questo periodo mi pare esprimere in modo non inappropriato il carattere della religione, l’immagine, resa attuale dalla contingenza, del disarmo. Intendo dire che la religione, nel suo aspetto più intimo, peculiare e essenziale, è in sé disarmo, resa incondizionata, unilaterale – non però al nemico, al vincitore, al più forte, dopo la sconfitta. Quale che sia il riferimento “ultimo” di una fede (Dio, Nulla, Cosmo, Natura, Assenza o non attribuzione di riferimento ultimo…) il dato che caratterizza il fenomeno religioso è proprio l’abbandono incondizionato a “quella realtà” – tutte le religioni sembrano concordare almeno su questo punto. Qui non c’è spazio per la mentalità tecnica, che non può prescindere dalla ricerca dell’ottenimento di un risultato.
Credo che questa sia la peculiarità della religione, ciò che contraddistingue il fenomeno religioso: la religione ci indica un percorso e ci dimostra un’esperienza in cui il disarmo non è il segno della sconfitta, ma una scelta di vita e di libertà, la finestra su un modo nuovo di concepire se stessi e la relazione con gli altri.
La religione (qui, il buddismo) ad altro non serve: tutto il resto, la cura del mondo, l’avventura del pensiero, la relazione fra gli esseri, la scoperta del vecchio e del nuovo, conviene lasciarlo alle varie discipline delle tante culture umane. Che di queste materie pretenda occuparsene la religione è solo il segno della cattiva coscienza dei religiosi e della loro radicale sfiducia nell’uomo.
Il carisma della religione è il tutt’altro dal mondo: non perché ci sia un altro mondo, ma perché la religione è la funzione non mondana nel mondo. Questo e nient’altro le religioni raccontano.
Il buddismo, pur essendo una delle religioni più antiche, è oggi in occidente una nuova religione: forte di questo paradosso, deve trovare il modo di rinnovarsi senza perdere la sua antica natura. Guai se per essere up to date, al passo con i tempi, il buddismo mantenesse le forme antiche e assumesse una nuova natura: sposando cioè la causa della tecnica, fornendole nuovi alibi sotto forma di antiche pratiche orientali. Il senso della presenza del buddismo in Italia e in occidente è esattamente l’opposto: testimoniare lo spirito religioso di disarmo, rinnovando, nell’incontro con la tradizione di pensiero occidentale, le antiche forme orientali.
Nella generalizzata eccitazione per la tecnica che tutto pervade, anche la religiosità occidentale sembra smarrire la propria vocazione originaria: la religione si riveste di etica, sociologia, politica, pedagogia… e si dimentica di se stessa. Guai se il buddismo si accodasse al generale andazzo, limitandosi a fornire qualche strumento in più, magari fascinosamente esotico, per assoggettare ulteriormente l’ambito spirituale al dominio della tecnica.

[1] In India in epoca tarda, forse a partire dal settimo secolo, e poi dal tredicesimo secolo in Tibet, si è cominciato a ricordare con una cerimonia il giorno del risveglio. Che secondo alcuni dovrebbe essere il giorno del primo plenilunio da quando il sole entra nella costellazione dell’ariete. Tuttavia, in Giappone si prolunga il sesshin (ritiro) di inizio dicembre per farlo terminare a mezzanotte e un minuto del sette dicembre perché si pensa che il risveglio del Buddha sia stato all’alba del giorno otto. Sempre in Giappone a metà febbraio si legge il “Sutra del Nirvana” per ricordare il trapasso di Sakyamuni: paese che vai usanza che trovi. In Italia (ora anche in Europa) viene celebrata la ricorrenza chiamata Vesak, dalla parola tedesca wesak modellata sul termine pali vesākha (sanscrito vaisakha) che vuol dire “ariete”. In Italia tale celebrazione comprende tutto: nascita, risveglio, nirvana. A parte il gusto occidentale per le feste religiose, è un modo per far sì che, una volta all’anno, le varie scuole buddiste si trovino tutte assieme.
Se volete, lasciate un commento.
Devi essere autenticato per inviare un commento.