Dom, 5 Apr 2009
Mi scuso. Il conflitto d’interessi -seppur di moda- vorrebbe mi astenessi. Pubblicare una scheda di approfondimento di un mio libro non è il massimo dell’eleganza, quantomeno. Ma così van le cose del mondo. JJ ha approntato una scheda del mio ultimo, un lavoro veramente faticoso (il suo) se pensate che per redigere la scheda ha letto due volte questo libro sulla Cina. Ne è uscito un lavoro accurato, forse un poco encomiastico ma estremamente utile per chi voglia sapere, capire -magari senza leggerle- che cosa contengono le 400 pagine di quel testo.
Dopo il volume Il Buddismo mahayana attraverso i luoghi, i tempi e le culture. L’india e cenni sul Tibet; il viaggio del dharma, continua attraverso la sterminata Cina,
e Marassi lo segue svelandocene le tappe fondamentali.
Questo lavoro, non a caso, riprende il titolo del primo volume, che sarebbe consigliabile aver letto prima di accingersi alla scoperta di questo ricco testo. Ma cosa dobbiamo aspettarci di trovare in un libro che tenta di descrivere l’incontro fra due mondi? Non troveremo un’esposizione storiografica del fenomeno Buddista, ma piuttosto una presentazione a spirale del Buddismo attraverso una serie di nodi cruciali.
La prima questione che viene affrontata nel libro è il problema centrale, della trasmissione – laddove ve ne sia una – di un “quid” originario di ciò che noi oggi denominiamo Buddismo. Al riguardo leggiamo queste righe (pagg. 17-18):
«Mentre mi accingo ad avventurarmi in territorio cinese, sulle tracce di un pesce dorato che nell’anno zero scavalcò l’Himalaya, nella curiosità che dirige il mio procedere la domanda che più mi coinvolge indaga proprio per capire se in quel mondo misterioso il limite senza limite sia stato violato o meno: c’è qualche cosa nei buddismi nati in Cina che già non sia contenuto nella cultura buddista indiana? Oppure: è possibile un buddismo così evoluto che possa prescindere anche dalla sua nascita?»
Come possiamo evincere da queste righe la questione è fondante e Marassi la pone in modo immediato. In questo modo ci vengono forniti degli strumenti ermeneutici indispensabili per seguire il viaggio del dharma dalla sua nascita (o “non nascita”), al suo incontro con la cultura cinese.
Queste pagine hanno una funzione storiografica, ovvero ci danno le coordinate indispensabili per seguire l’evoluzione storica del Buddismo, infatti, il secondo nodo affrontato nel testo, è volto ad evitare un’errore comune a quanti tentano di definire un’ermeneutica della storia del Buddismo: confondere ciò che è una forma, e quindi qualcosa d’impermanente, con ciò che è il fondamento, che poi sarebbe un non fondamento, del Buddismo. Se non si pone questa attenzione, non solo si rischia di scrivere cose inesatte, ma si trasmette un dharma “pericoloso”, potremmo dire che si “afferra il serpente in modo errato”.
Questa, che noi abbiamo definito forma di attenzione, emerge in vari luoghi in questo lavoro.
Queste righe di Marassi possono darci un’idea di questo particolare aspetto (pag. 20): «In termini funzionali, operativi, la condizione di vuoto che sottostà all’impermanenza è la peculiarità che rende riconoscibili – e perciò affidabili – i buddismi, i quali si manifestano con capacità/esigenza di esistere pur in assenza di una struttura fissa: in qualche modo il buddismo è obbligato a usare le strutture che incontra perché il vuoto intrinseco a ogni ente è anche la sua condizione. Così, se il buddismo non è mai la struttura in cui appare, essendo questa contingente, per vederlo occorre non confonderlo con la forma, con tutto ciò che riempie il vuoto che lo costituisce».
Una volta equipaggiati degli strumenti necessari per leggere il cammino storico del dharma, il testo affronta un’altra questione centrale, ovvero la differenza linguistica che vi è tra il nostro linguaggio fondato sul “logos” e il linguaggio cinese fondato sugli ideogrammi.
Non è distinzione da poco, infatti, da questa differenza scaturisce una differenza di cosmologie. Queste pagine sono molto dense e ricche di riflessioni filologiche, non mancano richiami a Semerano e Austin.
In Cina da sempre ciò che ha unificato le varie etnie non è mai stata una lingua bensì una scrittura. Una determinata “res” esiste solo se è rappresentata da un segno che la descrive; comprendiamo quindi come sia fondata, in questa cultura, l’esigenza posta da Confucio di ordinare i segni. Ordinare i segni significa ordinare la realtà. Quando il Buddismo arriva in Cina incontra una cultura con una tradizione filosofica secolare, ovvero incontra un universo di segni con delle radici molto profonde. Se questo incontro fosse avvenuto tra Buddismo e filosofia Greca avremmo detto comunque che tale confronto avveniva tra Buddismo e una tradizione filosofica secolare, ma ciò che muta è il senso che diamo a quel “filosofico”: mentre in Cina il “logos” , inteso come discorso, parola, suono, non è fondante, lo è, di contro, per la filosofia Greca, ma dovremmo dire con più esattezza per tutta la filosofia occidentale.
Una tale differenza non è astratta, puramente linguistica, ma è causa di differenze che oggi noi possiamo riscontrare con forza. Queste differenze, scaturite da una diversa concezione linguistica, devono essere continuamente tenute presenti, ma vediamo come scrive Marassi al riguardo (pag. 52): «Un interessante aspetto che – spero – in futuro venga accuratamente esaminato è il seguente: confucianesimo e daoismo hanno rilevanza culturale, religiosa, filosofica in un Occidente che pare in grado di considerare ammissibili solo i valori e i paradigmi nati e sviluppati all’interno della propria storia? Oppure, culture e religioni così radicalmente diverse non hanno nulla da scambiarsi e da giovarsi perché inapplicabili fuori dal loro contesto? E se invece questa radicale diversità fosse la sponda ideale dalla quale guardare al nostro mondo per meglio vederne i limiti e i contorni? Le parole “filosofia” e “religione” in quella parte del mondo non sono mai esistite sino a tempi recenti quando sono stati accostati appositamente ideogrammi per tradurle dalle lingue occidentali. Abbiamo così zhe xue, “studio della saggezza” per filosofia e zhong jiao, “insegnamenti di una setta/chiesa ” per religione. Ma è così anche per “politica”, “rivoluzione”, “costituzione”, “persona”, “diritti umani” e tante altre parole la cui assenza nel contesto antico di fatto costringerebbe a usare neologismi o approssimazioni nella “traduzione” di quelle categorie. Viceversa, e questo incide sul lavoro attuale, sono presenti numerosi elementi linguistici che rimandano a un significato del tutto o in parte assente nel nostro pensare e in questo caso la resa nella nostra lingua di quei termini rischia di essere fuorviante o sminuente; per esprimermi in “cinese”: la rana nel pozzo non sa parlare del mare».
Dunque il dharma proveniente da occidente giunge nella sterminata Cina. Due sono i pilastri culturali che il Buddismo incontra: il Confucianesimo ed il Daoismo. Sono molte le pagine che Marassi dedica a questi due universi di senso. Vogliamo definirli così: “universi di senso”, infatti, dalla lettura di queste pagine emerge proprio questo aspetto: il Confucianesimo, il Daoismo non possono essere definiti, non possono essere rinchiusi in determinati confini semantici. La potenza di Confucio, intesa come influenza diretta sull’evoluzione storica di un popolo, di una nazione, è palese e sconvolge in quanto ad efficacia e continuità. L’incontro del Buddismo con “un tale universo di senso” non è scevro di problematiche. E ancora dalle pagine di Marassi emerge una costatazione puntuale: in India l’Induismo alla fine ha assorbito il Buddismo, facendone una sua forma, allo stesso modo in Cina il Confucianesimo ha dissolto il Buddismo. Tale dissoluzione ha dato origine ad un Buddismo totalmente succube dell’efficacia sociale del Confucianesimo. Vogliamo leggere queste righe di Marassi che bene esplicano questo concetto (pag. 103): «Il confucianesimo finalizza il “lasciare andare”, l’esimersi dall’agire secondo la propria volontà o dall’imporla, all’assunzione della forma rituale perché considerata l’unica valida, o quantomeno la più valida. In questo mio non ergermi come soggetto autonomo, eccentrico, assumendo la forma “standard” c’è la realizzazione fattuale dell’ordine naturale, quindi l’ordine poggia sulla scomparsa dell’affermazione delle individualità in ogni ambito relazionale. Questa è la potenza e la malattia dell’Estremo Oriente: una capacità di omogeneità enorme che permette coesione e perciò efficacia a spese della rappresentazione delle pulsioni individuali, intese come dissonanti ossia fautrici del disordine».
L’incontro tra Buddismo e Confucianesimo e tutta la sua evoluzione è analizzato in modo dettagliato da Marassi. Non mancano prese di distanza da un Buddismo sino-giapponese che vorrebbe proporsi oggi in occidente, come l’autentico dharma.
Ma, non basta fare i conti con Confucio, l’autore affronta l’altro “universo di senso”: il Daoismo. Qui le difficoltà maggiori sono nel tracciare con chiarezza le differenze, per evitare equivoci di senso. Vi sono passaggi, specialmente, nel Zhuangzi molto vicini ad una sensibilità Buddista, su tutti i concetti di via e vuoto; al riguardo ecco cosa scrive l’autore (pag. 186): «Nel daoismo del Laozi e del Zhuangzi “via” e “vuoto” hanno una collocazione e un senso diversi dai loro omologhi buddisti: nel buddismo delle origini il termine “via”, “sentiero” non aveva una valenza particolare; mutuato dalla cultura indiana precedente indicava sì il procedere ma legato all’intenzione “dietro” al comportamento, è il procedere di chi usa la propria vita secondo un progetto religioso: il Nobile Ottuplice Sentiero è la vita dell’uomo secondo gli insegnamenti etici, gnostici e di pratica interiore impartiti dal Buddha. Non è l’ideale cosmico dell’assecondare il flusso naturale come inteso dai daoisti e neppure mantenere l’ordine e l’armonia attraverso la giusta forma di comportamento. Ancor più è marcata la differenza se parliamo del vuoto: l’aggettivo shunya qualifica tutta la realtà in quanto priva di vita propria, o svabhava, e il sostantivo shunyata è semplicemente il nome di questa condizione di assenza, non è – come nel daoismo – un luogo metafisico, la parte non ancora esistente del fenomeno, un’essenza così piena da essere più piena del pieno. L’identità profonda della gnosi delle due tradizioni, buddista e daoista, arriva sino alla realizzazione del vuoto interiore ma poi si divarica irrimediabilmente: l’identità col vuoto nel buddismo di Nagarjuna è la scomparsa del mondo nel mondo, è la vita privata del suo pungiglione: l’attaccamento alla vita stessa. Per il saggio daoista procedere verso il vuoto è la via, Dao, di identificazione con il latente, la radice, l’origine».
Dopo aver preso in esame queste argomentazioni, ricche di spunti di riflessioni e di ulteriori ricerche, il libro affronta temi più specifici sul Buddismo in Cina. Vengono prese in esame le prime scuole, la loro gestazione, i loro primi passi. Non mancano rimandi agli sviluppi che avranno in Giappone.
Troviamo riflessioni molto interessanti sulla costruzione dei lignaggi, elementi essenziali per legittimare storicamente una scuola. In Cina assistiamo ad una vera opera di architettura storica ex novo. Se vi è stata una costruzione storica è grazie all’opera di tanti pellegrini che affrontando viaggi, spesso mortali, hanno trasportato, trasmesso, attraverso i sutra quello che era il dharma autentico.
Incontriamo delle pagine che affrontano l’evoluzione storica della traduzione di tali sutra. Quindi Marassi si sofferma sulla figura del traduttore Kumarajiva, ma non solo su di lui. Avendoci fornito gli strumenti ermeneutici adeguati riusciamo a comprendere l’immensa opera di questi traduttori. Comprendiamo il tempo e la fatica necessaria per riuscire a trasmettere quel senso che è al di là delle parole, dei ragionamenti, ovvero la traduzione di ciò che è denominato “linguaggio intenzionale”. L’autore per facilitare una tale comprensione utilizza passi tratti dalla tradizione Cristiana.
Al koan è dedicato un capitolo specifico, ciò che è molto interessante in queste pagine dedicate al koan è l’utilizzo di Merton e del suo celebre Lo zen e gli uccelli rapaci. Merton è “manipolato” da Marassi per presentare questa scuola in un modo più diretto a chi, come noi, fa fatica ad afferrare determinati passaggi perché lontani dal nostro linguaggio, dal nostro modo di pensare. Tuttavia non mancano prese di distanza da Merton e queste sono ancora più importanti per comprendere ciò di cui si sta parlando.
Il capitolo XI è davvero interessante: vi sono presi in esame in modo dettagliato due trattati non molto conosciuti: Il trattato del risveglio della fede nel Mahayana e Il trattato delle due uscite e delle quattro pratiche. Questo capitolo riprende temi toccati nelle pagine precedenti, ma gli dà una luce diversa e molti argomenti trovano una nuova collocazione. Il trattato del risveglio della fede nel Mahayana è fonte di riflessioni sul rapporto tra individuo e autenticità del dharma.
L’appendice finale apre uno scorcio sui nostri giorni, sulle conseguenze, della cultura Cinese prima, Giapponese poi, sul Buddismo oggi presente in occidente.
11 Commenti a “Il viaggio continua…”
Se volete, lasciate un commento.
Devi essere autenticato per inviare un commento.

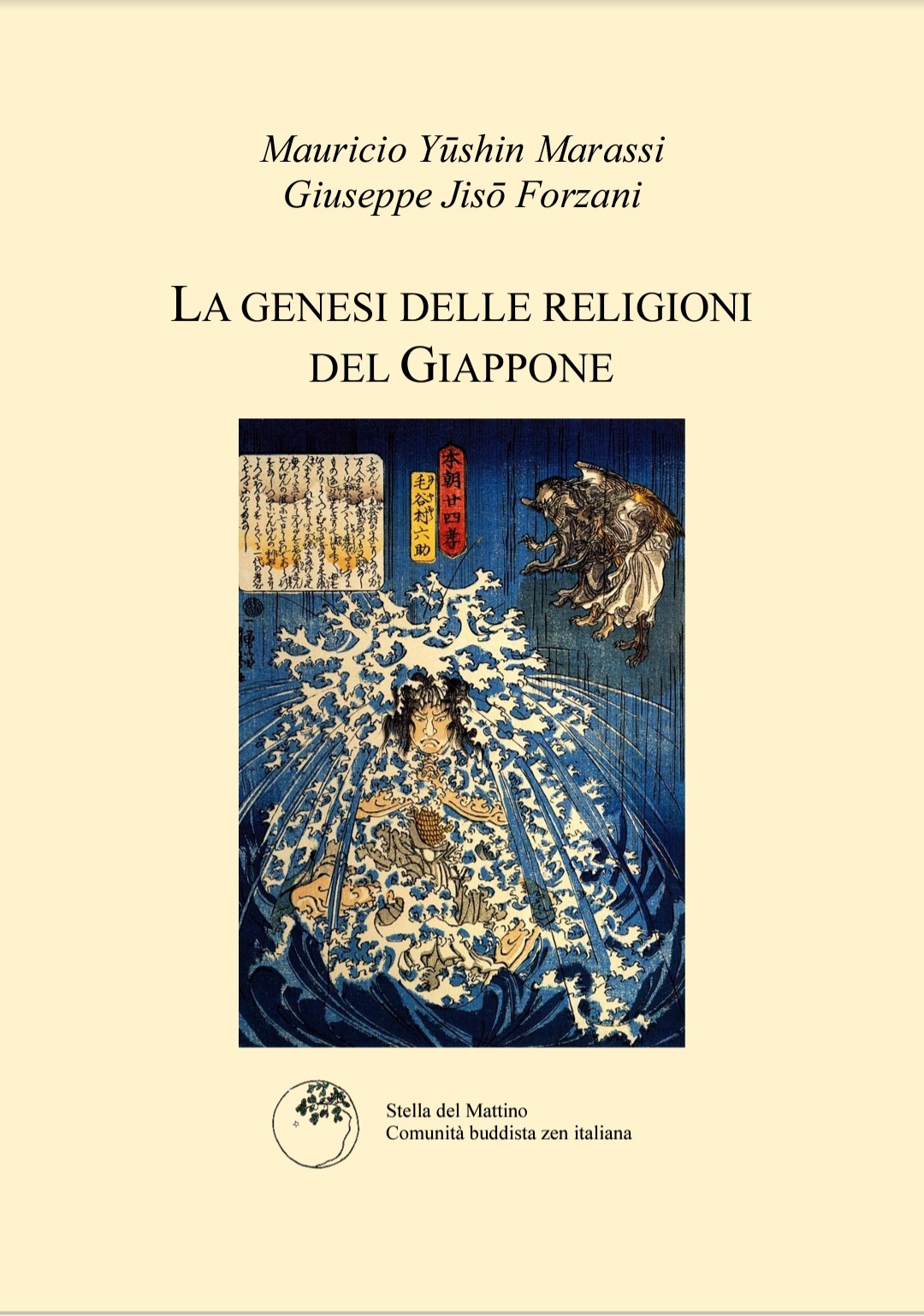






6 Aprile 2009 alle 11:07 am
Ottima scheda.M sa vedere al di là, nella parte invisibile, ulteriormente; ma l’invisibile non è ciò che non appare, è il suo apparire che incarnato, non coincide né si esaurisce nella sua apparenza. La lettura è tanto più “esatta” in quanto estatica, eccessiva, ulteriore, alla ricerca del senso: non adeguazione all’oggetto ma rivelazione della “cosa” spirituale. In questo, in fondo, sta la sua originalità e la sua forza, di pensiero come di stile.
7 Aprile 2009 alle 7:34 pm
Grazie. Sì, la scheda è fatta bene, merito di JJ. Bella l’idea che l’invisibile non sia ciò che non appare. Sei un entusiasta, si direbbe.
7 Aprile 2009 alle 11:53 pm
WRONG.Il mio spirito sciamanico si desta in occasioni di catastrofi(Cfr.6.04.09 e 26,12.08). I was born with the wrong sign,in the wrong house With the wrong ascendancy.
8 Aprile 2009 alle 6:46 pm
Visti i risultati, forse, allora, sarebbe bene che il tuo spirito sciamanico tornasse a quietare, magari a lungo…
8 Aprile 2009 alle 10:53 pm
Oppure, data la sincronicità dei miei stati di trance in prossimità di una crisi, sarebbe bene prendere sul serio i profeti di sventura…
8 Aprile 2009 alle 11:05 pm
E se un Dio non ci venisse a salvare?
9 Aprile 2009 alle 1:46 pm
Be’, se citi i “testi canonici” non posso che essere d’accordo… 🙂
12 Aprile 2009 alle 4:21 pm
Le aquile non volano a stormi.Mi hanno cacciato dalla scuola delle buone maniere…Delirio faticoso e avvilente quello del compilatore di grossi libri, del dispiegatore in 400 pag. d’un concetto la cui perfetta esposizione orale capirebbe in pochi minuti! Meglio fingere che questi libri esistano già, e presentare un ‘riassunto’ ,’un commento. Happy Easter.
12 Aprile 2009 alle 4:35 pm
Caro Homosex, ti preferisco mellifluo e sognatore, sciamanico e visionario. Quando fai il cattivo non mi pari all’altezza: è in grazia di lenti e arruffoni lettori come (…omissis) che si fa l’improba fatica. Poi, quell’unico concetto non c’è e ciò che resta è il meno possibile. Allora si può parlare di buon libro.
12 Aprile 2009 alle 4:56 pm
Ci sono due modi, almeno secondo me, di leggere un libro ( che non sia ricreativo ), o andando alla ricerca di quello che si sa già, o cercando di capire “ciò” che ci vuole dire l’autore, per integrarlo con le nostre conoscenze in modo da “ricombinare” il quadro con qualche pezzo mancante in meno.
A parte questo, quello che mi ha colpito maggiormente nei “testi canonici” dell’ autore è la modalità di interagire con “il lettore”, più esplicita forse nei primi testi ma sempre presente ed “energica” ( non mi viene un termine che mi renda meglio l’idea )anche negli ultimi due.
Questo, unito al linguaggio e allo stile usati, induce ( sempre dal mio punto di vista ), almeno durante una prima lettura, ad “arrivare in fondo”. Cosa abbastanza strana, trattandosi di argomenti non immediatamenti accessibili.
12 Aprile 2009 alle 6:17 pm
Grazie Marta. È un gran complimento. Tu sei insegnante quindi…. ti è più facile capire questa cosa: quando fai lezione scrivi un libro ogni volta nella testa dei ragazzi. Farlo con la scrittura è più difficile perché non hai il contatto diretto. Si sopperisce anche con la fatica che ci deve mettere il lettore. Ma tecnicamente ho sviluppato quel modo nel rapporto con i ragazzi. È a quel rapporto, quindi, che ne va il merito.