Sab, 24 Apr 2010
In una conferenza tenuta al Congresso mondiale degli abati benedettini a Roma nel settembre 2000, Timothy Radcliffe – maestro generale dei domenicani dal 1992 al 2001 – affermava che i monasteri sono, o dovrebbero essere: «Luoghi in cui la gloria di Dio rifulge, troni per il mistero. Questo non per una sorta di diritto divino, né per qualche automatismo nominalistico, ma proprio a causa di ciò che i monasteri non sono e di ciò che
non fanno, perché l’invisibile centro della vita monastica si manifesta nel come i monaci vivono. I monaci, infatti, non fanno nulla di particolare, non comprendono se stessi né sono compresi come quelli che hanno una particolare missione o funzione nella chiesa: essi sono là e, felicemente, continuano a essere semplicemente là… Le loro vite non conoscono carriere e promozioni, non hanno altro traguardo che la venuta del Signore: sono fratelli e sorelle, non possono aspirare a essere nulla di più, non hanno altra via di progresso che quella dell’humilitas».
Se al posto di “humilitas” inseriamo “zazen” (humilitas viene da humus)
e al posto di “monaci” poniamo “coloro che fanno zazen”…
Imparare ad essere conosciuti, caratterizzati, anche apprezzati, da ciò che non si è e non si fa potrebbe essere un buon inizio per evitare di trasformare il nostro “essere zen” in un teatrino più o meno pubblico, più o meno privato, dal quale ricevere conferme e identità. Il buddismo è un come interiore, non una forma esterna: «Non preoccupatevi di moltiplicare i monaci: l’abito nero non salva; colui che porta l’abito bianco, cioè chi ha lo spirito di obbedienza, di umiltà e di purezza, costui è un vero monaco del monachesimo interiorizzato» (Evdokimov, 1968).
Il senso di “monachesimo interiorizzato” andrebbe approfondito in un’ottica buddista, zen. Ovviamente per noi stessi, non per farne un altro moloch con il quale tormentare gli altri: «Tu non hai ancora il monachesimo interiorizzato… »
108 Commenti a “Essere semplicemente là”
Se volete, lasciate un commento.
Devi essere autenticato per inviare un commento.


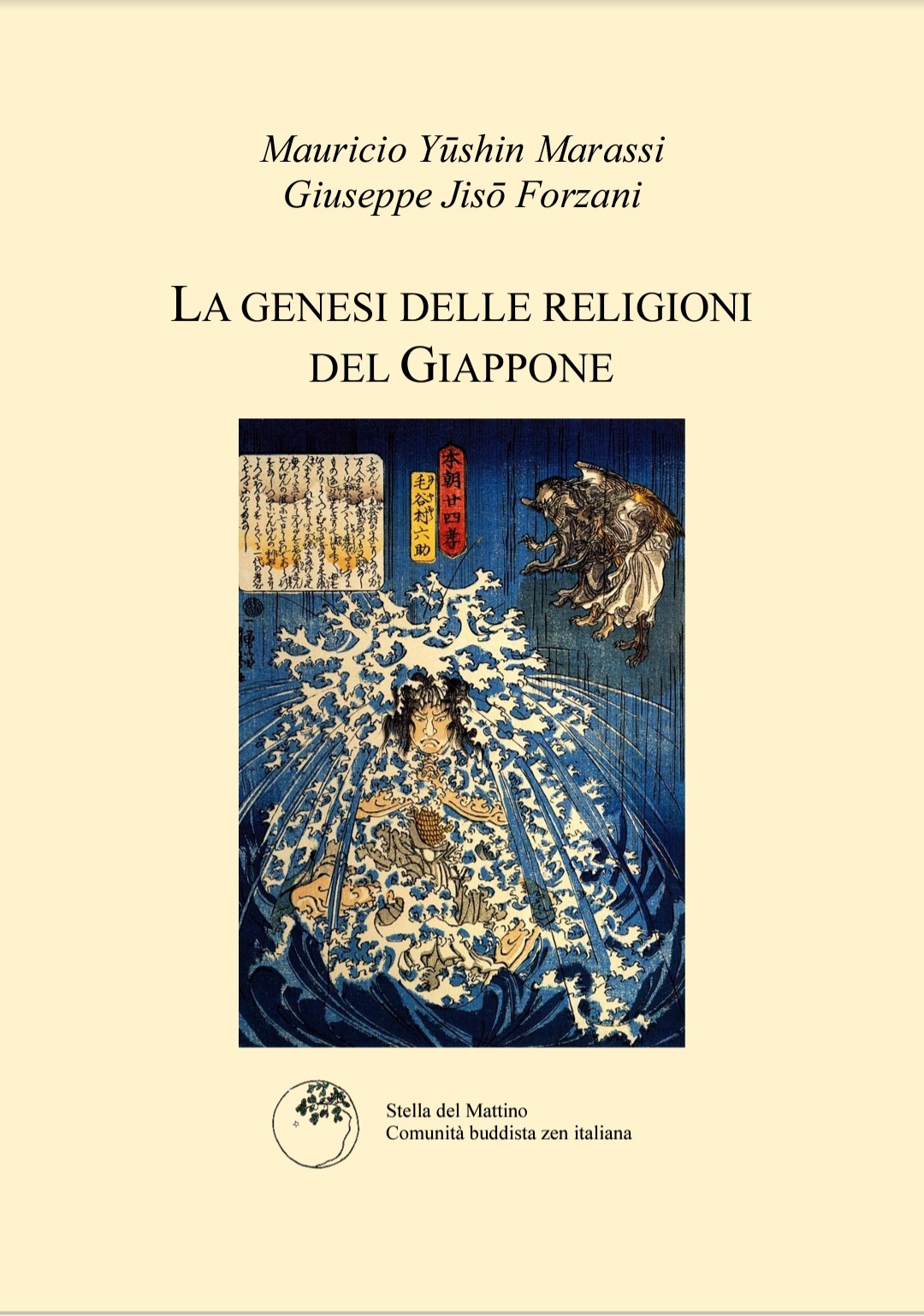






24 Aprile 2010 alle 5:41 pm
“La magia degli elfi mi ha tenuto in vita troppo a lungo. Ho vissuto ben oltre il limite della mia vita. È ora che io me ne vada. Ma […] me ne vado in pace, senza dolore”.
“Ti ho appena ritrovato [disse la figlia Lucinda]. Non puoi morire proprio adesso”.
Arthur si chinò verso di lei e le parlò – dolci parole che Jared non riuscì a sentire – poi scese […] e la strinse in un abbraccio. Appena i piedi di Arthur toccarono terra, il suo corpo si trasformò in polvere e fumo. Un piccolo vortice mulinò intorno a Lucinda, poi si allontanò nella notte e in un attimo scomparve.
Dalla saga fantasy “Spiderwick”, finale
24 Aprile 2010 alle 5:49 pm
Molto bello, grazie Dr. Vuoi darci un indizio per collegarlo al post oppure…
24 Aprile 2010 alle 6:16 pm
beh vale per ciò che NON dice 😀
a parte gli scherzi, mi è sembrato uno spunto notevole. Nella saga, Arthur Spiderwick è quello che “tutti lo cercano, tutti lo vogliono”, ma appena lo trovano, lui scompare.
24 Aprile 2010 alle 7:44 pm
Faccio il pontiere: da sempre -in ambiente zen- si conciona sull’ineffabile, l’indicibile, l’esperienza personale come unico medium. Poi, d’un tratto, diciamo “adesso te lo insegno io come stanno le cose”. Vivere una vita abitata da una religione è inventarsela (la vita!) faticosamente giorno dopo giorno, non c’è spazio per i soloni. Giorno dopo giorno significa “appena trovato scompare”. Faticosamente significa: non è facile essere “semplicemente là”.
Cuntént?
24 Aprile 2010 alle 8:26 pm
Ma Ella, se lo lasci dire, è un militare sopraffino: pontiere, truppe d’assalto, Genio guastatori…
25 Aprile 2010 alle 11:45 am
Per mym (n.4)*appena trovato scompare*
Mi viene in mente – udite, udite – K. Marx: “La religione è la consapevolezza dell’uomo che non ha ancora acquisito o ha nuovamente perduto se stesso”.
25 Aprile 2010 alle 11:58 am
Sì, posso essere d’accordo: perdere sé stesso è il centro della pratica buddista. Da comprendere con estrema attenzione, però.
25 Aprile 2010 alle 12:01 pm
Per Marx (n.6) e per interposta persona per Louis:
“La religione è la consapevolezza dell’uomo che acquisisce e subito nuovamente abbandona se stesso”.
Per il resto devo pensarci un po’ su: ci risentiamo (forse). Buon 25 aprile a tutti.
25 Aprile 2010 alle 12:28 pm
Ciao Nudelook. Sì, concordo, anche se così si fa parlare Marx come … un bravo prete?
25 Aprile 2010 alle 12:35 pm
Leggendo le tue righe mi è venuto alla mente questo passo da Il grande discorso di distruzione della brama, Gnoli, Vol. 1, pag. 39: “Egli è contento della veste che copre il suo corpo, del cibo elemosinato con cui si sostenta e, ovunque vada, porta questo con sé e va. Come un uccello che, ovunque voli, porti con sé il peso delle sue ali e vola, proprio così un monaco è contento della veste che copre il suo corpo, del cibo elemosinato con il quale si sostenta e, ovunque vada, porta questo con sé e va.”
Ciao, Gennaro
25 Aprile 2010 alle 12:37 pm
Uuuuh! Non vale, se usi le armi pesanti non vale! 😉
25 Aprile 2010 alle 5:16 pm
Anche Marx ha diritto a rinnovarsi… Immagino intendesse che la religione è una iattura proprio perché paralizza l’uomo nella consapevolezza di non aver ancora acquisito e/o di nuovo perso la propria autentica dimensione e qui, in questo senso di incompletezza dell’uomo, la religione ci sguazza e costruisce il suo deleterio potere. Mentre l’uomo nuovo, dopo la rivoluzione, acquisisce e non perde. Marx è, in questo campo, davvero un buon (?) prete, che punta sul futuro e mira a un guadagno inalienabile, un altro idolatra dell’escatologia.
“Un monaco è contento della veste che copre il suo corpo, del cibo elemosinato con il quale si sostenta e, ovunque vada, porta questo con sé e va…” sì, una meraviglia! Ma cum grano salis… Con le armi pesanti si può far male a sé e agli altri. Un monaco siffatto lo conosciamo, di persona, intendo? Non voglio fare il guastefeste, ma attenzione a non fare di un ideale (che si scioglie giorno per giorno, faticosamente nel semplicemente là) un idolo ulteriore, più raffinato, forse, ma non meno ingannevole.
25 Aprile 2010 alle 5:29 pm
Il guastafeste è storia antica, “ruba la vacca al contadino” dicevano quei filoni di cinesi. In effetti ciò che mi è piaciuto della citazione è proprio quel semplicemente là, unito a felicemente. Niente di speciale, seppure molto difficile.
25 Aprile 2010 alle 6:01 pm
Eh, sì! Semplicemente là, beh, insomma, non ci vuole poi molto: è quel “felicemente”, abbinato, che è difficile, senza il quale non c’è gusto nel semplicemente là.
25 Aprile 2010 alle 11:26 pm
Non entro nel merito delle asserzioni rispettabilissime, ma per me hinayaniche, del maestro degli abati benedettini, anche se interessanti. Mi permetto di tentare di precisare, dal mio punto di vista, le riflessioni susseguenti di Mauricio Yushin.
Si dice: “Il buddhismo è un come interiore, non una forma esterna”, se è, è. E’ un intero. Non si differenzia in “interiore-esteriore”.
Ancora riscontro nella citazione di Evdokimov l’eterno dualismo…si dice: “,cioè chi ha lo spirito di obbedienza…”, obbedire a chi? a che cosa? Per me al Dharma, ma si può solo essere Dharma, non è “possedibile” appunto.
E ancora, sinceramente, nell’ambiente zen che ho frequentato non si è mai “concionato” su nulla di “ineffabile, indicibile”, e il “solone” (che ci sarà sempre e ovunque in qualche forma) può essere un ottimo upaya.
E ancora mi sento di dire che non c’è nulla da trovare quindi nulla che possa scomparire. E il termine “essere” è esaustivo in se stesso, contiene ogni cosa, quindi non necessita di “felicemente semplicemente là”. Che se anche fosse includerebbe per transizione anche “tristemente, difficilmente, qui”.
Infine, caro Mauricio, mi sembra che la prospettiva sia un pò ristagnante nella dimensione del “criticismo” che può esprimere anche una certa salute o deontologia ma…anche essere fine se stesso.
Nel Dharma.
Nello Genyo
26 Aprile 2010 alle 11:48 am
Ciao Nello, grazie per il tuo commento. Su una cosa mi sento spinto a puntualizzare: il termine hinayana (e derivati) non esiste se non in termini dispregiativi, nessuno vi si è mai riconosciuto poiché è sempre stato usato (a partire dal suo senso letterale: “veicolo, percorso inferiore, minore, scadente”) per stigmatizzare “i falsi buddisti”, infatti non esiste (se non nella testa di qualche autore) un buddismo hinayana.
In ogni caso ha poco senso esaminare o giudicare il buddismo di Radcliffe e Evdokimov, non hanno mai inteso esserlo né li ho presentati come tali.
26 Aprile 2010 alle 11:53 am
Vi prego di guardare benevolmente a questo dubbio di una troglodita dello zen. Se “essere” e “non essere” sono la stessa cosa, se il “da-sein” che ho altrove visto in discussione non ha senso, allora cosa significa “essere là” più o meno felicemente e semplicemente? Vi prego ancora: abbiate pazienza…
26 Aprile 2010 alle 4:34 pm
Cara troglodita, nulla di così difficile: con “stare (o essere) semplicemente là” si esemplifica un atteggiamento di vita privo di iattanza, privo esposizione o di spettacolarità. Condurre la propria vita senza ostentarla, esibirla.
26 Aprile 2010 alle 9:16 pm
Occhei, grazie. Troglodita però me lo posso dire io, ma non un altro, neppure tu!
26 Aprile 2010 alle 10:53 pm
Con i miei poteri giucascaselliani, leggo nella mente di mym: “Ci sei cascata!”
27 Aprile 2010 alle 3:09 pm
‘Essere semplicemente là’ può significare anche, in termini più rigorosi, tentare di bilanciare ed equilibrare le volontà individuali che, per natura, tendono ad affermarsi e sopraffarsi (ad esibirsi). Accettandosi come uguali, ma anche volendosi come uguali – e il saio ne è una prova – i monaci orientano la loro vita secondo il principio della ‘buona volontà’ sulla terra: aspirano, cioè, ad affermare e mantenere come durevole l’invisibile centro della loro attività – la glorificazione di Dio -.
27 Aprile 2010 alle 3:20 pm
Ciao Homosex, ben tornato. Certo che da quando Isabela ti concede la sua presenza non sembri più tu, sei addirittura migliorato (non ti offendere, eh!). Se mi diventi buddista … ne avremo perso un altro.
27 Aprile 2010 alle 3:23 pm
Dr sei sempre così carino!Prima di andare a letto abbraccerò una quercia del mio giardino.Per Marx & co:ma la rivoluzione mica la si fa per il futuro!?Non sono per nulla turbata dall’ aver perso il mio avvenire a carte:tanto sono buddista. Combatto (invento?) per avere un passato affinché un po’ del mio immenso amore riposi intatto nell’accaduto. Do ragione a nudelook al commento 12:è da vili, da preti(?), calcolare tutto in base a perdite e vantaggi.Scappo a prendere il sole;è una giornata bellissima!Bye.
27 Aprile 2010 alle 3:37 pm
Confesso una certa emozione/nel sentirmi Isabela dar ragione…
La rivoluzione non si fa per il futuro, il guaio è che se la si mette nel futuro, la rivoluzione semplicemente non si fa. E infatti… Non puoi perdere il tuo avvenire a carte, l’avvenire ce lo hai alle spalle (Angelus Novus) è da lì che ti arriva e precipita nel passato: come puoi sapere se lo hai perso o vinto? Per questo non ha senso occuparsi di perdite e guadagni. Anche qui c’è il sole.
27 Aprile 2010 alle 4:41 pm
Apprezzo l’argomento, e mi piacerebbe guardare a un aspetto della prassi su cui mi sembra che Yushin Sensei insista da tempo in ogni occasione.
Leggo proprio in queste sere due passi, che ispirano il dialogo, entrambi a bilanciare una visione (non solo cattolica) a volte un po’ troppo teatrino-monastica e ad approfondire, forse, il riferimento al “progresso nell’umiltà” (i.e. della pratica) come uno “stare non facile”.
1. “Chi non dice io né mio, costui è chiamato monaco” (Dhammapada?)
2. “Quelle cose che ti sono di impedimento nell’amare il Signore (i.e. nella compassione)… e tutti coloro che ti saranno di ostacolo… tutto questo devi ritenere come una grazia (i.e. frutto dell’interdipendenza)… e non volere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te (i.e. lascia andare la presa)… e questo sia per te più che stare nell’eremo” (Francesco d’Assisi, lettera a un ministro).
Grazie e a presto,
Giorgio
27 Aprile 2010 alle 4:47 pm
Mmmh, sì, l’icona del monaco è abbastanza facile da usare (un po’ meno da vivere) anche perché si presta agevolmente all’idealizzazione. Però in questo caso -e forse diciamo la stessa cosa, non so- chiudendo il testo con la citazione del teologo russo sul monachesimo interiorizzato volevo richiamare l’attenzione su l’icona del bancario, del bidello, della shampista… Ciascuno all’interno della propria forma di vita vissuta come una piccola opera d’arte silenziosa. Felicemente, bada bene. Ambedue caratteristiche (cesellare la propria vita senza pubblico e in serenità) possibili solo in un altra forma ideale: il buddismo maturo, quello del superamento del monachesimo quale via esclusiva di salvezza. Va da sé, come dico nel testo, che senza una pratica intensa, quotidiana, tutto ciò non ha la minima possibilità di vedere la luce.
27 Aprile 2010 alle 7:03 pm
>Confesso una certa emozione / nel sentirmi Isabela dar ragione…
A me, figurarsi un pochino, / ha detto che son carino!
Solo per mym non ha mai una parola gentile… e però… e però… il 99% dei post sono rivolti a lui, carta canta.
27 Aprile 2010 alle 7:41 pm
Be’, ragazzi, mi spiace suscitare invidia 8) però … La zampata del leone graffia ancora… 😉
27 Aprile 2010 alle 8:31 pm
… e al rinoceronte, le corna rotte
27 Aprile 2010 alle 9:07 pm
Beh, caro dr, (27) non c’è partita, lui è il Lupo della Stella…
27 Aprile 2010 alle 9:25 pm
>lui è il Lupo della Stella…
sarebbe un buon titolo per un film horror
… o lo è già? 😀
27 Aprile 2010 alle 10:39 pm
Troppo bbuoni.Per sporcare un po’ l’ideale prendo a prestito queste parole di Platone:”Coloro che dedicano molto tempo agli studi filosofici, quando affrontano i tribunali, si rivelano, naturalmente, degli oratori ridicoli”(Teeteto,172 C-D).Altro che avvocato del diavolo!Devo ringraziare il mio sarto per quei 4 clienti che ho. A conferma di quanto sostiene dr(27) chioso con dei versi dedicati a mym:”il mare è in burrasca/la terra in tempesta/se mi tocchi Cristina/ti spacco la testa(^_^)
27 Aprile 2010 alle 10:42 pm
Caro dr il futuro sarà pure alle spalle ma ho tanta nostalgia della frequentazione del lusso e dei panorami dell’avventura.Ma l’hai vista la soffitta di homosex?
Mi va di recitare un haiku di Junichiro Kawasa: “Abito un tempo che ha un occhio solo e guarda il passato. Il futuro è alle spalle. La nostalgia è noia che dilaga. Nostalgia della nostra nostalgia”.Bonne nuit.
28 Aprile 2010 alle 12:00 pm
Mamma mia, ragazzi/e, mi fate sentire -più che allupato- un ignorantibus. Io ero rimasto alla collezione di farfalle (a proposito, Isabela, nella mia soffitta ci ho anche il macaone dorato…) e voi qui parlate di Kultura, non so che dire…
28 Aprile 2010 alle 3:07 pm
Mi basta che tu abbia riso.Perdona la licenza poetica ma suonava bene(spallucce).Non ti faccio una lode solo perchè rischierei di essere lungo e andare fuori tema – così impari! -.E poi dovresti sapere che,per una mentalità yakuza come la mia, è disdicevole far mostra dei propri sentimenti.Allora invito i gentili cybernauti a considerare la superba gestione del sito della S.d.M.:non solo non è una vanagloriosa esibizione del suo ‘ayatollah’,ma neppure una mera vetrina di merci. Per quello che fai dovrebbero riempirti d’oro le tasche!Ma non contarci troppo: il turbo-capitalismo ostacola certe forme di intelligenza, specie quelle solidali.Ciao.
28 Aprile 2010 alle 5:07 pm
Vado subito a comprare dei pantaloni con le tasche graaaaandi…
Ciao.
PS: ho riso, ma non ho più basta. E sono bure raffreddado 😀
28 Aprile 2010 alle 6:56 pm
Caro homosexual, se la Cristina davanti alla quale alzi un poetico scudo protettivo (32) sono io, ti ringrazio. Se non lo sono, mi compiaccio dell’omonimia. Purtroppo non sono in questo momento in grado di partecipare attivamente alla discussione, cosa di cui mi dispiaccio e mi scuso. A volte, non capisco proprio di cosa si stia parlando: per es., cosa significa “giucascaselliani” (dr.20)? Ciao a tutti.
28 Aprile 2010 alle 8:04 pm
uéé ragazzi miei, se non conoscete Giucas Casella, che cosa avete visto del mondo?…
era colui che (non) sapeva leggere nel pensiero, esattamente come il sottoscritto.
28 Aprile 2010 alle 9:01 pm
Conclusione.Ma certo che sei tu, Cristina, il mio scudo poetico!Tuttavia mi preoccupo dell’incolumità di mym.Dal tenore dei tuoi commenti credo che, se mi trovassi solo con te nella stessa stanza, mi sentirei al sicuro solo dopo averti legata ben bene.Banalizzo:sabato mattina – giuro! – perdendomi con l’auto sono finito in un venerando monastero.Il giardino era splendido ma il monastero semideserto.Imho, se continua così, “l’invisibile centro della sua attività” non durerà poi molto.Taccio fino al prox post. Non mi va di stuzzicare la proverbiale calma olimpica di mym.Adieu.
28 Aprile 2010 alle 9:05 pm
Errata corrige. Senza punto esclamativo al secondo rigo.Eppoi l’haiku è di Junichiro kawasaki.
29 Aprile 2010 alle 1:00 pm
Ho oggi stesso acquisito la consapevolezza di essere vissuta senza vivere realmente, non conoscendo Giucas Casella. Ora andrò a fare una ricerca!
Mi sembra che l’incolumità di mym non abbia mai corso seri pericoli: non si difende ma attacca, quanto alla sua calma olimpica a volte oserei metterla in discussione: mi sembra che a volte si incavoli come una persona normale! Scusa mym, soprattutto scusa il fatto che non so bene cosa intendo per “persona normale”…
29 Aprile 2010 alle 4:17 pm
A nome delle persone normali: ringrazio ringhiando olimpicamente…
29 Aprile 2010 alle 6:13 pm
>non so bene cosa intendo per “persona normale”…
non guardare me!
29 Aprile 2010 alle 6:55 pm
Siete una banda di scoppiati! Oooooh!
29 Aprile 2010 alle 7:24 pm
Booom! Ma che scoppiati, siamo i tuoi fedeli e affezionati collaboratori!
29 Aprile 2010 alle 10:48 pm
Non ce ne dovrebbe essere bisogno, tuttavia mi sento di precisare alcuni punti.
Ho aperto il mio intervento in questo modo:
“Nello Scrive:
25 aprile 2010 alle 11:26 pm
Non entro nel merito delle asserzioni rispettabilissime, ma per me hinayaniche, del maestro degli abati benedettini, anche se interessanti. Mi permetto di tentare di precisare, dal mio punto di vista, le riflessioni susseguenti di Mauricio Yushin.”
Nell’ambito degli studi accademici, il termine “Hinayana”, viene tradotto come “Piccolo Veicolo”, quindi nessuna valenza spregiativa o riduttiva tipo quelle che hai usato tu (“inferiore, minore, scadente, falso buddhisti”).
Relativamente ai signori Radcliffe ed Evdokimov, nulla da dire…le mie osservazioni erano relative all’uso che TU ne hai fatto trasferendole in ambito buddhista. Questo a dire che ho capito che non li hai presentati come buddhisti (ed era chiaro) ma che non condivido le equiparazioni dei loro asserti con il buddhismo che ritengo impropri per i motivi che ho sintetizzato nel mio intervento (n°15).
Saluti.
Nello
30 Aprile 2010 alle 4:23 pm
Il termine hīnayāna, nato come spregiativo per indicare i falsi buddisti, viene impropriamente -e pudicamente- tradotto piccolo veicolo.
“Inferiore, minore, scadente” non li ho usati a caso: sono la traduzione di hīna, assieme a: più basso, inferiore, difettoso, insufficiente, incompleto ecc. ecc. (Cfr. Diz Sanscr. – It., a c. di O. Sani, p. 1965). Grazie al cielo (Cielo?) quel termine non lo usa praticamente più nessuno perché non indica alcuna realtà esistente che in quel nome si riconosca o si sia mai riconosciuta.
2 Maggio 2010 alle 5:20 am
Tento di dare un contributo all’intervento di Cristina che dice:
“Cristina Scrive:
26 aprile 2010 alle 11:53 am
Vi prego di guardare benevolmente a questo dubbio di una troglodita dello zen. Se “essere” e “non essere” sono la stessa cosa, se il “da-sein” che ho altrove visto in discussione non ha senso, allora cosa significa “essere là” più o meno felicemente e semplicemente? Vi prego ancora: abbiate pazienza…”
Per partire ad affrontare il tema dell”essere” e “non essere”, non può essere elusa la tradizione occidentale (greca) e il principio di non contraddizione (PDNC)enunciato da Aristotele nel libro IV della Metafisica. Oltre a lui, bisogna rispondere anche a Parmenide…
In tempi moderni ti consiglio l’ottimo testo di Emanuele Severino, “Essenza del nichilismo” che include appunto il famosissimo “Ritornare a Parmenide”, il relativo “Prologo” e tutto il resto…
Tra cui:
“La verità dell’essere è cioè il predicato di ogni ente: non nel senso che l’ente stia al di fuori della verità dell’essere, ma nel senso che questa è la stessa predicazione, ossia la stessa unità veritativa dell’ente e del suo predicato, dove il soggetto non vive altrove che in questa sua unità col predicato.” (p.214)
Questo testo, molto importante per tutta la teoretica contemporanea, rimanda ad un’altro testo fondante di Severino che è “La struttura originaria”, Adelphi.
Poi, naturalmente, si possono trovare e tentare tantissime analogie con il pensiero buddhista, tuttavia, quanto posto in essere dalla visione del mondo operata dai greci, a mio avviso, e occupandosi di “essere”, non è bypassabile, va conosciuta e possibilmente fornire delle risposte agli interrogativi ed enunciati che pone.
Ciao.
Anche sul dasein…ci sarebbe da dire…ma per ora restiamo sul PDNC e Severino (grandissimo e già nell’Olimpo),
Nello
Esserci, dasein. E’ il termine scelto da Heidegger per designare la realtà umana. L’essere dell’Esserci è l’esistenza.
Esistenza, existentz. E’ l’essere dell’Esserci, a cui l’Esserci si rapporta sempre nella comprensione dell’eesere che è propria di esso. Non va quindi confusa con la existenzia che la tradizione contrappone alla essentia e che in Heidegger corrisponde piuttosto alla semplice presenza.
Semplice-presenza, (Vorhandenheit). E’ una categoria fondamentale, cioè un modo di essere degli enti che l’Esserci incontra nel mondo. Innanzitutto e per lo più l’Esserci incontra l’ente intramondano prendendosi cura di esso; in tal caso questo ente si rivela sotto l’aspetto categoriale dell’utilizzabilità. Quando l’Esserci assume invece l’atteggiamento conoscitivo, va oltre l’utilizzabilità immediata e tende ad esibire nell’ente intramondano la semplice-presenza. Nell’ontologia antica essa ha il suo equivalente nella existentia contrapposta alla essentia.
(termini tratti da “Essere e Tempo” di M. Heidegger, ed. Longanesi, 1971, pp.544,548)
2 Maggio 2010 alle 10:00 am
Grazie Nello. Questa è cultura, perbacco. Aggiungo, a mo’ di complemento, che il titolo Essere e tempo il Nostro lo mutuò dal titolo di una sezione dello Shobogenzo di Dogen: Essere (è) tempo, Uji in giapponese.
2 Maggio 2010 alle 10:59 am
Un piccolo (piccolo nei contenuti e nelle pretese) contributo ontologico.
Pur nel rispetto di un “grande” filosofo come Severino direi che:
a) rispetto ai limiti del suo pensiero, in particolare alla pretesa di aver colto la logica dell’essere in una concezione univoca in contrapposizione ad ogni forma di fede (la fede è in sè considerata “la follia” dell’occidente), consiglierei la lettura di un testo del “giovane” filosofo fabrizio Turoldo 1- Polemiche di Metafisica [Aracne Ed]
b)Penso che rispetto a Severino,in relazione al pensiero orientale, in particolar modo al taoismo e allo zen, si possa parlare di assonanze più che di analogie, visto che non mi sembra che in queste ci sia la pretesa di individuare “Il logos”.
“Via che uno enuncia non è già più la via
Nome che uno pronuncia non è già più il
Nome” Tao Te King 1
“Sappi che l’essere di ogni cosa non è
l’essere di essere non-essere..” Bussho 2
“Joshu dice:’Tu sai fare una cosa essere
per un’altra perciò profani’…
Pur stando così le cose, non dire che d’ora
in avanti non puoi rifuggire dal profanare:
o uomo che vai avanti all’asino e corri
dietro al cavallo.” Bussho 15 (traduz.Jiso)
Sulla fede:”Pittura del moci..In esso, pur affermando che un dipinto di un moci non può soddisfare la fame, Doghen non si ferma a questa ovvietà, ma procede oltre affermando che senza dipingere l’immagine del moci neppure è possibile realizzare quello che sazia la fame.” Note a Bussho di Jiso.
Ciao dario
2 Maggio 2010 alle 11:05 pm
Heidegger=perdita di tempo.Era un volgare nazista e ho un amico ebreo che, se fosse stato per herr professor,non sarebbe mai nato.Non stronco Severino per evitarci un pistolotto – sarebbe decisamente off topic.(.)Uffa, mi annoio.Bonne nuit.
3 Maggio 2010 alle 7:28 am
Giusto, su Heidegger invito a leggere il breve saggio di Hans Jonas “La filosofia alle soglie del Duemila”, Il Melangolo 1993.
Jonas fu suo allievo. Ma…
3 Maggio 2010 alle 10:46 am
Ciao Mara, benvenuta. Conosciamo anche un’altra Mara, ma tu is mei ke uan, come dicono i romagnoli in California… Che Heidegger fosse una perdita di tempo -pur nella mia ignoranza- lo sospettavo a tal punto che ci ho scritto su un libretto. Però non si sa mai… Che fosse, quantomeno, acquiescente coi nazisti è vero, forse però non era volgare.
3 Maggio 2010 alle 8:41 pm
Su Heidegger.. non tutti i mali vengono per nuocere: vedi Hannah Arendt.
D’altra parte anche De Andrè diceva che “dai diamanti non nasce niente
dal letame nascono i fior”
buona serata
3 Maggio 2010 alle 10:12 pm
>“dai diamanti non nasce niente
dal letame nascono i fior”
Le “impurità” (nel senso chimico del termine) che rendono possibile la vita, come diceva Primo Levi.
Però una delle “impurità” era la presenza della cultura ebraica in mezzo a quella dominante, alla faccia di Heidegger.
4 Maggio 2010 alle 2:27 am
Heidegger:”L’interrogare è la pietà del pensare”.Questa espressione non ha nessun senso filosofico.E’ una espressione di speranza religiosa, cioè l’abbandono della filosofia, al solo fine di guadagnare l’applauso degli ascoltatori. Egli farnetica su Dio per la liberazione improvvisa di questa speranza nei disperati.Ma il decostruire e dissolvere ogni contenuto significa distruggere il pensiero.Il pensiero puro, senza contenuto, non esiste. Non Cogito, ergo sum, ma per converso e più ebraicamente Est, ergo cogito – Off line.
4 Maggio 2010 alle 9:59 am
“Il pensiero puro, senza contenuto, non esiste”, interessante affermazione (negazione?). Pare Parmenide, ma forse sbaglio e, giù per li rami, siamo arrivati a Wittgenstein. Se Mara volesse darci qualche lume a proposito…
4 Maggio 2010 alle 1:19 pm
No.Heidegger mi annoia a morte.Ha la sua Foresta Bianca, cioè di libri, veramente tanto da dire?Tutto il suo decostruire e dissolvere non va, in defiunitiva, al di là della lotta contro le creazioni della logica come macchina autoaffermativa e falsificante dell’uomo-animale bisognoso, che fu già di Nietzsche.Cosa si salva? Il limite della “purezza” che è invalicabile.Ma il velo non si lacera, l’occhio non guarda se stesso.Il pensiero è sempre pensiero di qualcosa.Ecco, ora ho proprio voglia di mangiarmi un gelato.A bien tot.
4 Maggio 2010 alle 3:23 pm
Aaah, ecco, il velo. Bella storia quella. Mi ricorda Il Cacciator nel Bosco… Sei avara ma per oggi mi accontento.
5 Maggio 2010 alle 12:16 pm
A Nello (48). Con felice preveggenza mi sono scusata in anticipo della mia presenza saltuaria sul sito! Solo oggi ho visto il tuo intervento e la discussione successiva. … Proprio pensavo a Parmenide quando sono intervenuta, a Parmenide e MYM in parallelo: MYM sostiene da qualche parte, nel suo primo volume sul Mahayana, che l’equivoco inficiante tutto il pensiero occidentale parte proprio da lui, dalla dicotomia “l’essere è, il non essere non è”. Per cui mi sono chiesta che cosa significhi “essere semplicemente lì”, come nella frase di Radcliffe. Conosco sufficientemente Parmenide in quanto studio Greco da, ahimé, oltre …ant’anni: non posso dire lo stesso di Heidegger e Wittggenstein sui quali ho solo il ricordo di un’informazione lontana risalente al liceo. Se però qualcuno se ne è annoiato o li sprezza, sono affari suoi: cioè scelte personali. Così certamente si può dannare Pirandello in quanto sostenitore del fascismo e fans di Mussolini… per quanto, nella sua opera, non ci sia proprio niente che sia pur lontanamente avvicinabile o condizionato da quell’ideologia.
5 Maggio 2010 alle 10:21 pm
Ciao Cristina.
Chiarisco subito che la mia citazione heideggeriana era relativa al tuo uso del termine “dasein” sul quale sono stati scritti fiumi di inchiostro…era una semplice citazione lessicale che ognuno poi ha colorato e colora a seconda del SUO modo di intendere le cose che ovviamente non significa per nulla che le cose stiano nel modo in cui lui/lei le pensa (Nagarjuna docet).
Tu hai capito il senso della mia trascrizione del glossario dal testo in oggetto.
Riguardo il mio intervento sul questo topic, ho contribuito al N°15 e al N°46, e non era rivolto solo a mym ma a tutti ovviamente. Nel mio primo intervento ho sintetizzato perchè, l’essere, non necessita di attribuzioni speciali perchè le contiene tutte, è un intero.
Certo, Parmenide pone una questione forte. Per me, il filosofo contemporaneo che meglio ha sviscerato il positivo e il negativo del pensiero parmenideo e tutto il corollario susseguente nei secoli a lui (e ad altri)riconducibile è Emanuele Severino.
Il confronto, da parte buddhista per quanto mi riguarda, con un Maestro del calibro di Severino, non è bypassabile, nè liquidabile in poche superficiali battute.
D’accordo con te sulla conclusione del tuo intervento…se studio il pensiero di Tanabe Hajime, studio il PENSIERO di Tanabe Hajime, e lo stesso vale per Nishida Kitaro e Nishitani Keiji o Abe Masao, vale a dire la Scuola di Kyoto, le cui teoresi vanno ben oltre le attribuzioni di sostenitrice del regime giapponese ante 1945, tutte da dimostrare…tra l’altro.
Ciao. Nello
5 Maggio 2010 alle 10:58 pm
Per dario (N°50).
Severino più che di logos, parla di epistéme che si certifica attraverso l’elenchos.
Per Severino, la “fede”, più che “follia” è “violenza”, e lo dimostra in modo pressochè incontrovertibile.
Poi, su cosa si intenda per “essere”, si può discutere a lungo…e certo Severino produce una teoretica assolutamente antropocentrica che non condivido ma con la quale non è possibile non confrontarsi.
Tenendo ben presente che quando si parla di Severino, si sta trattando con un titano del pensiero contemporaneo e non solo.
Terrei ben distinto il taoismo dallo zen e soprattutto da Dogen.
Non conosco Fabrizio Turoldo.
Condivido l’ultima citazione di Jiso.
Ciao. Nello
5 Maggio 2010 alle 11:21 pm
Per dhr (N°55).
Da ignorante in materia, quale sarebbe “la cultura ebraica”?
6 Maggio 2010 alle 7:35 am
Semplicemente la presenza ebraica con le sue tradizioni e – soprattutto – la sua “alterità”. Non un insieme di concetti A, B, C.
6 Maggio 2010 alle 10:22 am
Buongiorno a tutti. Per gli amanti del brivido, una lettura che fa volare (chi vola vale, ecc. visto che si rinverdiscono torbide simpatie di aerei filosofi): “Filosofi sovrumani”, di Giorgio Colli, ed Adelphi, in cui il grande, poco più che ventenne, legge i cosiddetti presocratici, Eraclito, Parmenide e c. (ma anche in parte Platone) in chiave “mistica” e non solo politica (alla greca). Tante contrapposizioni pseudo ideologiche (es. Eraclito versus Parmenide) assumono una nuova luce. Gli specialisti sanno già tutto, of course, quindi questa nota è solo per ignoranti, genia cui mi onoro di appartenere. Unum scio… la conoscenza più stimolante è quella della propria ignoranza. Ciao
6 Maggio 2010 alle 11:06 am
Grazie Nello, bisogna riconoscere che i tuoi interventi sono esaurienti. A nudelook: grrrr, vuoi farmi arrabbiare? Se uno conosce, mal per lui, il greco, dovrebbe fingerne l’ignoranza tanto per non apparire consapevole, o superbo, delle sue conoscenze? …le quali, ovviamente, non sono né totali né assolute né indiscutibili. Però non è lecito leggere uno scrittore di tot anni fà appartenente a un ben preciso ambito culturale, inserendolo invece in un sistema di pensiero posteriore magari di millenni e confrontandolo con questo. Omero si spiega attraverso Omero.
6 Maggio 2010 alle 12:29 pm
Non ci penso neanche a volerti fare arrabbiare.
L’ignoranza non si finge, è un patrimonio inalienabile. E c’è anche un ignoranza dei dotti, nel senso che c’è sempre uno spazio non noto anche a chi sa (si era parlato di Wittgestein, mi pare…) Omero si spiega attraverso Omero, a patto di sapere che questo non vuol dire che Omero spiega Omero: se io leggo Omero, fra Omero e la mia lettura c’è tutto quello che ci sta fra Omero e me. E quel che dice oggi Omero, lo dice oggi. O no?
6 Maggio 2010 alle 12:30 pm
PS. Per qualche giorno sono fuori portata computer, se non rispondo a eventuali altre “arrabbiature” non è per spocchia o per fifa, solo per sconnessione…
6 Maggio 2010 alle 12:37 pm
Grazie Nudelook. Parlando di ignoranza, mi piacque ascoltandolo un’espressione di Paolini, sorta di invettiva lanciata ai governanti rapaci e spocchiosi, privi di ogni creanza civile: “mancanza di ignoranza!”.
6 Maggio 2010 alle 2:05 pm
YAAhhhwwwnn..L’errore di fondo che Severino fa da sempre, e che rende le sue tesi insostenibili, è quello di prendere gli oggetti dal divenire negando il divenire. Prendiamo la bellezza. Può venire dall’essere? Ammettiamo pure che in ultima analisi venga dall’essere, attraverso una lunghissima mediazione. Ma in primo luogo essa viene, quando viene (è cosa rara), dal divenire. E dura poco. Come potrebbe essere eterna?
È una creazione del fisico e segue il destino del fisico. Allora, Nello-so-tutto-io quanto è morto un morto? Tranquillo, nessuno ti sopravvaluta. Questa è una domanda a cui si può rispondere solo con la fede. Mi faccio un giro con nudelook. Bye-bye.
6 Maggio 2010 alle 2:35 pm
Parla la Sapienza: “Quando Egli fissava i cieli, io ero là”… semplicemente, I suppose?
(Proverbi 8,27)
6 Maggio 2010 alle 5:42 pm
Bella domanda Dhr. In ogni caso è una bella coppia, Lui che -con aria ieratica?- dà gli ultimi ritocchi al settimo cielo e lei, implacabile, già lì a sindacare.
Per questo l’ottavo giorno creò il divorzio… 😀
6 Maggio 2010 alle 5:48 pm
Mara (70), scusa se mi permetto, però questa cosa di “venire dal divenire” nonècche mi convinca molto.
Quando è morto un morto? Questa la so: già da prima, altrimenti era un vivo.
Mi piace di più questa: che differenza c’è tra un vivo e un morto?
Al primo che risponde esattamente un CD con le conferenze di mym, al secondo due CD, al terzo…
Ah, e poi, per favore, sii gentile con Nello, se non son gentili almeno le signore…
6 Maggio 2010 alle 6:30 pm
>che differenza c’è tra un vivo e un morto?
Che dei vivi bisogna avere paura, non dei morti.
And the winner is.
😛
6 Maggio 2010 alle 6:32 pm
>Bella domanda Dhr. In ogni caso è una bella coppia
Rinvio al racconto “Lilith” di Primo Levi, dove si narra la love story tra l’Altissimo e la demonessa Lilith.
Però non stavano “semplicemente là” con le mani in mano.
6 Maggio 2010 alle 7:29 pm
No no no, quella differenza tra i vivi e i morti, insindacabilmente, non la assevero: aver paura dei vivi è abbastanza comune, quasi come aver paura dei morti, il problema non è questo. Per concludere (?) questa chat ci si aspettava qualcosina… qualcosina di più moscatello, ecco.
6 Maggio 2010 alle 8:49 pm
Persa in un bicchiere di troppo..Il divenire che crea la mia bellezza dopo un po’ la distrugge, inevitabilmente, con la mia morte.Rientro con la morte nel nulla?No, perchè il nulla non esiste.Rientra nell’essere, ma come rimane un mistero.E, se il mio corpo muore, che ne è dello spirito?Quanto si muore quando si muore?”Ehi, I’m showing U the door ‘cause I gotta have faith”. – Non ne posso più.Fate un post ad hoc così mi metto in poltrona con le mie amiche e ci facciamo due risate.Nel frattempo mi incornicio il commento 21 e chi sì è visto, s’è visto -.Au revoir.
6 Maggio 2010 alle 8:59 pm
A nudelook. Arrabbiatissima! No, non proprio, sono d’accordo in linea generale: non si finge l’ignoranza come non si finge la competenza. Non c’e differenza tra chi si vanta dell’una e chi si vanta dell’altra; l’esserne consapevoli, e dichiararlo, non è la stessa cosa! Mi piacerebbe sentire cosa direbbe Omero oggi, non tanto sui suoi argomenti che non hanno più ragione di essere, quanto sui discorsi che si fanno su di lui. Tra me e lui ci sono 2700 anni circa, il mio impegno deve essere quello di leggerlo sforzandomi di vedere una realtà che per lui era chiara in quanto era la “sua” cultura, per me è una faticosa ricostruzione… se voglio provare seriamente a ricostruire e quindi capire.
6 Maggio 2010 alle 9:11 pm
>Per concludere (?) questa chat ci si aspettava qualcosina… qualcosina di più moscatello, ecco.
Eccola: un morto non avrebbe mai postato questa tua richiesta.
6 Maggio 2010 alle 9:47 pm
Giusto. Sai mara,non ci avevo mai pensato.’Quanto’ è morto Gesù?E Buddha?Mah..Cmq anch’io stasera mi sbronzo di brutto e chissenefrega di dio, del demonio e dei sacramenti.Au revoir.
6 Maggio 2010 alle 10:06 pm
Per mara (N°70),
Il “divenire”, non lo nega (giustamente) solo Severino ma il buddhismo stesso.
Non c’è nessuno spazio per il divenire nella realtà.
La legna non diventa cenere, esiste nella sua posizione dharmica (ju hoi) in quanto legna, e la cenere esiste nella sua posizione dharmica in quanto cenere. Vale a dire che non può essere vissuta nel suo tempo precedente o successivo ma solo e sempre come qui ora (nikon). Nikon quale punto zero eterno, perenne, e luogo di convergenza dei tre tempi (kyoryaku) presenti contemporaneamente in questo attimo che si muove (trans-presente).
Alla tua domanda relativa al “morto”, rispondo con un’altra domanda, “morto” rispetto a che cosa?
E ancora riguardo la tua citazione di “fede”, nel buddhismo si riconduce al termine “engi”, di cui ti allego una semplice e sintetica introduzione:
縁 (en/fuchi/yukari) en/yukari = bond, tie, to be linked fuchi = hem, edge, verge
起 (ki/gi/okoru/okiru) to happen, to get up, to start
The original meaning of 縁起(=engi) came from Buddhism and means that not everything in the world has a specific physical or tangible form. Things are composed by various intangible “reasons” and “conditions”.
Infine, non so cosa tu abbia letto e studiato di Severino…il bresciano non è certo un filosofo che si presta a letture troppo tranchant, superficiali e categoriche come fai tu e tanti altri.
Ciao. Nello
6 Maggio 2010 alle 10:09 pm
Scusate mi facevo beffe di mym..Non è gentile correggere una signora specie quando ha ragione.Dunque: ‘Quanto’ è morto(di)Gesù?E(di) Buddha?
6 Maggio 2010 alle 10:21 pm
Per dhr (N°64),
“Tradizioni” riconducibili a che cosa?
Puoi fare qualche esempio?
E ancora, la “alterità” che presuppone quale prospettiva? Poggiante su quale piano?
Com’è la alterità da parte ebraica?
Ed “ebraico” cosa indica?
Mi rendo conto che possa non essere facile dare risposte sintetiche…tuttavia, se si usa il termine “ebraico”, penso debba per forza riferirsi a qualcosa. Cos’è questo “qualcosa”?
Arigato.
Ciao. Nello
6 Maggio 2010 alle 10:41 pm
Ok Nello.SEI decisamente uno sgobbone. – Per la serie Achille e la tartaruga ^^ -.”Nel mondo era, e il mondo fu fatto per lui, e il mondo non lo conobbe”(Giovanni I 10).Kisses from a rose.
7 Maggio 2010 alle 10:33 am
Per toccare ogni filo da voi annodato o sciolto ci vuole tempo e pazienza, oggi difetto un poco. Così riassumo: Mara sei una birichina, quel (77)”rientro/rientra” a che cosa si riferisce, parlando di morte? Nonècche speri di esserci PER DAVVERO? Per questo chiami in causa gli spiriti? Allora meglio la macumba… Nello ne sai una più di… Lilith, però perché tutto quel giapponese? Engi è “solo” la pronuncia giapponese del cinese 緣起, il tentativo di Kumarajiva di tradurre pratityasamutpada, la formula buddista in sanscrito per dire quello che poveramente chiamiamo “divenire”. Infatti è enunciato (anche) nel Discorso della pianticella di riso, che “diviene” pianta di riso. Nagarjuna, sapiente di ciò che conta per l’uomo, ovvero l’altro sesso e la religione, dice (cito a memoria): “Se una cosa sorge in relazione ad un’altra non è uguale ne diversa da quella che l’ha generata”. La ghianda e la quercia, il bambino e l’adulto… e il vivo e il morto? Chiedo a Dhr, su quel che non fanno i morti siamo d’accordo, ma al vivo manca qualche cosa per essere morto? O è al morto che manca qualche cosa per essere vivo?
7 Maggio 2010 alle 11:15 am
Al vivo manca qualcosa per essere morto.
7 Maggio 2010 alle 11:33 am
Sì, qualche… minuto 😉 , ciao, y
7 Maggio 2010 alle 2:40 pm
@mym, commento 85.Se io morissi, il mio spirito morrebbe con me?Sì, se non avessi fede in me;no se invece ne avessi.Oggi non ho proprio tempo per essere concisa devo andare dal parrucchiere.Bacini.
7 Maggio 2010 alle 2:42 pm
Non posso esimermi dal ringraziare Milady per la sua lode al commento 21.Ecco ‘come stanno le cose’:l’anima che va all’inferno vuole restarci.Amen e così sia.
PS – Attenzione a contraddire Milady è molto permalosa e vendicativa.
7 Maggio 2010 alle 2:45 pm
Già,adoro la crudeltà di Milady..ed è pure veloce col pugnale.Scommettiamo, caro Nello, che se te lo infilza in pancia
‘diventi’ morto?Semplicemente perchè il divenire e’.Ovvero, più banalmente, il divenire infinito è il modo in cui si manifesta l’essere.Ti prendi un altro SEI, questa volta in matematica – che regola i rapporti tra noumeni e fenomeni – e, al terzo SEI, finisci dritto dritto all’inferno.Anch’io devo andare dal parrucchiere,allora vi lascio una citazione dotta:”Il riso è l’anima di Dio”(Lisa Simpson – proprio quella dei cartoni).Au revoir
7 Maggio 2010 alle 3:35 pm
Insomma, Mara, hai scelto la macumba, eh? Non so, forse è divertente ma questa volta sorrido allo spirito di Isabela, la citazione è da papessa.
Però, non sfrucugliate Nello, por favor.
7 Maggio 2010 alle 10:15 pm
>62
Su Severino: condivido la evidente difficoltà (anche dei suoi allievi) a confrontarsi con la complessità del “suo” pensiero ma che lui lo ritenga il “La” verità(“Il” logos) su questo non credo ci siano dubbi:
“Se il destino è ciò a cui non si può sfuggire, allora la verità è il senso originario del destino..La verità dice:..nel senso che essa è il mostrarsi, l’apparire della necessità(il logos) in cui il Tutto dimora..il luogo in cui il Tutto sta in accordo e presso il quale si raccoglie: il logos.” (Il senso del destino in ‘Destino della necessità’).
“tanto dire natura autentica niente, quanto dire natura autentica ente entrambi imodi diffamano.”(Bussho)
ciao dario
7 Maggio 2010 alle 11:21 pm
Per mym (N°85),
Sull’asserto di Nagarjuna bisognerebbe sviluppare un dibattito…
Confortato da Dogen, che raccoglie ed evolve il dettato nagarjuniano (lo supera), posso tranquillamente dire che pratityasamutpada (Coproduzione Condizionata od Origine Dipendente)non significa “divenire”.
Dogen, stabilisce che non può esserci divenire nella Via di Buddha, e questa a me interessa.
Il punto è, perchè Dogen (che non contraddice Nagarjuna, ma evolve i suoi postulati circa 1000 anni dopo) non può accettare il divenire?
7 Maggio 2010 alle 11:41 pm
Per mym (N°85),
il termine “engi” l’ho utilizzato in relazione al termine “fede”, questo perchè, nel buddhismo zen, la “fede” è qualcosa indissolubilmente legata a causa-effetto, engi, appunto.
Ovviamente, nell’essere totalmente causa e totalmente effetto, non esiste alcun divenire. Se esistesse “quel” divenire, crollerebbe il buddhismo.
Sandokai e Sekito Kisen docet.
8 Maggio 2010 alle 12:15 am
Per dario (N°92),
Scusa ma non è molto chiaro quello che dici.
Se non ho capito male, secondo te, Severino riterrebbe il “suo” pensiero nientemeno che “La” verità (“Il” logos)?
Se hai dedotto questo leggendolo, hai dedotto male…
La elaborazione teoretica di Severino ha ben altro respiro…
Severino pone delle questioni, apre il dibattito, e l’evidenza delle cose che vengono a mostrarsi, a loro volta lasciano trasparire ciò che non appare…lo sfondo…
Sui termini poi, basta intendersi, il testo che citi tu è del 1979, oggi, mi sembre gli piaccia di più utilizzare il termine “epistéme”, a mio avviso meno ambiguo del termine “logos”.
Non sono un allievo di Severino ma lo stimo moltissimo. I suoi allievi sono tutti eccellenti filosofi, conoscono molto bene la sua teoretica, lo chiamano (giustamente) Maestro.
8 Maggio 2010 alle 12:29 am
Per dario (N°92),
anche la tua citazione da “Bussho”, scollegata dal suo contesto non mi è chiara…
Bussho, la natura-di-buddha, è l’impermanenza (mujo).
La natura-di-buddha-impermanenza, è ovviamente l’integrazione dei due piani di realtà. Quindi, non se ne può affermare uno a discapito dell’altro. I due vivono insieme senza costituire nessun uno. Ovvero,
estinguere il dualismo senza creare alcun monismo.
8 Maggio 2010 alle 10:54 am
Grazie Nello. Se fosse possibile farei volentieri crollare il buddismo. Il divenire non esiste (come il buddismo), parole al vento che prima o poi cancella ogni cosa. Il punto, questa volta, era “essere semplicemente là” (anche “qua”, per i pignoli) e, per allargare il panorama fuori dal chiostro, “monachesimo interiorizzato”.
Un mio amico dice di avere un cane buddista perché ha imparato che cosa vuol dire “Fido molla l’osso!”. L’ambiente si declassa…
11 Maggio 2010 alle 10:42 pm
Per Mauricio (N°97),
ognuno gioca con gli strumenti che ha o che preferisce…Poi si può anche dire che non esiste nessuno strumento e nessun gioco…
Non credo si sia andati fuori tema.
Per me il buddhismo è l’universo…e si può anche dire che non esiste, basta intendersi su quale registro comunicare.
Ripeto, per me, “essere” è esaustivo in se stesso e non necessita di coloriture parrocchiali, poi, ognuno è anche libero di colorarlo come preferisce e io mi prendo la stessa libertà, nè più. nè meno.
Con le parole si rischia sempre di sostanziare, quindi nominalizzare, quindi contraddire, tuttavia, per mezzo di esse può prodursi il dibattito, l’elaborazione. Attraverso questa personale elaborazione, ho cercato di dire che per me, “monachesimo interiorizzato” non significa nulla, lo trovo un termine fuorviante…
Se si cita la dottrina buddhista, o un testo buddhista, le interpretazioni soggettive aprono il dibattito, l’elaborazione…che poi questa sia sterile e non significhi nulla ai fini della esperienza concreta delle cose…apre un altro piano dialettico.
Non ho nessun “osso”, quindi nulla da “mollare”.
Ancora…”l’ambiente”, per me, è l’universo.
Oppure, sono nuovo dell'”ambiente”…
Ma anche, non c’è nessun ambiente che possa declassarsi. Proprio non esiste.
Ciao. Nello
11 Maggio 2010 alle 11:04 pm
Ovviamente, l’essere umano ha le sue contraddizioni, vale a dire che non è detto che affermando l’inesistenza del divenire abbia compreso la responsabilità della concatenazione delle cose.
Ma, se afferma il divenire, è molto più fuorviante.
12 Maggio 2010 alle 2:10 pm
(intervengo solo per far raggiungere la mitica quota 100 a questo thread! era mai successo prima?)
———————————-
100 e non più 100?
mym, in piena invasione di campo 🙁
13 Maggio 2010 alle 10:51 am
Grazie Nello, continuo a non replicare alle tue complesse argomentazioni. È solo perché vedo il commento come un veicolo agile, leggero. La parte “pesante” è già nel post e negli eventuali allegati.
13 Maggio 2010 alle 11:08 am
(al n. 100)
Robb de matt, esalta l’ecologia e poi invade i campi!!
14 Maggio 2010 alle 12:02 am
E’ impossibile non rispondere, anche il silenzio è una replica.
“agile, leggero e pesante”, sono relativi, quindi soggettivi.
Ovvero, quello che è “agile” può dimostrarsi inagile, quanto ritenuto “leggero” può rivelarsi pesante e viceversa.
“Qui ed ora è diverso per ognuno” Taisen Deshimaru Roshi.
14 Maggio 2010 alle 12:06 am
Per Isabela,
non temo Milady…che non conosco…ma se anche mi infilzasse, quando sono vivo, sono completamente vivo, quando sono morto, sono completamente morto.
Come puoi facilmente vedere, c’è solo l'”essere”, l’uno o l’altro, e nessun “divenire”.
Bacioni.
14 Maggio 2010 alle 11:34 am
Grazie Nello, sei un tornado (nel senso di hurricane)… A proposito del qui ed ora in effetti Deshimaru ha ragione: a parte latitudine e longitudine, nel definire il qui anche i metri quadri andrebbero stabiliti con cura. Per quanto riguarda l’ora poi non ne parliamo nemmeno, è un bailamme incredibile. Chissà se qualcuno conosce e ricorda Il difficile ritorno del signor Carmody: quando fantascienza faceva rima con intelligenza.
14 Maggio 2010 alle 3:05 pm
>quando fantascienza faceva rima con intelligenza
la fa ancora…
14 Maggio 2010 alle 5:11 pm
La fa ancora??? Non sul mio tappeto, per favore!
14 Maggio 2010 alle 8:29 pm
tanto che importa? i Centri sono chiusi, nessuno ha più bisogno di tappeti per fare sesshin
😛 😛 😛 😛 😛